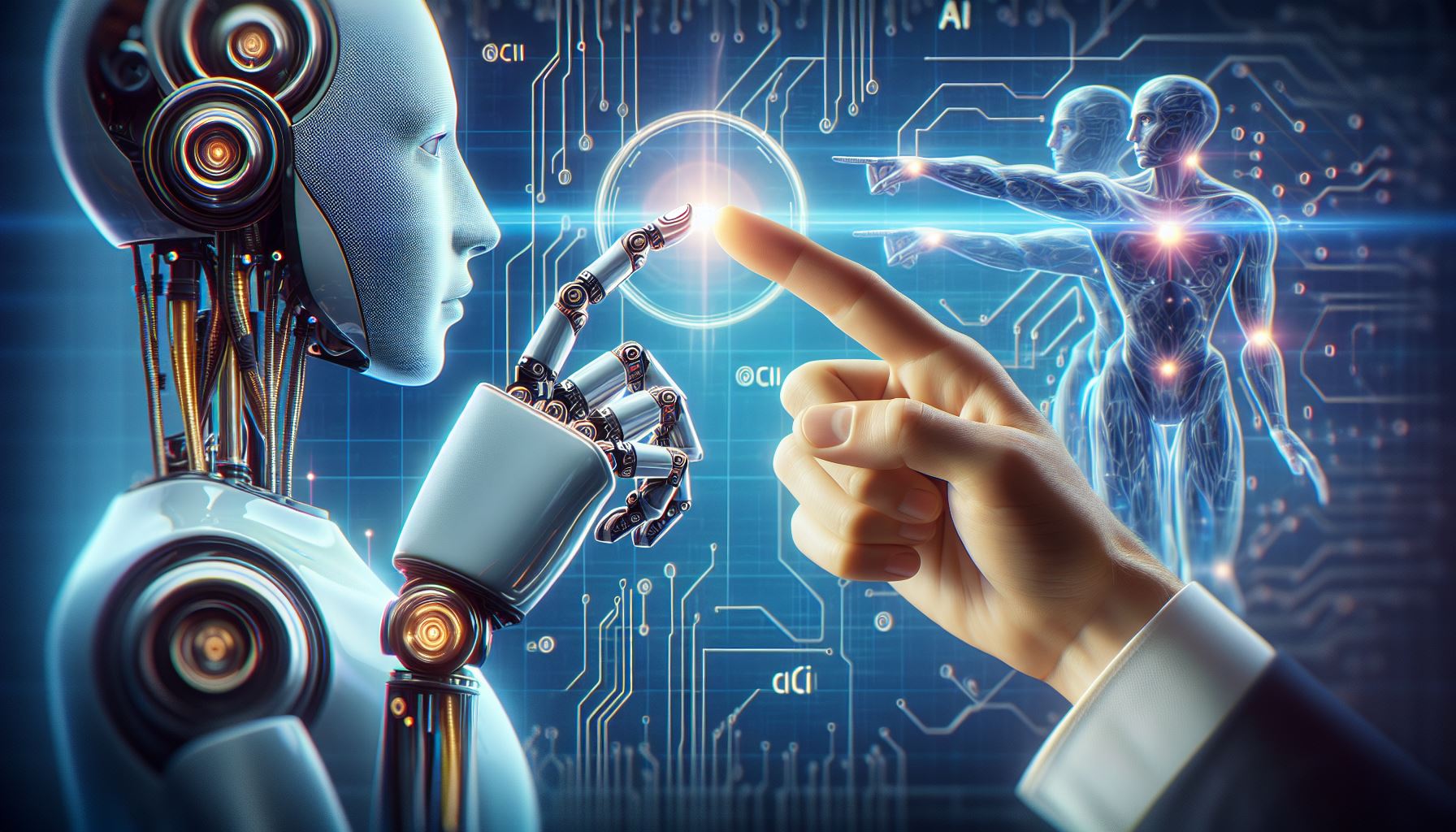L’analisi dell’impatto delle tecnologie dell’informazione sul concetto politico di identità e le conseguenze della trasformazione dell’individuo da “chi” a “cosa” è il tema affrontato dal volume “Lost in the Shell. Mind, body, identity and the the technology of information”, a firma di Andrea Monti, docente di identità digitale, privacy e cybersecurity nell’università di Roma-Sapienza, ed edito da Routledge Books. Ne pubblichiamo un estratto
Lost in the Shell analizza l’impatto delle tecnologie dell’informazione sul concetto politico di identità e le conseguenze della trasformazione dell’individuo da “chi” a “cosa” o, in altri termini, della concezione del corpo come un bene disponibile, sul quale chi lo “abita” —la persona— ma anche chi lo governa —lo Stato— rivendicano il potere di farne ciò che vogliono. Fra i fattori che hanno reso possibile questo dualismo politico uno dei più rilevanti è la normalizzazione giuridica delle istanze sociologiche e psicologiche risalenti agli anni 80 che, basandosi sul concetto di “cyberspazio” e “virtualità” hanno posto le basi per la rottura politica e poi giuridica fra soggetto, identità e persona.
Fra le varie conseguenze di questo fenomeno, c’è non solo la rivendicazione al diritto al controllo assoluto sul “simulacro” biologico, ma anche la pretesa di crearne di altri da usare come magazzino di pezzi di ricambio. Questo pone un tema di biopolitica tanto cruciale quanto trascurato nel dibattito pubblico occidentale, a fronte dei progressi che altri Paesi, come la Cina, stanno facendo, per esempio, nelle tecnologie dell’editing genetico.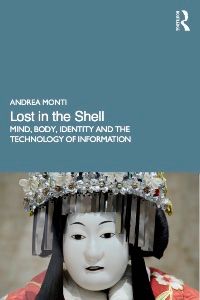
Per quanto sgradevole e inaccettabile sia questa considerazione, non possiamo ignorare che il tema politico è capire dove poniamo il limite al controllo sul corpo, in nome di quali principi lo facciamo ma, soprattutto, a chi lo affidiamo.
Il quinto capitolo del libro affronta questi temi.
5 – Vita venduta a pezzi
Replicare le funzioni cognitive dell’essere umano e costruire meccanismi che ne riproducono l’aspetto e l’operatività non sono gli unici obiettivi degli svariati ambiti di ricerca che convergono sulla costruzione di un simulacro dell’uomo. Gli stessi studi, infatti, hanno un notevole e diretto impatto sul corpo umano, sulla persona e dunque sull’identità, nel momento in cui si affiancano allo sviluppo di componenti —protesi destinate a essere impiantate sul corpo umano e organi da trapiantare al suo interno.
Si è detto che i ragionamenti sulla vitalità di macchine e software dovrebbero rimanere confinati nell’empireo delle speculazioni astratte, mentre questioni come i danni derivanti dall’interazione con un chatbot o causati dal malfunzionamento di un robot (cioè, malfunzionamenti di software e hardware) troverebbero migliore collocazione nel meno affascinante, ma più coerente, perimetro della responsabilità per la costruzione di prodotti pericolosi.
Questa considerazione, che fatica ad essere accettata in relazione all’AI e alla sua installazione in macchine di vario tipo, genera meno resistenze concettuali nel caso dei “pezzi di ricambio” del corpo umano. Tuttavia, oltre al tema della responsabilità da prodotto, gli avanzamenti tecnologici nella protesica, nei trapianti e nella costruzione di organi artificiali biologici e non, pongono dei problemi estremamente concreti che riguardano soprattutto il rapporto fra identità biologica e identità personale in senso normativo.
Un percorso concettuale per un’analisi giuridica su questi temi, dunque, deve necessariamente tenere conto del modo in cui si sono sviluppate le tecnologie che potremmo chiamare “riparative” per evitare, anche in questo caso, di soccombere alle suggestioni di una narrativa più fantasiosa che concreta.
A differenza della clonazione genetica umana, regolata —vietata— avendo in mente la tutela della dignità umana, la creazione di componenti artificiali (biologiche, meccaniche o ibride) non vive ma attive e —in certi casi— autonome, non è facilmente comprensibile applicando queste logiche normative.
Queste entità non rientrano nella portata semantica dei divieti esistenti, proprio perché non presentano le caratteristiche della categoria giuridica di “essere umano”. Non nascono, perché vengono costruite. Non muoiono, perché —per alcuni— non sono mai state vive. E se, come nel caso dei bodyoid, sono vive, per negare loro lo status giuridico di persona basta associarlo, normativamente, al non-possesso delle funzioni cognitive.
Un diritto della persona costruito sulla genesi naturale della vita sembra avere difficoltà nel classificare in modo univoco ciò che genesi naturale non ha.
Alla base di queste difficoltà risiede una contraddizione normativa sullo statuto giuridico di parti o di entità biologiche che sono strutturalmente umane nella forma, e che però si vorrebbero giuridicamente ridotte a cose – mercificate, assemblate, raccolte.
Invocare la loro natura non senziente e imbarcarsi in un esercizio da sofista creando, fra la vita e la morte, uno stato intermedio di non-vita (o di non-morte) per giustificare l’esistenza di organi e corpi biologici ma artificiali pone i legislatori, e prima ancora, le società che li esprimono, di fronte alla necessità di compiere una scelta di fondo: smettere (soltanto) di chiederci se sia accettabile replicare un essere umano, ma domandarsi anche se sia lecito fabbricare un corpo umano “funzionante” al quale negare, giuridicamente, la condizione di vivente per smontarne parti da rivendere.
È chiaro che l’architettura normativa costruita per il dibattito sulla clonazione è inadeguata per affrontare questi nuovi costrutti. I bodyoid, per loro stessa natura, sono una finzione giuridica nel senso più letterale del termine: indistinguibili da un essere umano, ma privati dello status di persona.
Dunque, il luogo della contesa giuridica non è più il confine tra terapia e potenziamento, né il dualismo tra natura e artificio. È la soglia tra soggetto e oggetto, presenza e simulazione, vita e prodotto.
Non si tratta più di proteggere l’essere umano dalla replica. Si tratta di decidere se e quando, la replica cessa di avere status giuridico e quando le regole giuridiche, non riuscendo a rispondere alla domanda, cessano di essere applicabili.
L’incapacità di compiere una riflessione politica, e di conseguenza, giuridica sulle questioni aperte da quella che potremmo chiamare “non-vita artificiale” è una confessione di fallimento di un pensiero giuridico ipnotizzato dalle sirene della scienza o accecato dall’incapacità di comprenderla. Eppure, come ha dimostrato questo capitolo, le conseguenze materiali di questo silenzio si stanno già manifestando, non in un futuro ipotetico, ma nel presente tecnologico.
La questione, ora, non è più cosa può fare la legge con queste entità, ma se il diritto, e prima ancora la politica, sono ancora in grado di assumersi la responsabilità di ciò che viene fatto in loro nome.