L’esperienza va valorizzata e messa a disposizione della società civile, è il senso della prosecuzione come scrittore della lunga e prestigiosa carriera investigativa del Generale dei Carabinieri Giuseppe Governale, già comandante del Ros e direttore della Dia. Stile narrativo immediato e metodo saggistico, in primo piano nei primi tre libri dell’alto ufficiale i retroscena e le tematiche della lotta alla mafia. La recensione di Gianfranco D’Anna
Onestà intellettuale e dedizione, visione e impegno civile. Oppure l’insieme di tutte queste doti più la capacità di analisi, l’incidenza operativa e la valorizzazione e divulgazione esemplare delle proprie esperienze professionali.
Fra i molti modi di esercitare le pubbliche funzioni di Civil Servant, di servitore delle istituzioni, da Generale e gentiluomo, Giuseppe Governale non solo si è sempre istintivamente immedesimato in ruoli da protagonista ai vertici operativi dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione investigativa antimafia, ma con una non comune attitudine culturale riesce a sublimare conoscenze, competenze e capacità di scandagliare la realtà, in preziose analisi giudiziarie, saggi e libri storiografici.
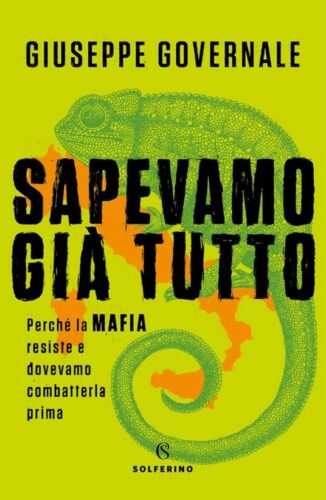 Sul filo di una scrittura immediata, nel 2021 nasce così “Sapevamo già tutto. Perché la mafia resiste e dovevamo combatterla prima”. Un libro che è un pugno allo stomaco di un’Italia che, nonostante i rapporti del Questore di Palermo Ermanno Sangiorgi di fine Ottocento e quello degli anni Settanta del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ha atteso la metà degli anni 80, con Falcone e Borsellino, il maxi processo e poi la tragica stagione delle stragi, per contrastare realmente Cosa nostra.
Sul filo di una scrittura immediata, nel 2021 nasce così “Sapevamo già tutto. Perché la mafia resiste e dovevamo combatterla prima”. Un libro che è un pugno allo stomaco di un’Italia che, nonostante i rapporti del Questore di Palermo Ermanno Sangiorgi di fine Ottocento e quello degli anni Settanta del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ha atteso la metà degli anni 80, con Falcone e Borsellino, il maxi processo e poi la tragica stagione delle stragi, per contrastare realmente Cosa nostra.
Ancora più impegnativo “Gli sbirri di Sciascia. Investigatori e letteratura, tra arbitrio e giustizia” del 2024, nel quale il Generale Governale, siciliano di Palermo, ripercorre i temi della verità e della giustizia, e in particolare dell’amministrazione della giustizia confrontandosi con Leonardo Sciascia, siciliano di Racalmuto, latitudine Agrigentina.
“Tutto è legato al problema della giustizia: in cui si involge quello della libertà, della dignità umana, del rispetto tra uomo e uomo”, scriveva Sciascia. E il generale viviseziona nei romanzi dello scrittore di “Todo Modo”, come può leggerli soltanto chi sa per mestiere che la giustizia può essere strazio o riscatto, i conflitti tra istituzioni e società, tra leggi e criminalità, mettendo in risalto le tensioni morali e le contraddizioni che animano l’azione e la vita degli investigatori.
A cominciare dal protagonista del “Giorno della Civetta”, il Capitano Bellodi, del quale attraverso gli archivi del Comando generale dell’Arma, Governale conferma l’identificazione di Sciascia nel Maggiore dei Carabinieri in servizio ad Agrigento negli anni Cinquanta Renato Candida.
Chiude la serie, intuitivamente destinata ad ulteriori pubblicazioni, “Radici di mafia. Dai bravi manzoniani ai picciotti dei Florio”, dell’ottobre 2025, che affronta col taglio del saggio storico letterario ed un sottofondo lirico e sinfonico, la disamina della genesi della mafia, in parte storicamente connaturata all’hispanidad che ha attraversato la Lombardia e la Sicilia.
Un’analisi che scaturisce dalla constatazione di come le primordiali manifestazioni di criminalità mafiosa emerse nel seicento nella Lombardia dominata dagli spagnoli vennero sdradicate, nel settecento, dalle successive riforme di Maria Teresa d’Austria, mentre in Sicilia nel vuoto delle istituzioni la mafia non la fermò più nessuno.
Di inedito rilievo è il raffronto dei destini femminili fra il personaggio letterario di Lucia Mondella dei Promessi Sposi, rapita dai “bravi” protomafiosi, e la giovane Franca Viola di Alcamo che nel 1965 venne realmente sequestrata da un rampollo mafioso per costringerla a sposarlo. Coraggiosamente, l’allora 17enne ragazza rifiutò invece di farlo, avviando un’autentica rivoluzione culturale contro la mafia.
Che tuttavia non venne colta e sviluppata in tutta la sua dirompente potenzialità. Così come non vennero mai sviluppate le dettagliate denunce dei rapporti del 1840 di Pietro Callà Ulloa Procuratore a Trapani durante il Regno di Napoli, del 1876 di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino e nel 1900 del Questore palermitano Sangiorgi durante il Regno d’Italia ed infine nel 1973 la testimonianza fiume di Leonardo Vitale.
Una trilogia antimafia di grande spessore culturale e storiografico quella del Generale Giuseppe Governale, col retrogusto amaro delle tante, troppe, occasioni mancate per la Sicilia e i siciliani che, si spera, rappresentino altrettante consapevolezze di irripetibilità.








