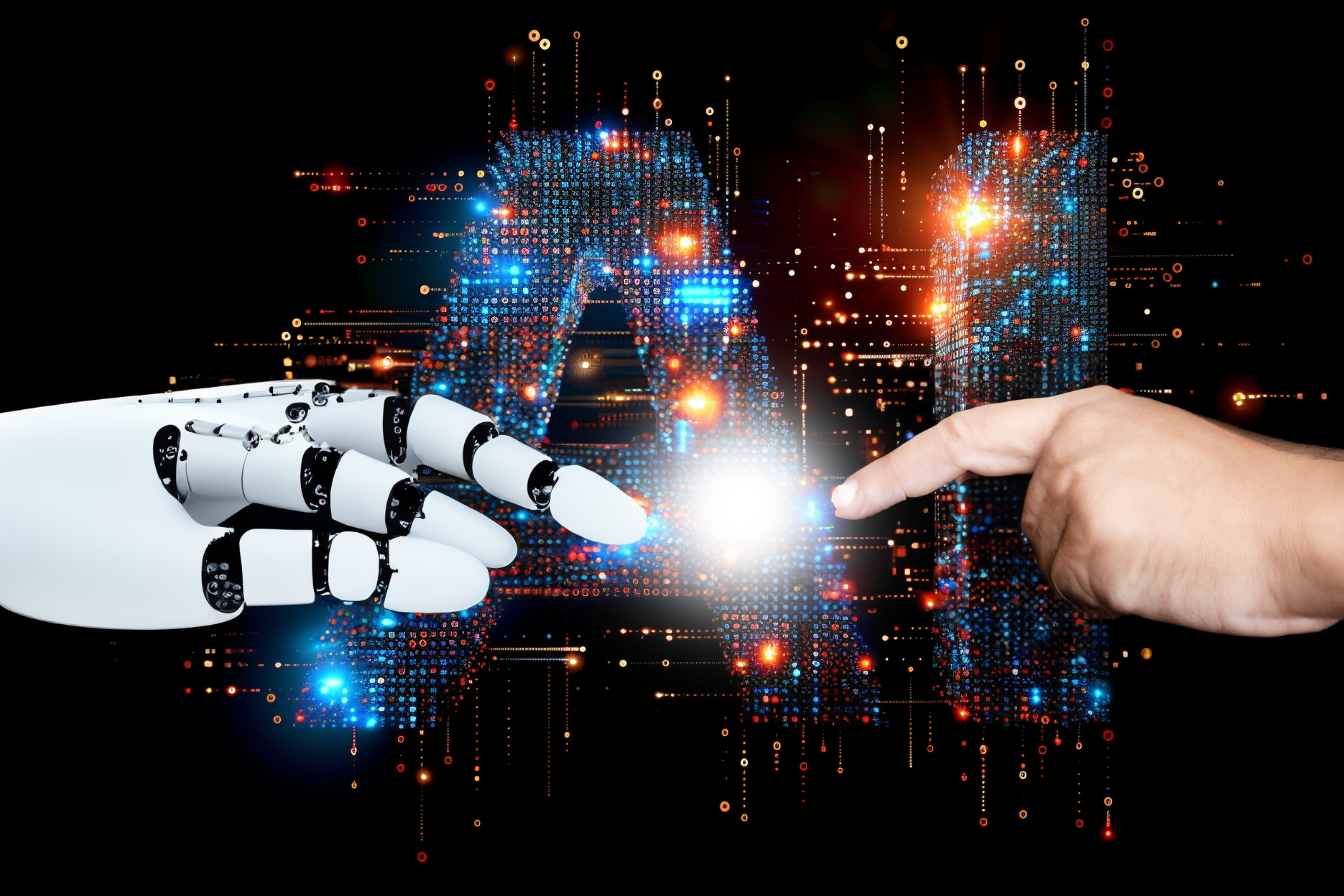Dalla sfida di AlphaGo alla strategia cinese sull’IA, fino al piano americano di Trump: l’intelligenza artificiale è il nuovo campo su cui si gioca la leadership globale. Pubblichiamo un estratto del libro “Intelligenza artificiale e competitività – Guida operativa per le imprese” di Stefano da Empoli e Luca Gatto (Egea, 2025)
L’IA nel decennio scorso era un campo che vedeva un chiaro leader tecnologico, gli Usa, grazie in particolare a un’azienda, Google. Al tempo, il ruolo dei governi sembrava limitato sia sotto il profilo della regolamentazione che delle politiche industriali per lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie. Poi tutto mutò, proprio a partire da una delle imprese di cui abbiamo parlato, la clamorosa spedizione di Google e della sua DeepMind in terra asiatica per sfidare i campioni assoluti di Go. Si deve aggiungere che l’azienda di Mountain View aveva un conto in sospeso con la Cina, dove nonostante le grandi ambizioni iniziali era stata costretta a fare le valigie in fretta e in furia nel 2010 dopo i contrasti con la dirigenza del partito comunista cinese, protagonista di ingerenze e di vero e proprio spionaggio ai danni del colosso americano e dei suoi manager di stanza a Pechino. Unendo i propri primati nell’IA con l’estrema popolarità di Go, Google decise che era arrivato il momento per provare a rientrare in Cina, al tempo di gran lunga il mercato digitale a maggiore crescita del mondo.
La strategia di marketing via Go era talmente prioritaria che l’amministratore delegato in persona, Sundar Pichai, si sentì in dovere di recarsi in Cina ben tre volte in pochi mesi per gettare le basi del match che avrebbe visto AlphaGo sfidare il diciannovenne Ke Jie, nel frattempo diventato il campione in carica del gioco. Si arrivò dunque al 23 maggio del 2017, quando si disputò il primo dei tre incontri a Wuzhen, antica e suggestiva città costruita sull’acqua a sud di Shanghai. Dopo il primo incontro, vinto da AlphaGo, Eric Schmidt, l’allora presidente esecutivo di Google, prese trionfalmente la parola per spiegare alle aziende cinesi presenti le virtù delle tecnologie prodotte in California. In particolare, avendo imparato la lezione e riponendo dunque nel cassetto ogni velleità di tornare sul mercato consumer e puntando invece a quello business, in teoria meno esposto a possibili controversie legate a libertà di parola e diritti umani, si concentrò sulle virtù del proprio software TensorFlow, che avrebbe consentito alle aziende cinesi di primeggiare tecnologicamente, in particolare nel DL.
Non aveva però fatto i conti con l’orgoglio cinese, al tempo meno evidente a chi non avesse una particolare conoscenza della civiltà cinese di quanto non lo sia oggi. Il tono sussiegoso, che escludeva la possibilità che le principali aziende cinesi potessero prodursi l’IA in casa e implicava dunque che dovessero essere costrette a bussare alla porta di Google, unita alla cocente umiliazione per la sconfitta del campione cinese, perdente in tutti e tre gli incontri, rappresentarono un boomerang clamoroso. Che da un lato, a livello aziendale, spinse su un binario morto (ancor prima di essere varato) il Google AI China Center, che sarebbe stato aperto nei mesi successivi. Dall’altro, su un piano decisamente più macro, determinò in Cina quello che venne definito dagli stessi esperti cinesi uno «Sputnik moment», cioè uno stato di panico misto a umiliazione analogo a quello che produsse negli Stati Uniti alla fine degli anni Cinquanta il lancio in orbita del primo satellite a opera dei sovietici, calamitando una pronta reazione nazionale che portò in poco tempo alla nascita della Nasa e successivamente al programma Apollo e che ebbe il suo culmine alla fine del decennio successivo con la prima missione umana sulla Luna.
Fatto sta che, appena due mesi dopo gli incontri, il Consiglio di Stato cinese approvò la strategia IA nazionale che si poneva l’ambizioso obiettivo di superare gli Usa diventando il Paese leader nel mondo entro il 2030. A rendere più concreta la reazione cinese ci pensò, poco dopo il match, Baidu, la principale Internet company cinese con Alibaba e Tencent, che annunciò l’ingresso come direttore generale di Qi Lu, uno degli scienziati di maggior valore della divisione ricerca di Microsoft, nato in Cina ma emigrato giovanissimo negli Usa, a cui venne assegnato come principale obiettivo, grazie anche alla versione del TensorFlow, chiamata PaddlePaddle, che Baidu aveva già pronta in casa, il lancio cinese dell’auto a guida autonoma, da realizzare possibilmente prima che i competitor statunitensi, a cominciare da Google, potessero fare altrettanto negli USA. In questo modo, fu subito chiaro lo straordinario mix di programmazione dall’alto e di dinamismo dei colossi tecnologici cinesi ma anche di nuovo entranti, come DeepSeek e tanti altri emersi nel frattempo nel campo della GenAI.
Nonostante il passo falso diplomatico di Go (a fronte del notevole successo tecnologico), gli Stati Uniti continuano al momento a primeggiare, grazie alla forza delle proprie imprese e del sistema finanziario e universitario sottostante. Una leadership che parte da una quantità enorme di capitali impegnati, peraltro in continuo aumento. Con DeepSeek e il rilascio successivo di altri modelli da parte sia di aziende consolidate che di altre startup, la Cina ha però dimostrato di saper fare molto con poco. Se infatti nel 2024 gli Usa hanno rilasciato 40 modelli giudicati notevoli dal rapporto che rilascia annualmente l’Università di Stanford, la Cina ne ha sfornati 15 con l’Europa crollata a 3, tutti peraltro ascrivibili a Mistral AI, apparentemente l’unico player Ue ancora in gara. Se poi si mette a confronto la performance dei migliori modelli americani con quelli cinesi ci si accorge che la differenza si è ridotta nel corso del 2024 a un margine sottilissimo. Merito anche della capacità cinese, e in particolare di DeepSeek, di efficientare al massimo addestramento e inferenza, minimizzandone i costi a quasi parità di prestazioni. Tra l’altro unendo questa caratteristica con quella di rilasciare modelli open weight, DeepSeek sta facendo fare il salto di qualità alla Cina anche nell’adozione dell’IA, quantomeno di quella generativa.
In questa ottica, il Piano d’azione IA, lanciato dagli Usa nel luglio del 2025, è stato da un lato una reazione all’avanzata cinese, dall’altro una mossa coerente con la politica commerciale aggressiva dell’amministrazione Trump. Già in premessa è enunciata la mission, cioè ottenere «il predominio mondiale» nella tecnologia più trasformativa dell’attuale fase storica. Il Piano, che contiene 103 raccomandazioni specifiche, è accompagnato da tre ordini esecutivi, rispettivamente su «Promuovere l’export dello stack tecnologico IA americano», «Accelerare il processo autorizzativo delle infrastrutture relative ai data center» e «Prevenire l’IA woke nel governo federale». Il fatto che a intestarsi il Piano non siano solo Michael J. Kratsios, assistente del presidente per la scienza e la tecnologia, e David O. Sacks, il consigliere speciale per l’IA e le criptovalute, ma anche Marco Rubio, nella sua funzione di consigliere per la sicurezza nazionale, la dice lunga su quanto sia rilevante la dimensione che la sicurezza nazionale ha assunto nella discussione pubblica sull’IA e che è chiaramente alla base a questo punto sia della strategia cinese che di quella americana. Gran parte dei rischi evocati nelle ventitré pagine si riferiscono infatti alla sfera della sicurezza e della difesa e fin dalle prime frasi è evocata sullo sfondo la competizione tecnologica con la Cina. Che va infatti marcata a uomo, incoraggiando lo sviluppo di modelli statunitensi open source e open weight. Detto fatto perché, a pochi giorni di distanza, è arrivata la notizia che OpenAI sarebbe tornata a rilasciare, dopo ben sei anni e facendo onore al proprio nome, modelli aperti (gpt-oss-120b e gpt-oss-20b, il primo con prestazioni quasi equivalenti al modello o4 mini, il secondo a o3 mini). Un annuncio seguito a ruota da xAI di Elon Musk.
D’altronde, il piano Usa sembra esprimere appieno la visione geopolitica dell’amministrazione Trump. Gli avversari (leggi soprattutto la superpotenza asiatica) vanno contenuti e contrastati il più possibile, dai consessi multilaterali fino a nuove e più rigorose forme di controllo alle esportazioni. Gli alleati, invece, non solo possono ma devono essere spinti a comprare la tecnologia americana, diventando (o rimanendo) clientes dell’intera catena del valore dell’IA statunitense, dall’hardware al software, dai semiconduttori (rigorosamente prodotti negli Usa, beninteso) e data center ai modelli IA di frontiera.
Senza mai citare l’AI Act (anche perché il piano non sembra scommettere su un ruolo nella partita dell’Europa, se non al più come alleata-vassalla della potenza egemone), è però significativo che il documento licenziato dall’amministrazione Trump si apra, quasi a mo’ di contrappasso dell’approccio Ue, invocando interventi di semplificazione della regolamentazione che anche solo indirettamente potrebbe limitare l’innovazione nel settore.
Il Piano IA di Trump suona la sveglia non solo per gli Stati Uniti ma anche, e per certi versi soprattutto, per chi come l’Europa li ha inseguiti in questi anni senza mai riuscire ad accorciare le distanze. Il cambio di passo che il Piano per l’IA invoca per gli Usa, per allontanare l’inseguitore cinese, impone anche da questa parte dell’Atlantico una rapida riconsiderazione delle priorità.
In effetti, nel suo discorso all’AI Action Summit di Parigi dell’11 febbraio 2025, che in qualche modo ha fatto da anteprima al Piano Ue presentato due mesi dopo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato, riferendosi all’IA, che «troppo spesso ho sentito dire che l’Europa è in ritardo nella corsa, mentre Stati Uniti e Cina sono già in vantaggio. Non sono d’accordo. Perché la corsa all’IA è tutt’altro che finita. La verità è che siamo solo all’inizio. La frontiera si sposta continuamente. E la leadership globale è ancora tutta da conquistare. E dietro la frontiera c’è l’intero mondo dell’adozione dell’IA. L’IA ha appena iniziato a essere adottata nei settori chiave della nostra economia e per affrontare le sfide cruciali del nostro tempo. Ed è su questo che l’Europa dovrebbe concentrarsi: portare l’IA nelle applicazioni specifiche dell’industria e sfruttarne il potenziale per la produttività e per le persone. È qui che l’Europa può davvero guidare la corsa».
Nelle affermazioni di von der Leyen c’è della verità. Come dimostrano le continue sorprese che riserva il settore, tra annunci di investimenti di decine e talvolta centinaia di miliardi di euro e la comparsa improvvisa di modelli e applicazioni sconosciute o quasi fino a pochi giorni che diventano di uso comune nel giro di pochi giorni o settimane, la sensazione è che la corsa sia tutt’altro che finita e certamente quello delle applicazioni verticali, ben delineato dallo stesso rapporto Draghi, è un versante sul quale l’Europa ha ancora molte carte da giocare. Tuttavia, non può essere sottaciuto che la gara sia già partita da tempo e, nonostante le enormi capacità finanziarie e umane di cui potenzialmente dispone (ma che di fatto trasferisce in parte ai propri partner-concorrenti, a partire dagli Usa), l’Ue sia in questo momento decisamente indietro rispetto a Stati Uniti e Cina. Questo dato piuttosto incontrovertibile non deve però farci cadere nella rassegnazione e, dunque, in questo senso fa bene la presidente della Commissione europea a mostrare ottimismo sulle sorti ancora incerte della corsa. Purché dalle intenzioni si passi con molta più decisione e vigore che in passato ai fatti. Affiancando al filone regolamentare, sfociato nell’AI Act, finalmente su un piano di parità effettiva, una politica industriale ambiziosa ed efficace, che con il supporto e in coordinamento con gli Stati membri, consenta all’Europa di raggiungere quegli obiettivi evocati dalla presidente della Commissione europea nel suo discorso di Parigi. Per farlo, occorre però uno scatto in avanti che consenta di attuare nei tempi più rapidi possibili gli obiettivi e le azioni evocati nell’AI Continent Plan.
Il piano si basa su cinque pilastri: la capacità computazionale, i dati, le applicazioni settoriali, i talenti e le competenze e, infine, la semplificazione degli adempimenti previsti dall’AI Act. Il primo filone è sicuramente quello dove più e meglio si è fatto negli anni scorsi, grazie prima all’iniziativa congiunta EuroHPC cofinanziata da Commissione europea e Stati membri e poi all’AI Innovation package lanciato nel gennaio 2024 con l’idea di creare capacità computazionale specializzata nell’IA con le cosiddette AI factory. Ora, come anticipato da Ursula von der Leyen nel suo intervento all’AI Action Summit di Parigi dello scorso febbraio, l’Ue rilancia il concetto con le gigafactory, ciascuna delle quali sarà dotata di almeno 100 mila processori di ultima generazione. Per finanziarle si punta a mobilitare attraverso il neocostituito InvestAI 20 miliardi di euro tra finanziamenti pubblici (europei e nazionali) e privati. A confronto, gli altri filoni offrono maggiori novità ma anche più incertezze. Sui dati si evoca una nuova strategia ma il fatto è che quella lanciata nel febbraio 2020 dalla prima Commissione von der Leyen è in larga parte fallita, se non per le molte centinaia di pagine di nuova regolazione prodotte. Si puntava a creare un sistema infrastrutturale prevalentemente europeo nonché una condivisione dei dati su larga scala in tutti i principali settori dell’economia. Non solo gli obiettivi non sono stati raggiunti ma siamo più distanti che mai.
Se sulle applicazioni dell’IA si rimanda alla successiva strategia AI Apply, su talenti e competenze da sottolineare l’atteggiamento più aggressivo nell’attrazione di talenti non europei, con l’istituzione di un programma di fellowship, tra le varie misure previste. Probabilmente, con la non troppo velata speranza che le politiche repressive di Trump verso le università americane e i visti rilasciati agli stranieri potrebbero spingere un certo numero di europei (e non solo) a fare ritorno nel vecchio continente (e tanti altri con la valigia in mano a non varcare l’Atlantico).
Come spesso accade con obiettivi e documenti strategici provenienti da Bruxelles, non sappiamo quanto di aspirazionale e quanto di concreto ed effettivamente realizzabile sia contenuto nel piano AI Continent. Certamente preoccupano due elementi. In primo luogo, la mancanza di qualsiasi elemento auto-critico su cosa e soprattutto perché non abbia funzionato finora, visto che siamo ormai a sette anni dalla prima strategia Ue e dal seguente piano coordinato e dunque un bilancio sarebbe possibile farlo. Ma impensierisce ancora di più che nel piano d’azione non sia previsto alcun meccanismo di governance per verificare che si stia procedendo nella direzione e alla velocità giusta e, allo stesso tempo, per coordinarlo con piani e strategie nazionali (forse la défaillance principale che ha determinato il fallimento del piano coordinato del 2018).