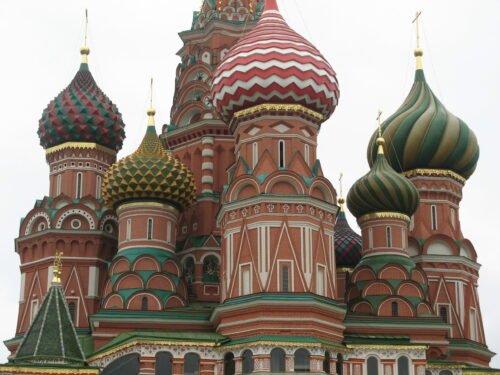In questa intervista, Mohammed Soliman riflette sui grandi assi di trasformazione che stanno ridefinendo l’ordine geopolitico tra Stati Uniti, West Asia ed Europa. Lo studioso del Mei presenta le tesi centrali del suo nuovo libro West Asia: A New American Grand Strategy in the Middle East, proponendo il superamento del concetto di “Medio Oriente” a favore di una lettura sistemica dell’Asia Occidentale. Dalla geopolitica dell’AI ai corridoi strategici, Soliman delinea una nuova architettura di ordine regionale fondata su potenze medie, connettività e competizione tecnologica
 Dal superamento del concetto tradizionale di “Medio Oriente” al passaggio dal nation-building all’order-building, dall’ascesa dell’AI come nuova infrastruttura strategica alla competizione sui minerali critici, fino al ruolo dei corridoi geoeconomici e delle coalizioni flessibili, Mohammed Soliman propone nel suo nuovo libro – “West Asia: A New American Grand Strategy in the Middle East” (Polity Press) – un’analisi sistemica di uno spazio sempre più interconnesso, nel quale il Golfo emerge come nuovo centro di gravità e l’Europa è chiamata a ripensare profondamente il proprio posizionamento.
Dal superamento del concetto tradizionale di “Medio Oriente” al passaggio dal nation-building all’order-building, dall’ascesa dell’AI come nuova infrastruttura strategica alla competizione sui minerali critici, fino al ruolo dei corridoi geoeconomici e delle coalizioni flessibili, Mohammed Soliman propone nel suo nuovo libro – “West Asia: A New American Grand Strategy in the Middle East” (Polity Press) – un’analisi sistemica di uno spazio sempre più interconnesso, nel quale il Golfo emerge come nuovo centro di gravità e l’Europa è chiamata a ripensare profondamente il proprio posizionamento.
Soliman è senior fellow presso il Middle East Institute (MEI), dove si occupa dell’intersezione tra tecnologia, geopolitica e business in Medio Oriente e in altri mercati emergenti. Ingegnere di formazione, è director presso McLarty Associates, dove fornisce consulenza strategica su temi che intrecciano tecnologia, AI, finanza ed energia. È inoltre non-resident senior fellow del Foreign Policy Research Institute e visiting fellow presso il programma di Sicurezza Nazionale di Third Way. Formiche.net lo ha raggiunto per un’intervista su diversi dossier aperti, la cui evoluzione interessa direttamente anche la proiezione internazionale dell’Italia.
Nel libro lei sostiene la necessità di superare il termine Medio Oriente a favore di Asia Occidentale, non solo come correzione geografica ma come vero cambio di paradigma strategico. In termini concreti, qual è l’errore più grave che Washington continua a commettere finché resta intrappolata nella vecchia mappa mentale del Medio Oriente?
Il libro non cerca di aprire una polemica terminologica. Il suo obiettivo è molto più semplice: mostrare che la vecchia idea di “Medio Oriente” non esiste più. Punto. Non esiste un vero confine che separi il Medio Oriente dall’Asia meridionale o dal mondo mediterraneo. Quello che osserviamo oggi è uno spazio unico e interconnesso, legato da geopolitica, sicurezza, commercio, infrastrutture per l’AI e movimenti di persone.
E questa non è un’idea nuova. È sempre stato così prima dell’egemonia europea. Personalmente vedo il concetto di Asia Occidentale come un contributo modesto alla tradizione delineata da Janet Abu-Lughod in “Before European Hegemony”.
La differenza sta nel momento storico. Nel 2026 non stiamo davvero tornando a prima dell’egemonia europea, ma piuttosto vivendo il dopo egemonia europea. E ciò che sta emergendo è un nuovo centro di gravità del sistema, con il Golfo al suo centro.
Questo ha un’enorme importanza per i decisori politici americani, che restano i principali architetti di ciò che rimane dell’ordine globale e continuano a sedere al suo centro. Ripensare il Medio Oriente come parte di un più ampio ordine asiatico aiuta a chiarire alcune delle domande più difficili che oggi affrontiamo: la finitezza delle risorse, l’eccesso di impegni, la sostenibilità economica di lungo periodo e, soprattutto, come delegare la gestione dell’ordine regionale a potenze regionali e medie capaci, invece di cercare di fare tutto, ovunque e sempre – cosa che semplicemente non possiamo più permetterci.
E qui però gli Stati Uniti dovrebbero passare dal nation-building all’order-building. Qual è la lezione più fraintesa delle esperienze in Iraq e Afghanistan, e come può Washington restare influente senza tornare a essere l’architetto diretto delle società locali?
La lezione più fraintesa dell’Iraq e dell’Afghanistan è che il problema non fosse l’esecuzione, o piani migliori, o più dispiegamenti militari, o – ovviamente – più denaro. Il problema era la premessa stessa di quelle guerre. Siamo entrati in guerra per le ragioni sbagliate e poi siamo rimasti per quelle sbagliate.
In Afghanistan, una volta sconfitto il regime talebano, non c’era un vero piano per il “giorno dopo”. Solo un impegno a tempo indefinito, centrato su Bagram, e l’invio continuo di soldati americani dal Mississippi a Kabul.
L’Iraq, invece, è stato il più grande disastro geopolitico in Medio Oriente nel XXI secolo. Nulla si avvicina nemmeno lontanamente. Ha distrutto l’equilibrio regionale di potere e ha aperto la strada a un asse settario iraniano offensivo, che ha devastato i territori sunniti e rappresentato una minaccia esistenziale per la stabilità interna e la coesione degli Stati del Golfo. In modo cruciale, Teheran ha mirato a compromettere le stesse “visioni” di sviluppo su cui oggi si fonda il futuro del mondo arabo.
Quello che ne è seguito sono stati, di fatto, vent’anni di slancio offensivo iraniano nella regione. E tutto questo risale alla disastrosa invasione dell’Iraq.
La vera lezione per gli Stati Uniti è semplice: non si può ingegnerizzare la stabilità sociale dall’esterno. Ciò che l’America può fare, quando è focalizzata, è modellare l’ambiente strategico più ampio. Aiutare a istituzionalizzare, mantenere e proteggere corridoi economici chiave; sostenere potenze regionali e medie che possono effettivamente imporre l’ordine; creare incentivi che impediscano al sistema di andare fuori controllo.
Restare influenti non significa progettare da zero le società altrui. Significa progettare il sistema e lasciare che le potenze regionali gestiscano i dettagli. Questo non è isolazionismo, come alcuni sostengono, ma semplice realismo rispetto alla finitezza delle risorse americane e all’esercizio del potere in un contesto globale sempre più conteso.
Nel libro si spiega come adesso il nuovo asse strategico tra Stati Uniti e West Asia non ruota più attorno al petrolio, ma al compute. Alla luce del Critical Mineral Summit di Washington e dell’iniziativa Pax Silica, quanto è ormai chiaro che la competizione sull’AI è, in ultima analisi, una competizione per il controllo dei minerali critici e per la gestione dell’intervento statale lungo l’intera catena del valore?
Durante il Covid viaggiavo spesso tra l’Arabia Saudita e Washington, e il contrasto era impressionante. Negli Stati Uniti avevo nel portafoglio un cartoncino cartaceo per il vaccino. In Arabia Saudita tutto era completamente digitale. Ho persino fatto l’Umrah alla Mecca tramite un’app. È stato impressionante e ha mostrato un livello di resilienza digitale del Golfo molto diverso quando la pandemia ha colpito. Dubai è diventata un hub globale per i nomadi digitali perché è rimasta aperta e ha costruito servizi digitali resilienti.
Tutto questo era prima del “momento ChatGPT”. Oggi è chiaro che il compute è una delle principali risposte del Golfo a un futuro post-energetico. C’è una concentrazione quasi chirurgica sulla costruzione di una base tecno-industriale che in larga misura salta l’era industriale del XX secolo.
Ma il compute, dal mio punto di vista, è finito. È vincolato da chip, infrastrutture energetiche e capitale. Un singolo gigawatt di capacità computazionale può costare oltre 30 miliardi di dollari. Ed è qui che il Golfo e la sua leadership diventano centrali. Vedono l’AI come uno strumento per affrontare alcune delle loro sfide più profonde: la diversificazione economica, la sicurezza nazionale e, soprattutto, la demografia.
E mentre gli Stati Uniti cercano di superare la Cina in termini di scala, faranno sempre più affidamento sul Golfo per contribuire alla costruzione della capacità computazionale globale. Lo abbiamo già visto negli accordi sull’AI dell’era Trump, nell’inclusione di due Paesi del Golfo in Pax Silica e nella cooperazione in corso con l’Arabia Saudita sulla lavorazione dei minerali critici.
Paesi come Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita stanno infatti investendo massicciamente in AI, data center e semiconduttori per passare da consumatori a produttori di tecnologia. Quanto è realistica questa ambizione e quali errori dovrebbero evitare per non restare semplici “piattaforme ospitanti” dell’innovazione occidentale? E dove passa il confine tra partenariato strategico e vulnerabilità, soprattutto in termini di sovranità digitale e controllo delle infrastrutture critiche?
La costruzione di infrastrutture di compute attrae interi ecosistemi: aziende che progettano chip, che sviluppano sistemi di raffreddamento, che producono semiconduttori legacy – tutti ambiti perfettamente alla portata del Golfo.
Queste sono anche le mie raccomandazioni: costruire una filiera di talenti in grado di progettare e gestire data center e grandi cluster di calcolo; investire in campioni nazionali per sviluppare un livello enterprise domestico; creare bacini di compute condivisi accessibili a startup e centri di ricerca, sia nazionali che regionali; sostenere la progettazione di chip attraverso incentivi di politica industriale tradizionali, con un focus molto mirato sui chip legacy.
Il compute non è semplicemente data center installati sul territorio con servizi enterprise sovrapposti. È un catalizzatore di tecno-industrializzazione.
Nello schema delineato, anche l’India emerge come pilastro centrale di un nuovo sistema che collega Nuova Delhi, Israele e gli Stati arabi moderati. Come può questo asse funzionare da stabilizzatore regionale senza essere percepito come un blocco apertamente antagonista da Iran e Turchia?
Ho formulato la tesi del “costrutto indo-abramitico” sei anni fa, e continua a reggere: il confine tra Asia meridionale e Medio Oriente, di fatto, non esiste, dicevamo.
Detto questo, nuove dinamiche stanno chiaramente emergendo. L’indebolimento relativo dell’Iran, combinato con la crescente libertà di movimento operativo di Israele nello spazio aereo arabo, sta rimodellando la regione. Come sostengo nel libro, stiamo assistendo all’inizio di qualcosa di nuovo tra Israele e gli Stati arabi moderati che, se continuerà, rappresenterà il cambiamento più significativo dai tempi della firma degli accordi di Camp David da parte di Sadat.
Allo stesso tempo, il Pakistan viene progressivamente integrato nel quadro regionale, parallelamente al rafforzamento dell’alleanza tra India e Israele. Pakistan e India, in modi e gradi diversi, coopereranno entrambi con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Non si tratta di scelte a somma zero. L’Azerbaigian, per esempio, è vicino alla Turchia e al Pakistan, ma anche molto vicino a Israele. Non vediamo effetti di spillover automatici.
Queste relazioni non operano in compartimenti stagni, ma la loro frizione è ormai una caratteristica riconosciuta del panorama regionale. L’era delle alleanze rigide al 100% è finita.
La vera sfida della regione è la sotto-istituzionalizzazione. Mancano meccanismi sufficienti per gestire le differenze, ridurre le frizioni e contenere l’escalation quando le tensioni aumentano. Per questo è significativo vedere il ME3 – Egitto, Turchia e Qatar – svolgere un ruolo collettivo su Gaza e sull’Iran. E formati come I2U2, Imec, Gcc-Asean e Gcc-Ue mirano proprio a costruire istituzioni per questa regione vasta e sotto-istituzionalizzata.
Alcuni formati dureranno, altri diventeranno dormienti. Ne emergeranno di nuovi, ed è perfettamente normale. In definitiva, i formati minilaterali funzionano per tentativi ed errori, per individuare i partner giusti e le strutture più efficaci. I decisori politici, in qualsiasi capitale – non solo a Washington – non dovrebbero legarsi a un solo formato.
La nuova normalità è una rete di coalizioni sovrapposte: talvolta in competizione, talvolta cooperative, a seconda del tema, del momento e, naturalmente, della postura di Washington.
Ma dopo Gaza e in un contesto di crescenti tensioni regionali, i corridoi – dall’Imec alla Development Road turco-irachena – restano strumenti credibili di ordine strategico o rischiano di rimanere soprattutto narrazioni geopolitiche? E ha senso, nel frattempo, affiancare ai grandi progetti multilaterali forme più flessibili e bilaterali di connettività, come un possibile asse Italia–India tra Trieste o Genova e Mumbai?
Diciamo subito che l’Europa non dovrebbe fissarsi sulla normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele. È una visione troppo ristretta e perde di vista il quadro più ampio. E se l’Europa continua a guardare al vecchio “Medio Oriente” solo come a una fonte di capitale e a una rotta verso l’India, allora – francamente – buona fortuna.
L’Italia conosce la propria storia e sa che il suo futuro è ancorato al Mediterraneo Allargato. Lo si vede nell’impegno attivo con Egitto, Golfo, Turchia e India, o nella presenza di aziende come Eni e nei cavi sottomarini di Sparkle. Roma si sta di fatto posizionando come testa di ponte di un nuovo sistema transcontinentale.
Nel frattempo, il reset geoeconomico europeo dopo l’Ucraina richiede qualcosa di molto più profondo: legami istituzionalizzati con Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, l’intero Gcc e, sì, la Turchia. Che piaccia o no ad alcune capitali europee, la Turchia è un pilastro della sicurezza europea post-Ucraina, e una revisione del rapporto con Ankara è da tempo necessaria. Erdoğan o non Erdoğan.
La regione non va letta attraverso un singolo corridoio o un singolo porto. È un sistema. Imec, la rotta guidata dalla Turchia o la Zona Economica del Canale di Suez rispondono tutte allo stesso obiettivo: costruire un sistema geoeconomico transcontinentale che va dal Mediterraneo all’Oceano Indiano.
O ne fai parte o ne resti fuori. Se l’Europa tratta l’Egitto come il semplice operatore del Canale di Suez, non dovrebbe stupirsi di svegliarsi un giorno e scoprire che la Zona del Canale ha poco a che fare con l’economia europea e molto di più con i produttori asiatici inseriti nelle catene del valore asiatiche. Questo non è il percorso ottimale per i produttori europei né per la loro postura globale.
Se la geografia è davvero destino – e lo è – allora il destino dell’Europa è indissolubilmente legato all’Asia Occidentale. Piuttosto che restare ai margini, l’Europa dovrebbe contribuire a governare la rotta di questa regione emergente.
(Foto: Fiona Brummer)