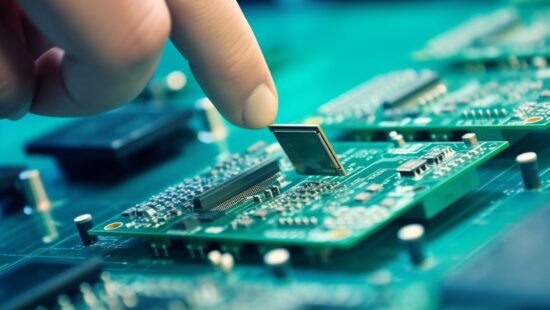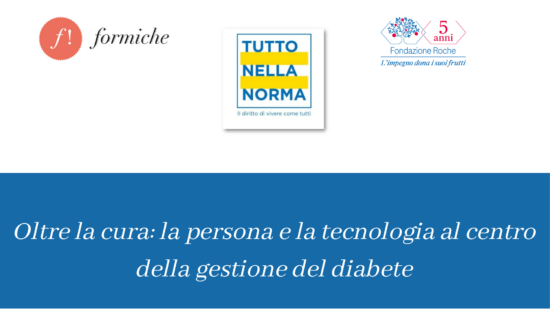La presidenza italiana del G7, dice a Formiche.net l’ex ambasciatore Gabriele Checchia, sarà strategica per ampliare un ruolo e rivendicare un peso specifico indiscutibile. L’occasione è il primo anniversario del governo Meloni, a cui il diplomatico dedica un’ampia riflessione, partendo da un dato: Ucraina, Fronte sud, Mediterraneo, Balcani, Caucaso e Nato sono punti chiave delle iniziative di Giorgia Meloni. Da un lato il Piano Mattei e il dossier migranti, dall’altro una maggiore presenza italiana e un ruolo di Roma di pivot nella ex Jugoslavia, accanto al peso specifico nell’Alleanza Atlantica e alla decisione sulla Via della Seta e sulla Via del Cotone. “La forza del governo? Meloni, Tajani, Crosetto e Urso ragionano all’unisono, un grande vantaggio”.
Un anno fa si leggeva che l’Italia con il governo Meloni sarebbe uscita dall’euro e dall’Ue: non solo evidentemente non è successo, ma la politica estera è diventata un punto cardine dell’azione del premier. Come giudica questi 12 mesi, tra vertici, meeting e decisioni?
Il giudizio non può essere che positivo per una serie di fattori. In primis la grande sintonia tra premier, ministro degli esteri, della difesa e del made in Italy: Meloni, Tajani, Crosetto e Urso ragionano all’unisono, un grande vantaggio. Certamente la politica estera è diventata uno dei tratti caratterizzanti di questo primo anno di Governo a maggioranza di centrodestra. Giorgia Meloni è fedele agli impegni che aveva assunto già in occasione del suo discorso di investitura e aveva asserito, tra l’altro, che chi non sarà d’accordo con un’Italia a pieno titolo nell’Europa e nell’Alleanza atlantica non potrà mai fare parte del governo, a costo di non fare il governo. Questo accadde nei giorni in cui ancora stava formando l’esecutivo e, successivamente, aggiunse che l’Italia non sarebbe mai stata l’anello debole dell’Occidente. Una risposta a chi faceva presente che nella maggioranza ci potevano essere componenti sensibili alle sirene che provenivano da Mosca.
È accaduto?
Si è rivelata coerente con questo impegno. Inoltre mi colpisce che, per la prima volta dopo tanti anni, abbiamo l’impressione di trovarci di fronte ad una politica estera basata su una visione ispirata a dei valori che sono quelli nei quali il premier e l’Italia si riconoscono, stando al risultato delle ultime elezioni. Roma è posizionata al fianco dell’Ucraina nel resistere alla brutale aggressione della Russia di Putin in linea con l’afflato atlantico, europeista e filo occidentale: certamente c’è una scelta valoriale nella nostra ferma adesione allo schieramento atlantico e nel nostro riconoscerci nei valori alla base dell’Unione europea. Lo stesso si può dire per quanto riguarda l’Africa.
In quale misura?
Un passaggio che mi ha molto colpito nell’approccio del presidente Meloni relativamente al continente africano è quello sulla politica non predatoria: ovvero una politica estera verso l’Africa in cui riconosco anche una componente legata alle nostre radici cristiane, cioè basata sul rispetto dell’interlocutore, chiunque egli sia a prescindere da razza e religione. È davvero molto intenso e mi pare che il Piano Mattei vada in questa direzione. In Africa, non dimentichiamo, si giocano tante partite valoriali, basta pensare al contrasto al traffico degli esseri umani che deriverebbe da uno sviluppo dei vari Paesi che compongono quell’immenso continente, ma penso anche a partite energetiche legate alle materie prime.
Il rapporto con l’Europa come si è sviluppato in questo anno?
È un’altra delle cifre dell’attuale coalizione di governo, un rapporto che sotto certi profili è di continuità per quanto riguarda la tenuta dei conti pubblici, a parte la nota questione del Mes. Vedo anche elementi di discontinuità non tanto sui singoli dossier, quanto nel rivendicare con maggiore assertività la tutela dell’interesse nazionale. E qui io ravviso un altro elemento importante relativo a Giorgia Meloni e alla sua storia politica, ovvero la consapevolezza della grande storia d’Italia e delle nostre radici. Quindi una identità nazionale rivendicata con sobrietà ma anche con orgoglio, che non è affatto in contrasto con l’afflato europeo. Del resto lo stesso generale De Gaulle parlava di Europa delle patrie, però certamente penso ad un’Europa nella quale l’Italia vuole costruire, insieme con gli altri partner, il futuro. Penso ad un’Europa allargata per quanto possibile ai Balcani e in prospettiva alla stessa Ucraina, ma ferma nella difesa dell’interesse nazionale, senza esagerazioni, senza cadute di stile.
Sull’Ucraina l’Italia ha già votato per sette pacchetti di aiuti, è in arrivo l’ottavo: quale il peso specifico del nostro Paese nella strategia complessiva di sostegno a Kiev?
La postura verso Kyiv ci conferisce una rilevanza particolare, in linea con quanto previsto dai trattati. Tutti sanno che siamo un partner ineludibile dell’Alleanza Atlantica, nella quale stiamo investendo un peso sempre maggiore, non foss’altro per la necessità per gli Stati Uniti di concentrarsi soprattutto sul fronte dell’Indo pacifico, ma anche ovviamente su quello mediorientale, alla luce dei drammatici avvenimenti in atto a Gaza. Kyiv e Zelensky sono consapevoli che siamo un Paese che ha una sua storia, ha un suo valore aggiunto sia in termini di capacità di porgere le proprie tesi, sia di interagire con gli alleati, ma anche di interagire con gli avversari. Noi abbiamo sempre mantenuto negli anni, sino alla sciagurata aggressione di Putin all’Ucraina, una buona relazione anche con la Russia, che potrebbe riaffacciarsi qualora la tragedia ucraina dovesse poco a poco essere riassorbita sulla base di una pace giusta e durevole, che tenga conto soprattutto delle aspirazioni del popolo ucraino. Quindi nessuna pace alle spalle o contro il popolo ucraino. Ma a queste condizioni l’Italia potrà trovare di nuovo il suo ruolo. E gli ucraini lo sanno bene, anche in vista di un’Europa allargata pronta ad includere la stessa Ucraina quando saranno completate le procedure di allargamento. Quindi c’è un nostro valore specifico, direi un dna italiano che trova simpatia, trova attenzione certamente in Ucraina e nei Balcani, ma direi anche in tante aree del mondo, a cominciare da quella mediorientale.
Il fronte sud e la buona relazione instaurata con l’India di Modi offre all’Italia un’occasione di crescita e cooperazione? E come si inserisce tutto ciò con la Via della Seta e la Via del Cotone?
L’Italia ha un’occasione di crescita e devo dire che la presenza e la partecipazione del presidente Meloni all’ultimo G20 di Delhi, così come i suoi brevi incontri bilaterali con il il primo ministro Modi in occasione del Forum di inizio anno, confermano l’attenzione che il nostro governo giustamente pone all’India come partner strategico. Una potenza emergente che aspira a diventare entro il 2030 la terza economia mondiale, con un interscambio italo indiano già sui 14 miliardi di euro e la presenza di nostre imprese di punta in quel Paese, cito su tutte Leonardo ed Enel. La Via della Seta è una creatura a ispirazione cinese e, sotto questo profilo, direi che il governo italiano si sta muovendo bene nel tentativo di disinnescare questa nostra partecipazione, incautamente avviata da uno dei governi Conte, ma senza rompere il rapporto con la Cina, che resta comunque un partner importante. Nessuna volontà di andare allo scontro con la Cina, ma certamente sottrarsi alla pesantezza della Bri anche perché si è visto che il nostro interscambio, pur avendo firmato il memorandum, non è cresciuto con la Cina, a differenza di altri Paesi che non hanno sottoscritto il memorandum ma che pure hanno fatto affari con Pechino. La via del cotone è quella che è emersa come possibile alternativa alla via della seta, anche come riferimento geopolitico e che vedrebbe l’India come elemento centrale di tutta l’operazione, assieme al Giappone. È quello su cui si deve continuare a lavorare. La presidente Meloni si è resa tra le più attive sponsor di questa iniziativa in occasione del G20 di Delhi e auspico che questo possa costituire un’alternativa alla fertilità e all’espansionismo geopolitico cinese nella nostra area del mondo che richiederà, però, anche nella visione iniziale del progetto, perlomeno una partecipazione come snodo logistico e operativo dello Stato di Israele.
Con quali difficoltà?
Alla luce del nuovo clima pesante molto pesante che si sta determinando tra lo Stato ebraico e il mondo arabo, sta venendo meno il tassello israeliano e ciò potrebbe effettivamente provocare dei rallentamenti nella messa in atto ottimale della via del cotone. Ma chissà che anche in Medio Oriente, superata questa tremenda fase, non si possa poi riprendere quel percorso di collaborazione che sembrava avviato a risultati importanti, specie con una normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita. È positivo che Riad abbia però non gettato alle ortiche, ma per il momento solo congelato, il tentativo di normalizzazione dei rapporti con Tel-Aviv. Quindi la via del cotone resta un’ipotesi per noi importante, anche in un’ottica di contenimento dell’espansionismo cinese in Africa e in altre aree del mondo, offrendoci l’India come partner credibile e alternativo a Pechino. Ci sono certo delle criticità, non lo nego, ma la storia è fatta di criticità ed è fatta di soluzioni che sembravano a portata di mano e che d’improvviso svaniscono per riapparire poi, magari con mutamenti di forma qualche tempo dopo, in momenti per molti inattesi.
Nel cosiddetto quint Roma è ormai in pianta stabile: le relazioni Usa-Italia si sono rafforzate in questo anno? E come potranno procedere alla luce delle nuove gravi emergenze belliche in corso?
Le relazioni italo americane stanno conoscendo un momento particolarmente felice, anche dopo la visita del presidente Meloni a Washington e l’eccellente rapporto personale da lei stabilito con il presidente Biden. Tutto questo mi fa pensare che gli Stati Uniti, pur a guida democratica, si siano resi conto del ruolo insostituibile dell’Italia in seno all’Alleanza Atlantica. Noi stiamo rispettando tutti gli impegni assunti in ambito atlantico, dalla nostra partecipazione alla missione in Kosovo alla nostra presenza alla guida della missione di addestramento delle forze di sicurezza irachene, quindi il nostro contributo in seno alla Nato sotto tutti i profili è inappuntabile. Di questo Washington è consapevole e ce ne dà atto mentre gli Stati Uniti dovranno sempre più concentrarsi sul versante indo pacifico, superata speriamo in tempi ragionevoli la tempesta mediorientale.
Quale la carta italiana per presidiare il Mediterraneo in attesa del G7?
Dovrà tornare a essere zona di stabilità e di scambi proficui tra tutte le sponde. Per gli Stati Uniti sarà importante avere un partner affidabile come l’Italia ed ecco perché la stessa Meloni ci aveva tenuto, in apertura nel proprio discorso di insediamento, a citare una Nato nella quale l’Italia intende restare come partner di primo piano e a testa a testa alta: questo nessuno ce lo può contestare. Credo che, in prospettiva, avremo ancora ulteriori opportunità di approfondire la collaborazione con gli Stati Uniti su tutti i profili, dalle nuove tecnologie alla transizione energetica, passando per la difesa, sulla base di una coesione che non è mai venuta meno e che giustamente il Presidente Meloni rivendica. La Nato ha ritrovato vitalità dopo il vertice di Vilnius, con l’adesione finlandese già avvenuta, quella svedese in fieri, Turchia permettendo. E in tutto questo il nostro ruolo sarà quello di assicurare la necessaria solidarietà all’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario, ma anche di evitare che l’Alleanza guardi esclusivamente a nord perché c’è un fronte mediterraneo, da monitorare e presidiare, come i drammatici avvenimenti di questi giorni in Israele, nell’area limitrofa stanno a dimostrare. In questo senso la presidenza italiana del G7 sarà strategica per ampliare un ruolo e rivendicare un peso specifico indiscutibile.