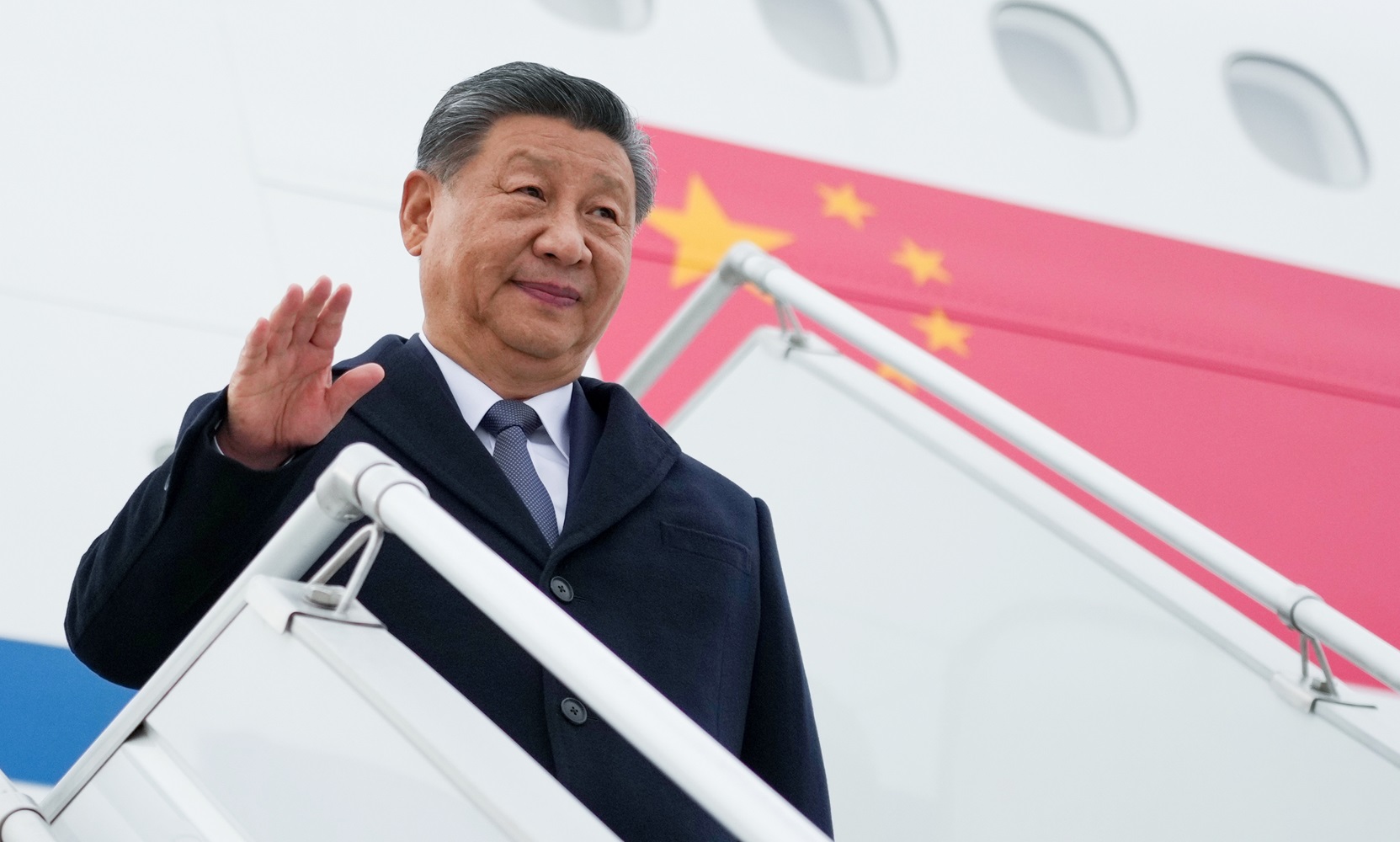Il problema europeo degli investimenti va analizzato all’interno di un contesto globale dominato dalla strategia economica di Cina e Stati Uniti. Se le quote manifatturiere di Pechino e Washington crescono, inevitabilmente quelle europee devono ridursi. L’analisi di Micheal Pettis, senior fellow presso il Carnegie endowment for international peace, ed Enrico Fardella, Associate Professor del Department of Social and Human Sciences all’Università di Napoli ‘L’Orientale’ e Adjunct Professor alla School of Advanced International Studies (SAIS) Europe della Johns Hopkins University
Un recente sondaggio della Banca Centrale Europea (BCE) ha confermato quello che molti osservatori sospettavano da tempo: gli investimenti in Europa ristagnano non perché manchi il capitale, ma perché manca la domanda. Le imprese europee non hanno incentivi ad aumentare la capacità produttiva se i consumatori non comprano e i margini restano bassi.
Questo dato ha conseguenze profonde. Sono in molti a Bruxelles o Francoforte a ritenere che eventuali flussi di capitale dall’estero – ad esempio se gli investitori globali riducessero l’esposizione agli asset americani e comprassero più titoli europei – sarebbero un bene per l’UE. In teoria abbasserebbero i tassi d’interesse e renderebbero più capitale disponibile per le imprese. Ma se il problema non è l’accesso al credito, bensì la scarsità di domanda, questi afflussi rischiano di sortire l’effetto opposto: un euro più forte, minore competitività, meno domanda per i prodotti europei, dunque meno incentivi a investire.
EU: troppo capitale e scarsa domanda, che fare?
La bilancia dei pagamenti prima o poi presenta il conto: se l’Europa assorbe capitali in eccesso senza che questi si traducano in nuovi investimenti, l’aggiustamento avverrà inevitabilmente attraverso una riduzione dei risparmi che potrà manifestarsi o sotto forma di maggiore disoccupazione – con imprese costrette a ridurre la produzione e licenziare – oppure tramite il debito, con famiglie e governi chiamati a sostenere la domanda mancante ricorrendo all’indebitamento.
Non si tratta di un’ipotesi astratta: con le riforme del lavoro del 2002, la Germania adottò un modello economico, fondato sulla compressione dei salari e minori tutele sul lavoro, che rese le sue esportazioni più competitive e le permise di accumulare ampi surplus commerciali. Il prezzo, però, fu una domanda interna debole e una crescente dipendenza dai mercati esteri. L’eccesso di risparmio così generato si riversò nel resto dell’Eurozona sotto forma di capitali, costringendo Paesi come Spagna e Italia – privi dello strumento del cambio in seguito all’adozione dell’Euro – ad adattarsi seguendo percorsi alternativi e spesso dolorosi.
La Spagna cercò di posticipare l’inevitabile aggiustamento attraverso un boom immobiliare alimentato dal debito, salvo poi subire dopo il 2008 una correzione brutale, con il crollo della domanda e la disoccupazione schizzata oltre il 25%. L’Italia, invece, fece meno affidamento sulla compressione dei salari o sui licenziamenti di massa, e trasferì il peso dell’aggiustamento sull’aumento del debito pubblico. È importante sottolineare che né la Spagna né l’Italia scelsero deliberatamente questi percorsi: entrambe furono costrette ad adattarsi per assorbire i surplus generati dalle politiche industriali tedesche all’interno del quadro della moneta unica.
L’Europa, dunque, non potrà sottrarsi all’impatto dei flussi di capitale. La questione è se a pagarne il prezzo sarà l’occupazione o la sostenibilità del debito.
Perchè l’industria “serve” più dei servizi?
Il problema europeo va analizzato all’interno di un contesto globale dominato dalla strategia economica di Cina e Stati Uniti. La Cina fonda ancora la sua crescita sull’espansione della quota di manifattura mondiale, oggi pari al 31% a fronte di un Pil che rappresenta il 18% del totale globale. Questo modello, come quello tedesco precedentemente descritto, richiede grandi surplus commerciali che di fatto trasferiscono all’estero le distorsioni economiche interne. Negli Stati Uniti – che ad oggi rappresentano il 23% del PIL globale ma solo il 17% delle manifatture nel mondo – si è ormai creato un consenso bipartisan sulla necessità di invertire decenni di de-industrializzazione, rilanciando la produzione interna e riducendo la dipendenza dalle importazioni di paesi come Cina e Germania.
Se le quote manifatturiere di Cina e Stati Uniti crescono, inevitabilmente quelle di Europa e altri Paesi avanzati devono ridursi. L’UE si troverà così a difendere le sue quote in un’arena dove competono giganti come Giappone, Corea del Sud o Taiwan, che a differenza della UE controllano attivamente le loro bilance di pagamenti e non lasciano che sia il ‘mercato’ a imporre loro decisioni strategiche.
C’è chi sostiene che i servizi possano compensare il declino industriale. Ma è purtroppo per lo più un’illusione. La manifattura è il principale motore della produttività e, a differenza della maggior parte dei servizi, è esportabile su larga scala. I servizi locali – dalla sanità alla cura alla persona – non generano le stesse economie di scala, e anche quelli più globalizzati, come finanza o consulenza, hanno dimensioni molto inferiori al commercio mondiale di beni. Questo significa che i servizi, da soli, non possono compensare la perdita della manifattura: non generano né sufficienti esportazioni né quel tipo di crescita della produttività che fa aumentare i salari.
Un’Europa sempre più dipendente dai servizi e dal debito rischia quindi di perdere competitività, accumulare deficit commerciali e alimentare frustrazione sociale e politica. È la traiettoria che hanno già seguito gli Stati Uniti: più disuguaglianze, crescita lenta, squilibri interni che riflettono quelli esterni. Quali sono i possibili scenari futuri? Di seguito identifichiamo dunque quattro possibili macro-scenari.
La Cina ribilancia la sua economia verso i consumi interni e coopera con Stati Uniti ed Europa per riequilibrare il commercio globale
Sarebbe la soluzione ottimale, ma anche la meno probabile: In Cina i consumi delle famiglie restano sotto il 40% del PIL, il livello più basso al mondo, e farli crescere richiederebbe una massiccia redistribuzione di reddito dai governi locali alle famiglie, pari al 10–20% del PIL. Un’operazione non solo economica ma soprattutto politica, perché minerebbe il potere del settore statale, principale beneficiario dell’attuale modello. Per questo, pur essendo semplice sul piano aritmetico, il riequilibrio appare altamente improbabile e, in ogni caso, molto lento: basti pensare che al Giappone, con squilibri ben più contenuti, servirono quasi vent’anni per rilanciare i consumi.
La Cina prosegue sulla rotta attuale e Stati Uniti ed Europa non reagiscono
È il mondo di oggi. Pechino mantiene l’attuale modello di crescita, continuando a puntare sulla domanda esterna e sull’export di surplus produttivi e capitali, mentre gli Stati Uniti non riescono a ridurre il proprio deficit con i dazi ed Europa resta esposta e senza protezioni. Questo significa per l’Occidente meno manifattura, più debito o disoccupazione e crescenti tensioni politiche. Tuttavia, lo scenario appare difficilmente sostenibile: a differenza dell’Europa, a Washington esiste ormai un consenso bipartisan sulla necessità di difendere l’economia americana da queste distorsioni.
La Cina non cambia, ma Stati Uniti ed Europa reagiscono insieme
La Cina mantiene l’attuale modello, basato su surplus commerciali e sulla crescita della propria quota manifatturiera, mentre Stati Uniti ed Europa reagiscono difendendo i loro mercati. Si crea così un’impasse: gli squilibri non possono più essere assorbiti né da altre economie avanzate, che si proteggerebbero, né dal mondo in via di sviluppo, che non ha la capacità finanziaria per farlo. A quel punto la Cina sarebbe costretta a una rapida ristrutturazione interna, con un forte aumento della quota di reddito delle famiglie e un riequilibrio che storicamente avviene solo tramite rallentamenti o contrazioni della crescita.
La Cina non cambia, gli Stati Uniti si difendono…ma l’Europa no
Lo scenario peggiore per l’Europa è quello in cui la Cina continua a espandere la propria quota manifatturiera mentre gli Stati Uniti si difendono rilanciando l’industria e riducendo il ruolo di assorbitore dei surplus globali. Questo sposterebbe i capitali in eccesso verso l’UE, costringendola ad assorbirli con più debito o più disoccupazione. Il risultato sarebbe un continente sempre più dipendente dai consumi finanziati a debito e dai servizi, mentre la sua base manifatturiera si restringe. Tra questi, il primo è certamente il migliore ma è ad oggi il più inverosimile; il quarto, purtroppo, appare il più probabile, soprattutto se l’Europa non comprende la portata storica della sfida e lascia che a reagire siano solo i singoli Stati membri, troppo piccoli per reggere l’onda d’urto in arrivo.
Formiche 217
Analisi pubblicata sulla rivista Formiche in vista dell’incontro “Turning tides? – The future of China–EU relations”, la conferenza internazionale che si svolgerà il 27 e 28 ottobre a Bologna, e co-organizzata dall’Università di Bologna e dalla School of Advanced International Studies (SAIS) della Johns Hopkins. Per seguire l’evento, che si tiene in occasione del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Ue e Cina, si può usare questo link. Formiche è media-partner della conferenza e pubblicherà analisi e approfondimenti su di essa.