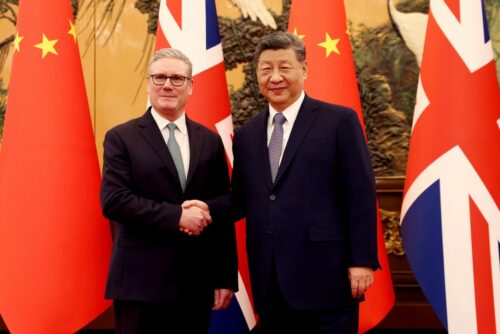Dalla fragile dialettica Usa-Iran alla crisi di Gaza, passando per Siria e rivalità intra-Golfo, il Medio Oriente entra in una fase di instabilità sistemica. Secondo Giuseppe Dentice (OsMed), più che soluzioni definitive, oggi prevale una gestione del rischio per contenere escalation e frammentazioni
Negli ultimi mesi il Medio Oriente è entrato in una fase di instabilità strutturale ad alta densità, in cui più dossier e tensioni – apparentemente – distinte tendono a sovrapporsi e a rafforzarsi a vicenda. Al centro di questo quadro critico si colloca il triangolo tra Stati Uniti, Israele e Iran, che continua a rappresentare l’asse portante delle dinamiche di sicurezza regionali. L’incontro in Oman tra funzionari iraniani e statunitensi di venerdì ha attirato i riflettori internazionali, pur avendo raggiunto risultati molto limitati – con l’unico, apparente elemento positivo il fatto che le due parti abbiano scelto di discutere.
”La relazione tra Washington e Teheran è tornata a oscillare tra deterrenza e diplomazia: da un lato, il rafforzamento della postura militare statunitense e i segnali di fermezza inviati all’Iran mirano a contenere rischi di escalation incontrollata; dall’altro, la riattivazione di canali negoziali sul nucleare indica la volontà di evitare che il confronto scivoli verso uno scontro diretto o verso una proliferazione irreversibile. In questo contesto, Israele svolge un ruolo ambivalente ma decisivo”, commenta Giuseppe Dentice, analista dell’OsMed dell’Istituto Studi Politici Pio V.
Tel Aviv osserva con estrema cautela qualsiasi apertura negoziale tra Stati Uniti e Iran, temendo che un accordo limitato al solo dossier nucleare possa lasciare intatte le capacità missilistiche iraniane e la rete di attori armati non statali che Teheran sostiene nella regione. ’La pressione israeliana sugli Stati Uniti – continua Dentice – va letta, dunque, come un tentativo di condizionare i termini di un eventuale accordo, più che di impedirlo del tutto. Tuttavia, in pratica, lo spazio per un accordo ampio è molto limitato”.
Lo scenario più realistico? ”È quello di un’intesa temporanea, che blocchi alcune attività sensibili iraniane in cambio di un alleggerimento selettivo delle sanzioni, con l’obiettivo di prendere tempo e ridurre il rischio di escalation militare. In questa fase, infatti, il negoziato sembra funzionare più come strumento di gestione del rischio che come soluzione definitiva al contenzioso’”.
La crisi di Gaza si inserisce in questo quadro come uno dei principali moltiplicatori di instabilità? “Lo è: la cosiddetta ’fase due’ del cessate il fuoco si presenta sin dall’inizio come una fase ad handicap, perché la riduzione delle ostilità non si è tradotta in un vero processo di stabilizzazione politica. Sul terreno, la Striscia resta segnata da distruzioni diffuse, sfollamenti interni all’area e dipendenza strutturale dagli aiuti umanitari, mentre il controllo della sicurezza rimane una questione irrisolta”.
Le proposte emerse finora – demilitarizzazione progressiva, governance transitoria a guida tecnocratica palestinese, meccanismi internazionali di monitoraggio – si scontrano con i nodi politici profondi. “Israele subordina (e rinnova di volta in volta) ogni avanzamento a garanzie di sicurezza stringenti, mentre Hamas difficilmente accetta una perdita di potere (anche solo parziale) senza contropartite politiche credibili. Il rischio, sempre più evidente, è che la governance tecnica di Gaza si trasformi in una soluzione amministrativa priva di legittimità, incapace di affrontare la questione centrale della rappresentanza politica palestinese. In assenza di un chiaro orizzonte politico, che includa una riforma o un rafforzamento dell’Autorità Nazionale Palestinese e un minimo consenso interno palestinese, la fase due rischia di rimanere una tregua armata, vulnerabile a nuove spirali di violenza e facilmente strumentalizzabile dagli attori regionali”, osserva l’analista.
Parallelamente, allargando lo sguardo, la Siria continua a rappresentare un laboratorio di competizione regionale. Gli scontri e le tensioni tra il governo centrale e le forze curde nel nord del Paese mettono in luce la fragilità del processo di ricomposizione statale. ”Damasco – analizza Dentice – punta a reintegrare i territori curdi riducendone l’autonomia militare e politica, ma questa strategia si intreccia con gli interessi esterni, in particolare quelli della Turchia, che considera le forze curde una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale”.
Il risultato è una dinamica in cui il dossier curdo diventa non solo una questione interna siriana, ma anche un terreno di competizione indiretta tra attori regionali. In questo scenario, la relazione tra Israele e Turchia assume un carattere sempre più conflittuale e competitivo. ”Ankara mira a consolidare la propria influenza nel nord della Siria e a impedire qualsiasi consolidamento curdo; Israele, al contrario, guarda con sospetto a un rafforzamento turco nel Levante e preferisce una Siria strutturalmente debole o frammentata, incapace di ospitare minacce coordinate contro il proprio territorio. La gestione della questione curda diventa così un fattore di frizione strategica: ogni avanzamento dell’uno è percepito dall’altro come una perdita relativa, alimentando una spirale di azioni indirette e posture difensive”.
A completare il quadro regionale contribuiscono le tensioni intra-Golfo, in particolare tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Quella che un tempo appariva come una partnership solida e immune a rivalità si è progressivamente trasformata in una competizione per la leadership regionale, visibile soprattutto nel dossier yemenita e nella proiezione di potere nel Mar Rosso e nel Corno d’Africa. Secondo Dentice, le divergenze su alleanze locali, controllo dei porti e modelli di influenza “hanno eroso la coesione del Golfo proprio mentre la regione avrebbe bisogno di maggiore coordinamento per affrontare crisi sistemiche come quella iraniana o la sicurezza delle rotte marittime”. Per l’analista, questa rivalità non si traduce necessariamente in un conflitto aperto, “ma agisce come fattore di frammentazione che indebolisce le capacità di mediazione regionale, complica la gestione dei teatri periferici ma strategici (come Yemen e Mar Rosso) e aumenta l’imprevedibilità per gli attori esterni, inclusa l’Unione Europea. In un Medio Oriente già attraversato da guerre irrisolte e competizioni incrociate, la frizione saudita-emiratina funziona da moltiplicatore delle fragilità esistenti”.
Nel complesso, emerge l’immagine di una regione in cui le crisi non possono più essere analizzate separatamente. Il negoziato sul nucleare iraniano, la fragile tregua a Gaza, la ricomposizione incompleta della Siria e le rivalità intra-Golfo fanno parte di un unico sistema regionale instabile, segnato da equilibri precari, da una deterrenza sempre più tesa e da processi politici irrisolti. “In questo contesto, in assenza di soluzioni strutturali, la gestione del rischio e il contenimento delle escalation rappresentano, nel breve periodo, gli obiettivi più realistici”, conclude Dentice.