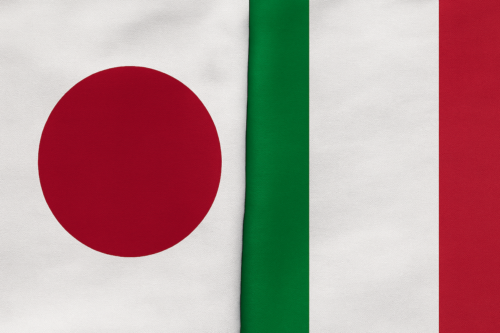Pubblichiamo l’intervento di Gabriele Natalizia, direttore del Centro studi Geopolitica.info, in audizione con il Comitato permanente sulla politica estera per l’Africa della Commissione esteri dedicata al Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito – promosso dalla Commissione europea
In occasione del trentennale dell’avvio del Processo di Barcellona per il partenariato euro-mediterraneo, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza hanno presentato il “Patto per il Mediterraneo”. Il documento è pensato per offrire nuovo slancio alla cooperazione con dieci Paesi della sponda sud ed est – Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia.
Si tratta solo dell’ultimo segnale di una crescente attenzione da parte di Bruxelles per l’area, che segue il varo dell’Agenda per il Mediterraneo nel 2021 e la nomina del primo Commissario europeo per il Mediterraneo nel 2024.
Il Patto per il Mediterraneo si prefigge di promuovere “più di cento iniziative” – in parte nuove e in parte come potenziamento di azioni già esistenti – che saranno recepite in uno specifico piano d’azione, la cui pubblicazione è attesa entro il primo trimestre dell’anno in corso. La presente riflessione, pertanto, si limita ad avanzare alcune considerazioni sul contesto politico-strategico nel quale il Patto si inserisce e sugli obiettivi generali di quest’ultimo.
Credo sia necessario, preliminarmente, ricordare alcuni numeri – forniti dallo UN environment programme – sull’importanza del Mediterraneo, che costituisce l’elemento di connessione tra i Paesi del partenariato. Pur rappresentando solo l’1% della superficie marina globale esso: ospita 600 porti e terminal; la sua popolazione costiera ammonta a 150 milioni e raddoppia durante la stagione estiva; genera il 20% del Prodotto marino globale mondiale; infine, registra il 25% del traffico marittimo globale e il 30% del traffico mondiale di petrolio.
Non a caso l’Italia ha iniziato a utilizzare – già dagli anni Ottanta – il concetto di “Mediterraneo allargato”, per riferirsi a quella macro-regione che abbraccia Europa meridionale e mar Nero, passa poi per Medio Oriente, golfo Persico e costa occidentale dell’India e, infine, attraversa Corno d’Africa, nord Africa, Sahel e golfo di Guinea.
Anche in funzione dei numeri qui brevemente riportati, Roma ha parlato anche di un “Mediterraneo globale”, per sottolineare la funzione di interconnessione che questo mare svolge tra due oceani – Indiano e Atlantico – e tre continenti – Europa, Africa, Asia – senza però dimenticare anche la costa orientale dell’America.
Negli ultimi quindici anni, tuttavia, l’area del Mediterraneo allargato è stata colpita da una generale condizione di instabilità.
Non solo perché vede riproporsi al suo interno le principali sfide della nostra epoca – transizione energetica, cambiamenti climatici, connettività infrastrutturale, approvvigionamento di materie prime critiche, sicurezza alimentare e digitalizzazione – ma anche perché vi ha preso forma una lunga – e ben nota – scia di crisi: il tracollo della statualità a partire dal 2011 di numerosi Paesi, come Libia, Yemen e Siria; i flussi migratori irregolari che hanno registrato diversi picchi, in particolare 2015 e 2023; i colpi di Stato a carattere anti-occidentale nel Sahel a partire dal 2020; il conflitto in Sudan, in corso dal 2023; gli attacchi del 7 ottobre 2023, il successivo conflitto a Gaza e il loro effetto spill-over in Libano; gli attacchi degli Houthi contro la libertà di navigazione nel mar Rosso e nel mar Arabico; il conflitto tra Israele e Iran del giugno 2025 (anticipato dagli attacchi del 2024 e con la coda dell’operazione Midnight hammer del 22 giugno 2025).
Occorre interrogarsi sulle ragioni di questa instabilità, che non colpisce un singolo Paese o un territorio circoscritto, ma investe il bacino del Mediterraneo nonché le aree ad esso immediatamente adiacenti.
È necessario, quindi, individuare la condizione permissiva di tale instabilità. Così come accade anche per l’Europa orientale, sul Mediterraneo allargato gravano le conseguenze del declino relativo in termini di potere che, a partire dal triennio 2007–2009, ha investito gli Stati garanti dell’ordine internazionale del post-Guerra fredda. Si fa riferimento, ovviamente, agli Stati Uniti e ai loro principali alleati, tra cui i Paesi europei.
Tale declino relativo ha riguardato, anzitutto, la dimensione economica e, seppur in misura minore, quella militare. L’altra faccia della medaglia è stata la crescita, anch’essa relativa, di potenze con interessi confliggenti con quelli dell’Unione europea e dell’Alleanza Atlantica – in particolare Cina, Russia e Iran – che hanno progressivamente accresciuto la loro influenza non solo nelle regioni di appartenenza, ma anche nel bacino del Mediterraneo.
Questi attori hanno iniziato a chiedere, con modalità sempre più assertive – e in alcuni casi ricorrendo alla violenza – una revisione dell’ordine internazionale del post-Guerra fredda, sia per quanto riguarda l’allocazione delle risorse, sia con riferimento ai valori, alle regole e ai modelli politici ed economici su cui era stata rifondata la convivenza internazionale dopo il collasso dell’Unione Sovietica.
A questo fenomeno si fa ormai comunemente riferimento con l’espressione di “competizione tra grandi potenze”. A tale declino relativo è corrisposta una minore disponibilità degli Stati Uniti a investire risorse in aree geografiche o in funzioni che non considerano più strategiche, ossia vitali per il mantenimento del loro primato internazionale. Il Mediterraneo ha così conosciuto una progressiva secondarizzazione all’interno della grand strategy americana, avviata ben prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ma a cui la nuova amministrazione ha impresso una brusca accelerazione.
Washington, d’altronde, ha cercato – per quanto possibile – di limitare il proprio impegno diretto nell’area, riorientando attenzione e risorse verso l’Indo-Pacifico, indicato come il teatro prioritario per la competizione con la Repubblica Popolare Cinese.
Questa tendenza non implica un disimpegno definitivo degli Stati Uniti dal Mediterraneo, come dimostrano il coinvolgimento dell’amministrazione Biden prima e di quella Trump poi nel conflitto a Gaza, il contrasto agli attacchi Houthi contro la libertà di navigazione verso il canale di Suez (Operazione Prosperity guardian), i raid contro le basi dello Stato Islamico in Nigeria nel dicembre 2025 o le recenti attività della quinta flotta nel contenimento dell’Iran. Indica, piuttosto, una crescente ricerca di alleati e partner disposti ad assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza dell’area, come confermato dagli interventi del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth allo Shangri-La Dialogue, dalla composizione del Board of peace per Gaza o, infine, dallo smantellamento di Usaid e dal taglio dell’83% dei suoi programmi.
È controproducente, tuttavia, illudersi che, finito il secondo mandato di Trump, gli Stati Uniti torneranno sui loro passi. Fintantoché non saranno nuovamente chiariti i rapporti di forza tra le grandi potenze, è verosimile che l’ambiente internazionale continuerà ciclicamente a registrare lo scoppio di nuovi focolai di tensione.
Per quanto riguarda le cause efficienti dell’instabilità, a differenza di quanto accade in Europa orientale – dove la minaccia deriva dal rafforzamento dell’apparato statale e militare della Federazione Russa – nel Mediterraneo allargato essa scaturisce da un fenomeno opposto: la fragilità statale. Questa è il prodotto di molteplici fattori: scarsa coesione interna, in particolare l’assenza di un pieno controllo del territorio da parte delle autorità legittime; declino economico e la fuga dei cervelli; incapacità dello Stato di fornire beni pubblici e garantire la rule of law; crescita incontrollata dei trend demografici o presenza di un numero elevato di rifugiati in assenza di risorse adeguate per gestirli.
Lo State fragility index 2025 indica che, tra i primi 23 Paesi più fragili al mondo, 14 insistono sul Mediterraneo allargato: 1. Somalia; 2. Sudan; 3. Sud Sudan; 4. Siria; 6. Yemen; 7. Afghanistan; 10. Ciad; 12. Etiopia; 13. Palestina; 14. Mali; 15. Nigeria; 16. Libia; 19. Niger; 23. Libano.
Tra questi ben quattro – Siria, Libia, Libano e Palestina – si affacciano direttamente sul Mediterraneo e fanno parte del partenariato euro-mediterraneo.
Il World food programme, inoltre, segnala che un terzo della popolazione siriana, la metà di quella palestinese e un quinto di quella libanese vivono in condizioni di crisi acuta o emergenza umanitaria della sicurezza alimentare.
In passato, l’Unione europea e la Nato hanno guardato agli Stati fragili soprattutto come a potenziali incubatori di terrorismo e criminalità transnazionale. Oggi, invece, emerge con maggiore chiarezza che anche potenze ostili all’occidente sfruttano attivamente la fragilità statale per “catturare” gli Stati che ne sono afflitti. L’obiettivo è quello di penetrarli per aumentare la propria influenza nel Mediterraneo allargato e, contestualmente, ridurre quella occidentale. La Federazione Russa, in particolare, sembra orientata verso una vera e propria weaponizzazione degli Stati fragili, un concetto che indica la loro trasformazione in leve strategiche da utilizzare per mettere in discussione la sicurezza europea, attraverso la manipolazione dei flussi migratori, l’uso strumentale delle risorse energetiche e la creazione di basi militari avanzate.
In tale prospettiva, la fragilità della Siria ha consentito alla Russia di consolidare la propria presenza nel Mediterraneo orientale tramite la base navale di Tartus e quella aerea di Latakia, al momento ancora in possesso di Mosca nonostante un cambio di regime sfavorevole. Allo stesso modo, la fragilità della Libia ha favorito il radicamento dell’influenza russa in Cirenaica, dove sono già operative alcune basi aeree – al-Jufrah, al-Khadim e Maaten al-Sarra – e dove si discute della possibile creazione di una seconda base navale a Bengasi, Derna o Tobruk.
È, infine, grazie alla fragilità di molti Paesi dell’area che prima il gruppo Wagner e poi l’Africa corps hanno potuto arruolare nel Mediterraneo allargato combattenti impiegati sul fronte ucraino e potenzialmente destinati a nuovi teatri operativi.
In questo contesto – segnato dal tentativo di disimpegno americano, dalla crescente influenza di potenze rivali e dal proliferare di minacce convenzionali e ibride – l’Unione Europea ha scelto di lanciare il Patto per il Mediterraneo. Questo è fondato su tre pilastri: le persone come forza trainante del cambiamento, delle connessioni e dell’innovazione; un’economia più forte, sostenibile e integrata; sicurezza, preparazione e gestione della migrazione.
Sul piano generale, per l’Italia iniziative come il Patto per il Mediterraneo appaiono guidate da un razionale pienamente condivisibile. Quello di contribuire alla stabilizzazione di un’area, nella quale il nostro Paese è immerso, attraverso progetti di medio-lungo periodo ispirati all’approccio people-to-people e alla logica del local ownership.
Il Patto, inoltre, evita di prospettare un approccio securitario tradizionale – già ampiamente presidiato dalla Nato – riducendo il rischio di duplicazioni e risultando coerente con l’idea di autonomia strategica europea sostenuta dall’Italia.
Si inserisce, d’altronde, all’interno di una serie di progetti – come Global gateway, Partnership for global infrastructure and investment (Pgii) o Imec – pensati per accrescere l’interdipendenza tra Europa, Mediterraneo, Africa e Asia meridionale in termini di sviluppo, connettività e sicurezza.
Implicitamente, il Patto mira infine a prevenire l’ingresso dei Paesi di quest’area in iniziative promosse dalla Repubblica Popolare Cinese e dalla Federazione Russa, offrendo al contempo opzioni alternative credibili. Il riferimento è a progetti come la Belt and road initiative, la Digital silk road o il gruppo Brics, al quale nel 2024 hanno aderito Egitto, Emirati Arabi Uniti ed Etiopia.
Passando poi alle sfide politico-strategiche che prendono forma nei singoli Paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo, un’attuazione concreta del Patto potrebbe produrre risultati particolarmente significativi in Nord Africa.
Sulle coste della Libia, ad esempio, le proposte accennate nel capitolo sulla gestione delle migrazioni potrebbero rivelarsi utili, anche se resta da capire come interagiranno con il nuovo patto dell’Ue sulla migrazione e l’asilo, che entrerà in vigore a giugno 2026. Il Patto, inoltre, potrebbe agevolare la mediazione nel conflitto libico, qualora includesse attori regionali capaci di influenzare le dinamiche interne del Paese, quali Turchia ed Emirati Arabi Uniti.
Ricadute positive possono essere attese anche sull’Egitto, che rappresenta un partner strategico per l’Italia. Basti pensare al dossier energetico o al ruolo centrale del canale di Suez per il nostro import-export. Sebbene il Paese stia uscendo da una fase di gravi difficoltà economiche, è già oggi chiamato a gestire la presenza sul proprio territorio di oltre un milione di rifugiati provenienti dal Sudan. Con ogni probabilità, inoltre, nel prossimo futuro sarà la destinazione anche di nuovi flussi, legati sia alla risoluzione della crisi nella Striscia di Gaza che alle crescenti tensioni tra Etiopia ed Eritrea.
Parimenti importanti sono le proposizioni del Patto sul Mediterraneo per le relazioni con Algeria e Tunisia, soprattutto alla luce della necessità di diversificare fornitori e fonti di approvvigionamento energetico per l’Italia e per l’Europa. In questo quadro, che bilancia transizione energetica e sostenibilità economico-sociale, assumono un valore strategico sia la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, che l’avvio di nuovi progetti. Tra questi, l’interconnessione elettrica Elmed tra Italia e Tunisia, il SouthH2 Corridor per l’esportazione di idrogeno rinnovabile da Tunisia e Algeria verso l’Unione europea, e il progetto MedLink, volto a rafforzare le capacità di produzione di energia rinnovabile nei due Paesi.
Nel Medio Oriente, invece, il lancio del Patto rappresenta un ulteriore passo verso la reintegrazione internazionale della Siria, dopo lo scongelamento della sua partecipazione all’Unione per il Mediterraneo e l’abrogazione del Caesar Syria civilian protection act del 2019 da parte del Congresso americano.
Allo stesso modo, una concreta implementazione del Patto sarebbe altrettanto importante per il Libano, che dalla crisi del 2020 e – ancor di più – a causa della spirale innescata dagli attacchi del 7 ottobre versa in una condizione economica e sociale gravissima.
L’attuazione del Patto con Israele e Palestina, d’altro canto, resta ovviamente vincolata a quella del piano di pace per Gaza, dove una cooperazione più efficace potrebbe essere favorita dall’avvio della ricostruzione sull’intero territorio della Striscia e dalla riduzione delle tensioni intra-palestinesi.
Affinché le iniziative del Patto producano gli effetti attesi, infine, potrebbe rivelarsi cruciale l’inclusione al suo interno delle potenze del Golfo e della Turchia, così come quella dei Paesi balcanici, nel quadro di una strategia volta a rendere l’intero Mediterraneo un’area realmente stabile, sicura e prospera.
Il Patto per il Mediterraneo, in conclusione, potrà risultare tanto più efficace quanto più sarà inserito in un programma ampio e coordinato sviluppato congiuntamente dall’Unione europea, dall’Alleanza Atlantica e dai partner like-minded del Mediterraneo allargato, nell’ambito di un approccio multidimensionale alla sicurezza, capace di integrare risposte di breve periodo, politiche di medio termine orientate allo sviluppo del capitale umano e, nel lungo periodo, grandi progetti di connettività, interdipendenza economica e sicurezza.
In tal prospettiva, una menzione particolare non può che spettare al Piano Mattei, la cui realizzazione dovrebbe procedere in sinergia con quella del Patto per il Mediterraneo.
Non solo perché una quota significativa dei suoi progetti pilota coinvolge già Paesi partner del Patto – come Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia – ma anche perché Piano Mattei e Patto per il Mediterraneo condividono la medesima impostazione di fondo. Entrambe le iniziative, infatti, mirano a rilanciare un partenariato su basi rinnovate, fondato su migrazioni, energia e sviluppo, superando logiche meramente emergenziali o securitarie. L’obiettivo comune è quello di favorire una crescita economica sostenibile nei Paesi partner e, contestualmente, intervenire sulle cause strutturali dell’insicurezza e dell’instabilità, piuttosto che limitarsi a gestirne gli effetti.
In tal senso, uno sviluppo sinergico dei due progetti non rappresenterebbe soltanto un esercizio di coerenza tra iniziative europee e nazionali, ma costituirebbe un moltiplicatore di efficacia politica e strategica, rafforzando il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Mediterraneo allargato.