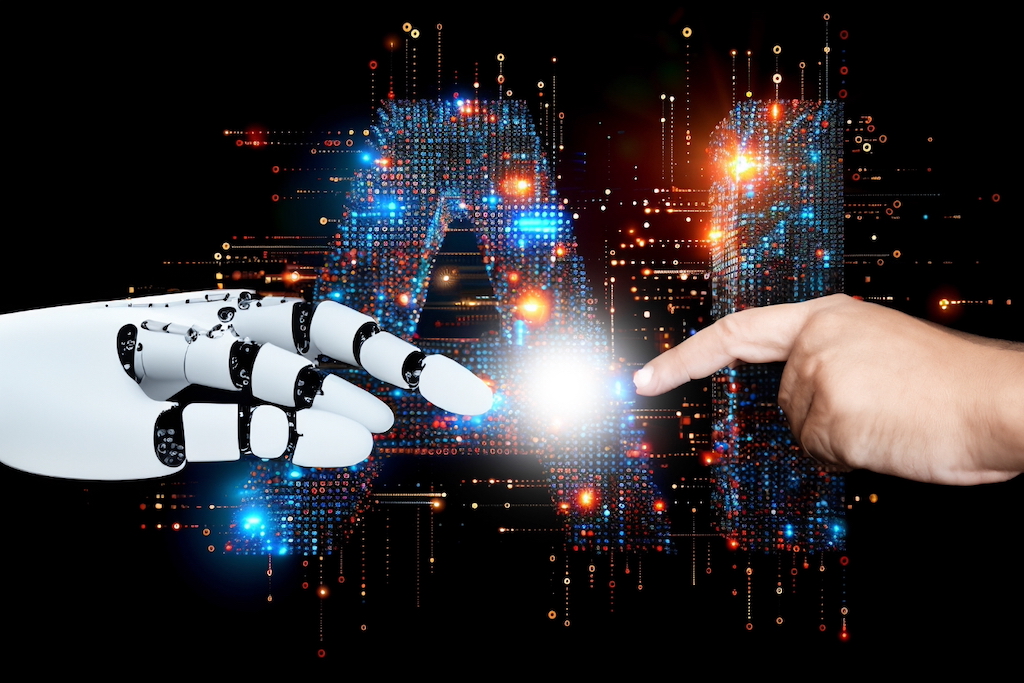Sebbene il tema della brevettabilità dell’AI resti complesso e in evoluzione, l’Europa dispone già oggi di un quadro giuridico solido, in grado di fornire certezze a inventori, imprese e professionisti. Il criterio guida resta sempre lo stesso: la presenza di un vero contributo tecnico, concreto, utile e applicabile nella realtà. L’intervento di Simone Billi, consulente italiano in brevetti, european patent attorney, european patent litigator e capogruppo Lega in Commissione Esteri
Nel pieno della quarta rivoluzione industriale, tecnologie come l’intelligenza artificiale, gli algoritmi avanzati e le simulazioni numeriche stanno trasformando profondamente l’industria, la ricerca e i servizi. Tuttavia, sul piano giuridico, queste soluzioni pongono interrogativi non banali: possono essere oggetto di brevetto? E a quali condizioni?
In Europa il principio di fondo è chiaro: secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo, un’invenzione è brevettabile se è nuova, comporta un’attività inventiva e può essere applicata industrialmente. Alcune categorie, però, sono escluse in quanto considerate astrazioni: è il caso dei metodi matematici, dei programmi per elaboratore e dei metodi per attività mentali o commerciali. Tuttavia, questa esclusione si applica solo nella misura in cui queste attività sono rivendicate “in quanto tali”. È proprio questa formula – apparentemente tecnica – a fare la differenza.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) ha sviluppato negli anni una giurisprudenza articolata per distinguere tra ciò che è puramente teorico e ciò che, invece, produce un effetto tecnico concreto. Un algoritmo o un metodo di intelligenza artificiale non sono brevettabili di per sé, ma possono esserlo se contribuiscono a risolvere un problema tecnico. È il caso, ad esempio, di un software che permette di risparmiare energia, tempo o risorse hardware, a condizione che tali effetti siano misurabili e verificabili.
Le Linee guida dell’Epo contengono la sezione G‑II, 3.3, dedicata ai metodi matematici, presente sin dalla prima edizione del 1978. Nel tempo, tale sezione è stata oggetto di aggiornamenti sostanziali, anche alla luce dell’importante decisione G1/19 dell’Enlarged Board of Appeal. In particolare, sono state introdotte la sezione G‑II, 3.3.1 nel 2018, relativa all’intelligenza artificiale e al machine learning, e la sezione G‑II, 3.3.2 nel 2022, riguardante la simulazione, la progettazione e la modellazione.
La decisione G1/19 ha chiarito che anche le simulazioni digitali, se collegate a una realtà fisica o se impiegate nel controllo di sistemi tecnici reali, possono essere protette da brevetto. Al contrario, simulazioni teoriche o puramente numeriche, se non legate a un impiego tecnico specifico, restano escluse.
Anche per i metodi di addestramento dell’intelligenza artificiale, vale la stessa logica: se sono funzionali al conseguimento di uno scopo tecnico, possono contribuire al carattere brevettabile dell’invenzione. Ad esempio, addestrare un algoritmo per migliorare il funzionamento di un apparato medico o per ottimizzare la gestione di risorse in un sistema informatico può rientrare nei casi ammessi alla tutela brevettuale.
In conclusione, sebbene il tema della brevettabilità dell’AI resti complesso e in evoluzione, l’Europa dispone già oggi di un quadro giuridico solido, in grado di fornire certezze a inventori, imprese e professionisti. Il criterio guida resta sempre lo stesso: la presenza di un vero contributo tecnico, concreto, utile e applicabile nella realtà.