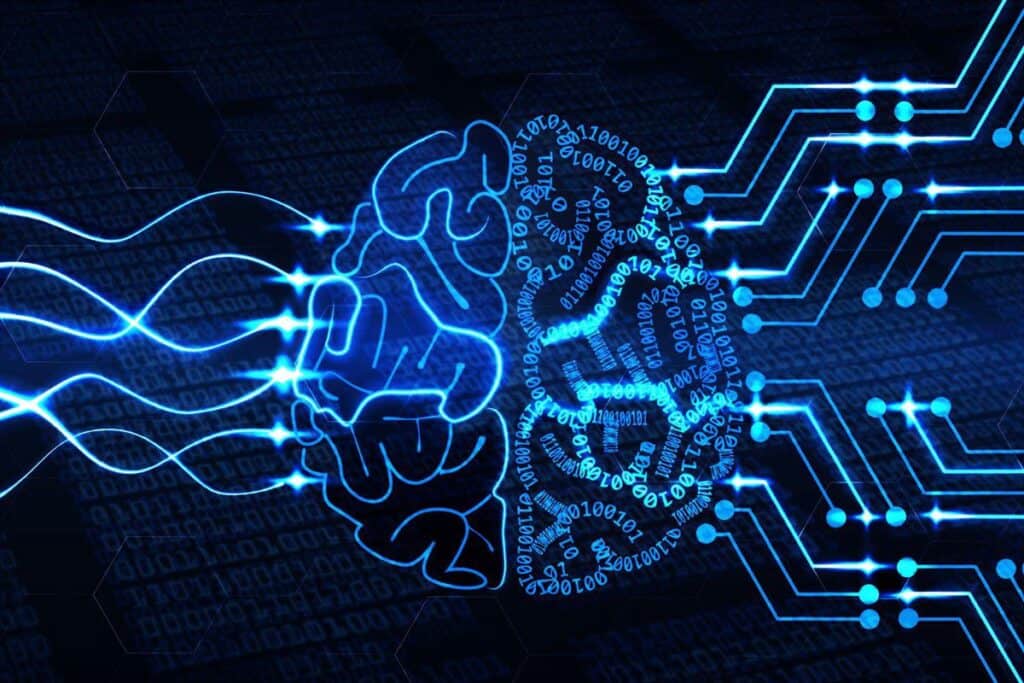Come la lingua di Dante unificò l’Italia spiritualmente prima ancora che politicamente, così un modello linguistico italiano può unire il Paese nella transizione digitale, rafforzando la coesione tra istituzioni, cultura e cittadini. L’analisi di Pasquale Preziosa, membro esperto del comitato scientifico Eurispes
L’Intelligenza Artificiale ha la potenzialità di riscrivere i processi di civilizzazione: quali processi e per chi, tuttavia, non è ancora noto. Ogni civiltà, in ogni epoca storica, ha espresso il proprio potere attraverso una forma linguistica. Il linguaggio non è mai neutro: è la prima infrastruttura della sovranità, il codice con cui un popolo pensa, nomina, interpreta e quindi controlla la realtà. Quando il linguaggio è colonizzato, anche il pensiero lo diventa.
Nell’era dell’intelligenza artificiale, questa antica verità assume una valenza nuova e drammatica. Oggi il linguaggio umano non è soltanto mezzo di comunicazione, ma materia prima dell’economia cognitiva: è ciò da cui si genera valore, informazione, comando e previsione. I grandi modelli linguistici, i Large Language Models (LLM), rappresentano la più recente e profonda trasformazione di questo rapporto tra linguaggio e potere.
Noi affidiamo ormai a questi sistemi una parte crescente della nostra capacità di comprendere il mondo. Essi non si limitano a tradurre o riassumere: modellano la realtà, selezionano ciò che è rilevante, stabiliscono connessioni, ordinano priorità. Sono i nuovi filtri epistemologici dell’umanità. Ogni modello linguistico è una costruzione politica ed etica della conoscenza. Chi controlla il linguaggio delle macchine, controlla anche la forma mentale di chi le usa.
L’Italia, Nazione di cultura e di parola, non può e non deve restare spettatrice di questa rivoluzione cognitiva. Non si tratta di rincorrere l’innovazione tecnologica, ma di preservare la nostra autonomia intellettuale e la nostra identità linguistica, oggi minacciata da un ecosistema digitale dominato da modelli costruiti altrove, secondo valori, categorie e priorità non sempre compatibili con la nostra storia e con il nostro modo di pensare.
Un modello linguistico di grandi dimensioni non è un semplice software, invero è un organismo cognitivo artificiale, addestrato su trilioni di parole, capace di apprendere le relazioni statistiche tra i concetti e di riprodurre, in forma probabilistica, il linguaggio umano.
L’apparente neutralità dell’intelligenza artificiale è, in realtà, una costruzione politica in senso weberiano della conoscenza, essa non descrive la realtà, ma costruisce una certa visione della realtà, conforme a chi l’ha progettata e finanziata. Ogni corpus di addestramento riflette una cultura dominante: ciò che è incluso o escluso, il peso dato a un tipo di fonte rispetto a un altro, l’interpretazione sottesa ai concetti. Chi utilizza questi sistemi accetta implicitamente i presupposti cognitivi e morali su cui essi si fondano. Un modello non è soltanto un intermediario, ma un attore cognitivo che filtra, pesa, orienta. Da questa consapevolezza derivano implicazioni immediate, tanto sul piano culturale quanto su quello della Sicurezza Nazionale.
L’adozione di modelli linguistici stranieri da parte di Stati e istituzioni pubbliche comporta rischi profondi: dipendenza semantica, distorsione culturale, vulnerabilità strategica. Già oggi molti uffici pubblici italiani utilizzano piattaforme di IA estere per redigere testi, tradurre documenti o analizzare dati. Ogni interazione alimenta sistemi di proprietà di soggetti privati stranieri, che ne assorbono i contenuti e li reinvestono in forma di conoscenza algoritmica.
Ciò significa che una parte della nostra produzione linguistica nazionale, e quindi del nostro pensiero, viene esportata e riciclata altrove, perdendo controllo, contesto e finalità. È una forma di estrazione cognitiva: come nel colonialismo industriale si estraevano risorse materiali dalle colonie, oggi si estraggono parole, concetti e dati dalle culture per alimentare economie dell’informazione globali che non rispondono a interessi nazionali.
L’Italia, più di ogni altra terra d’Europa, è nata da un atto linguistico Dante Alighieri, con il De vulgari eloquentia, intuì che una comunità linguistica comune poteva precedere la comunità politica. Quando scrisse che la lingua “è strumento del pensare”, anticipò di secoli la moderna idea che l’identità collettiva sia un fatto semantico prima ancora che geografico.
L’unificazione politica del 1861 fu possibile perché, nei secoli precedenti, la cultura italiana letteraria, giuridica, artistica, aveva già costruito una lingua condivisa. La nostra identità si è imposta con la parola. Il linguaggio è un’infrastruttura strategica, al pari dell’energia o della difesa.
Se la lingua è la materia del pensiero, allora uno Stato che non controlla i propri strumenti linguistici non controlla più la propria mente collettiva.
Vi è inoltre una dimensione di Sicurezza Nazionale. I modelli linguistici assorbono, elaborano e immagazzinano enormi quantità di dati: testi giuridici, documenti amministrativi, comunicazioni istituzionali. Se questi dati vengono trattati da modelli esteri, il rischio di fuga, manipolazione o utilizzo improprio diventa concreto.
Sul piano strategico, un modello nazionale garantirebbe il controllo dei dati, la trasparenza degli algoritmi e la resilienza cognitiva. Potrebbe essere utilizzato per applicazioni cruciali in tutti i ministeri e soprattutto in quello dell’istruzione per sostenere una formazione linguistica e digitale fondata sui valori della nostra cultura. Un modello linguistico nazionale non è un di più: è una infrastruttura di civiltà che alimenta la vita intellettuale di una Nazione ed esprime un atto di continuità storica.
Come la lingua di Dante unificò l’Italia spiritualmente prima ancora che politicamente, così un modello linguistico italiano può unire il Paese nella transizione digitale, rafforzando la coesione tra istituzioni, cultura e cittadini.
È una sfida che riguarda la nostra capacità di esistere nel mondo digitale come soggetto sovrano, non come periferia semantica né dell’anglosfera né della sfera algoritmica cinese, entrambe oggi egemoniche nel plasmare l’immaginario e il linguaggio del cyberspazio globalizzato. Nel campo dell’intelligenza artificiale, l’Italia occupa una posizione intermedia: eccellenze scientifiche e industriali di rilievo convivono con un ritardo strutturale nella capacità di investimento e nella visione strategica.
Per questo, serve una visione di Stato, capace di riconoscere nella sovranità linguistica digitale non un’astrazione, ma un pilastro della Sicurezza Nazionale e dell’identità repubblicana.