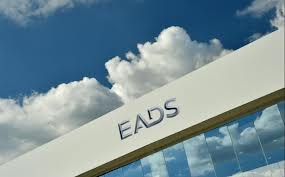Il 27 Ottobre 1964, Ronald Reagan, di fresca uscita dal partito Democratico, pronunció in televisione, a sostegno della campagna presidenziale di Barry Goldwater contro Lyndon Johnson, un famoso discorso dal titolo “Un tempo per decidere” che ancora oggi rimane profondamente esemplificativo della visione del Partito Repubblicano statunitense relativamente al ruolo dello Stato nell’Economia. Tra i molti passaggi degni di nota…
Archivi
L’uscita giapponese dal nucleare è una opportunità per l'Italia
Il 14 settembre il governo giapponese ha annunciato l’arresto progressivo della produzione nucleare da qui al 2040. La decisione, secondo Le Monde, è stata una scelta semi-irrazionale presa sull’onda dell’emozione per l’incidente di Fukushima. A sostegno di questa tesi, il quotidiano dell’Esagono cita le voci del business nipponico, scettiche sulla realizzabilità di un progetto così ambizioso. Essendo comunque passati…
Obama o Romney, Usa e Russia sono lontani
L’amministrazione Obama era ottimista. Il riavvio dei rapporti tra Usa e Russia avvenuto mentre Putin si trovava in una posizione centrale di governo, si faceva notare a Washington, continuerà anche dopo il ritorno al Cremlino del vecchio presidente. Il 26 marzo a Seul, Barack Obama faceva un ulteriore segno di apertura. Discutendo con Medvedev davanti a microblog aperti, il presidente…
Apple, un trionfo per l’iPhone 5 ma attenzione alla volatilità
I numeri parlano di un trionfo. Apple supera oggi i 700 dollari per azione a Wall Street. A fare schizzare il titolo in Borsa è stato il record di vendite dell´iPhone 5. L´azienda di Cupertino ha infatti esaurito la scorta dei nuovi smartphone venerdì, dopo circa un´ora dall´inizio dei preordini. Il successo del nuovo smartphone è testimoniato dal fatto…
Bae - Eads alla ricerca di un nome (Airbus?)
Airbus potrebbe essere il nome della società da 38 miliardi di dollari che nascerebbe dalla fusione dei due colossi dell’aeronautica e della difesa, la franco -tedesca Eads e la britannica Bae Systems, nonostante la preoccupazione che la scelta possa accendere le tensione sia con gli Usa che con la Gran Bretagna. Il nuovo nome, secondo il Financial Times, replicherebbe…
Che cos'è Sum Zero, il social network dei gemelli Winklevoss
I gemelli Cameron e Tyler Winklevoss sono tornati. C’era da aspettarselo. I due giovani che fecero causa a Mark Zuckerberg per aver copiato Facebook da una loro creazione (ConnectU), tornano alla ribalta finanziando SumZero, un social network, ma d’élite. Si perché questa volta non ci sono più vecchi amici da ritrovare ed esperienze da condividere, ma solo progetti da finanziare.…
Parsi: La vera minaccia per l’Occidente è un attacco di Israele
L’amministrazione di Barack Obama ha smesso di sostenere i dittatori del mondo arabo e questa scelta è tornata contro gli Stati Uniti. Per Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore, “il vuoto, la mancanza di un nemico interno ha spinto le popolazioni del Nord Africa a combattere contro un nemico esterno”. E in questo caso…
Le mire di Mr. Tod's e il gioco delle parti con Montezemolo
Fiat, sempre Fiat, fortissimamente Fiat. Ormai non si parla d’altro nell’italico circo mediatico, da quando, venerdì scorso, Diego Della Valle, padrone della Tod’s e azionista in varie società considerate strategiche come RcsMediaGroup, ha fatto uno shampoo alla Real casa torinese, accusandola in sostanza di essere inconsistente e incapace, una famiglia di furbetti che pensa solo al proprio piccolo, immediato interesse…
Polverini, una risata la seppellirà?
L’inondazione di Firenze del 1966, la Costa Concordia che si schianta al largo del Giglio, tumori come quelli della sua gola da estirpare. È un discorso duro, durissimo quello che la Presidente della Regione Lazio Renata Polverini ha pronunciato per prendere le distanze dalla “banda della Pisana”, come hanno ribattezzato su twitter lo scandalo delle spese con troppi zero che ha coinvolto…