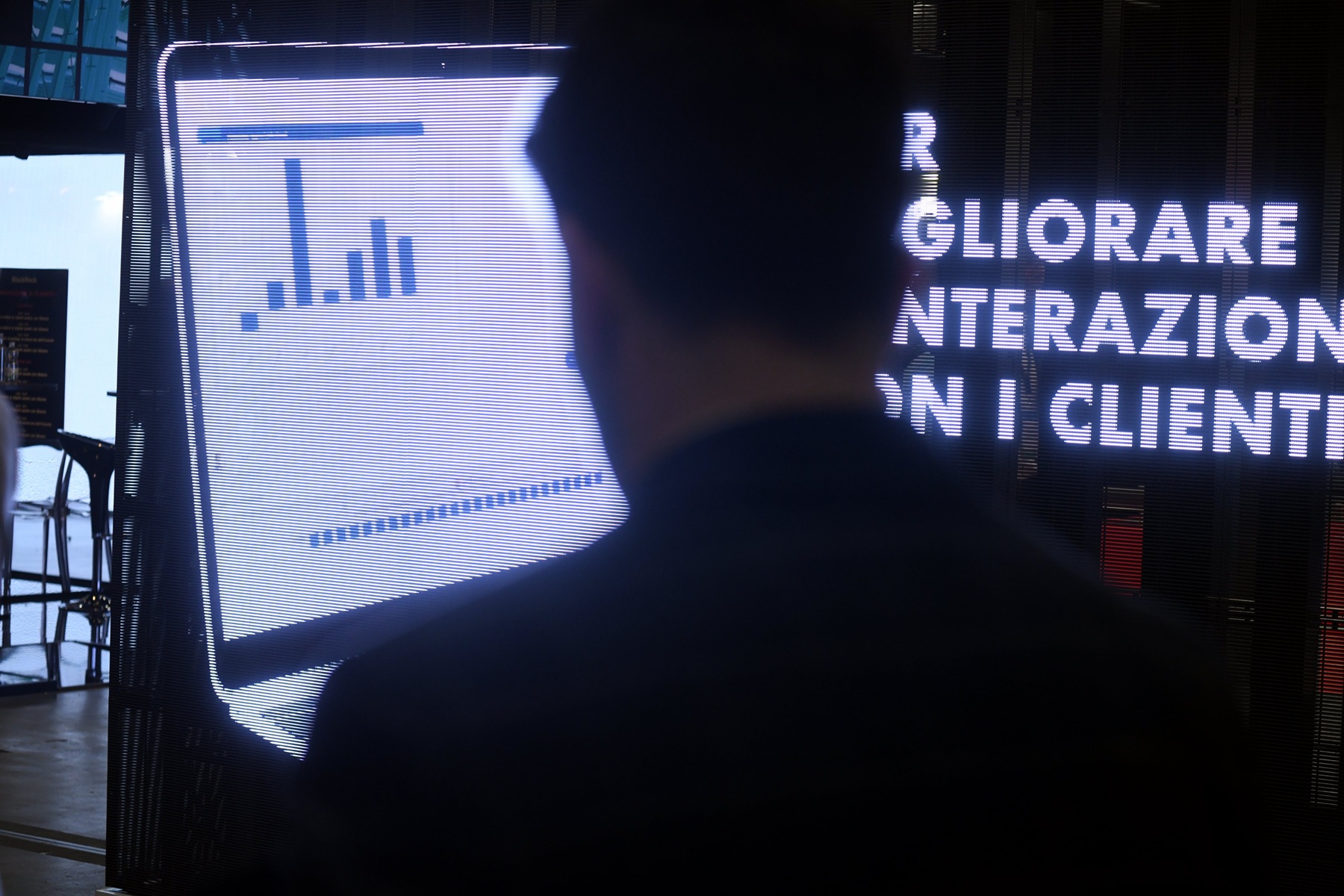I simboli contano, e le priorità culturali si indicano anche con i simboli. Difficile che Lampedusa possa essere il primo viaggio di papa Leone, ma intanto sappiamo che è sua intenzione andarvi, e le intenzioni contano, vanno considerate, capite. La riflessione di Riccardo Cristiano sul videomessaggio del pontefice inviato alla presentazione della candidatura del progetto “Gesti dell’accoglienza”, dell’isola siciliana, alla lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco
Archivi
L’attacco israeliano al Qatar segna la fine degli Accordi di Abramo. Scrive Mezran
L’attacco israeliano al Qatar apre un nuovo capitolo di tensioni in Medio Oriente. La crisi rischia di travolgere definitivamente gli Accordi di Abramo e di ridisegnare alleanze e schieramenti nella regione. Ecco perché secondo Karim Mezran, director della North Africa Initiative dell’Atlantic Council e resident senior fellow del Rafik Hariri Center & Middle East programs
Breve riflessione sul riordino delle agevolazioni fiscali. Il commento di De Luca
La razionalizzazione delle agevolazioni fiscali deve tradursi in una revisione strutturale delle spese fiscali. È necessario, quindi, agire su tutte le misure in essere per trasmettere un chiaro e netto messaggio di equità dello sforzo riformatore. Il riordino delle agevolazioni fiscali non può, pertanto, che avvenire nell’ambito di una riforma fiscale ampia ed organica. Il commento di Vincenzo De Luca, responsabile Fisco di Confcommercio
L'incursione dei droni russi in Polonia: una lezione di guerra ibrida
La notte tra il 9 e il 10 settembre 2025 ha segnato un momento spartiacque nella storia recente della Nato. Per la prima volta dalla guerra in Ucraina, droni russi hanno violato massicciamente lo spazio aereo di un Paese membro dell’Alleanza Atlantica, costringendo la Polonia a invocare l’Articolo 4 del Trattato Nato e aprendo interrogativi profondi sulla natura stessa della guerra moderna. L’analisi del generale Ivan Caruso, consigliere militare della Sioi
Il ruolo della stablecoin basata sullo yuan nella strategia cinese globale. L'analisi di Monti
L’annuncio della possibile emissione di una stablecoin basata sullo Yuan suggerisce che Pechino stia valutando un nuovo passo verso il distacco dal sistema monetario controllato dagli Usa per affermare la propria moneta come una risorsa globale. Il punto di Andrea Monti, docente di identità digitale, privacy e cybersecurity presso Sapienza, Università di Roma
Così la Danimarca protegge i suoi cieli con il sistema franco-italiano
La Danimarca ha scelto il sistema di difesa aerea franco-italiano Samp/T Ng, rafforzando le proprie capacità difensive e il ruolo strategico dell’Italia nella difesa europea. Con Mbda e Leonardo coinvolte, il progetto evidenzia l’eccellenza industriale italiana e promuove una cooperazione europea più autonoma e integrata
L'elettrico arretra, l'ibrido corre. La possibile beffa per la Cina secondo Goldman Sachs
Nei prossimi anni l’alimentazione ibrida, che concilia benzina con elettrico, potrebbe superare per vendite il motore green per eccellenza. Tutto a discapito della Cina che con Byd sta puntando alla disintegrazione dei mercati concorrenti
Il credito alle famiglie non si ferma. Report Abi
A dispetto dei venti di burrasca che soffiano in Francia, ad agosto 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione rispetto al +1,3% del mese precedente
Trump pressa la Nato. Stop al petrolio russo e sanzioni comuni
Trump chiede ai Paesi Nato di fermare gli acquisti di petrolio russo e adottare sanzioni comuni contro Mosca, minacciando dazi fino al 100% sulla Cina. L’appello arriva mentre l’Alleanza rafforza il fianco orientale dopo l’incursione di droni russi in Polonia
Transizione ed economia circolare. Le Giornate dell'energia a Trevi
A Trevi il confronto tra mondo della ricerca, imprese, giovani generazioni e operatori dell’informazione convenuti per l’appuntamento annuale delle Giornate dell’Energia e dell’economia circolare, promosse da Globe Italia e dal World Energy Council Italia, che si chiudono oggi