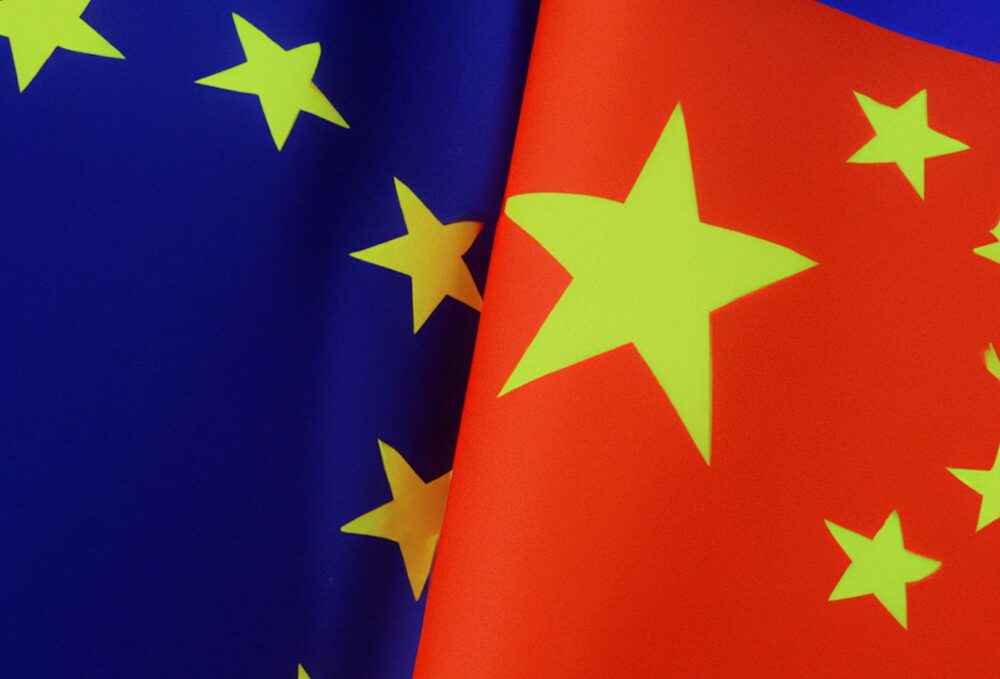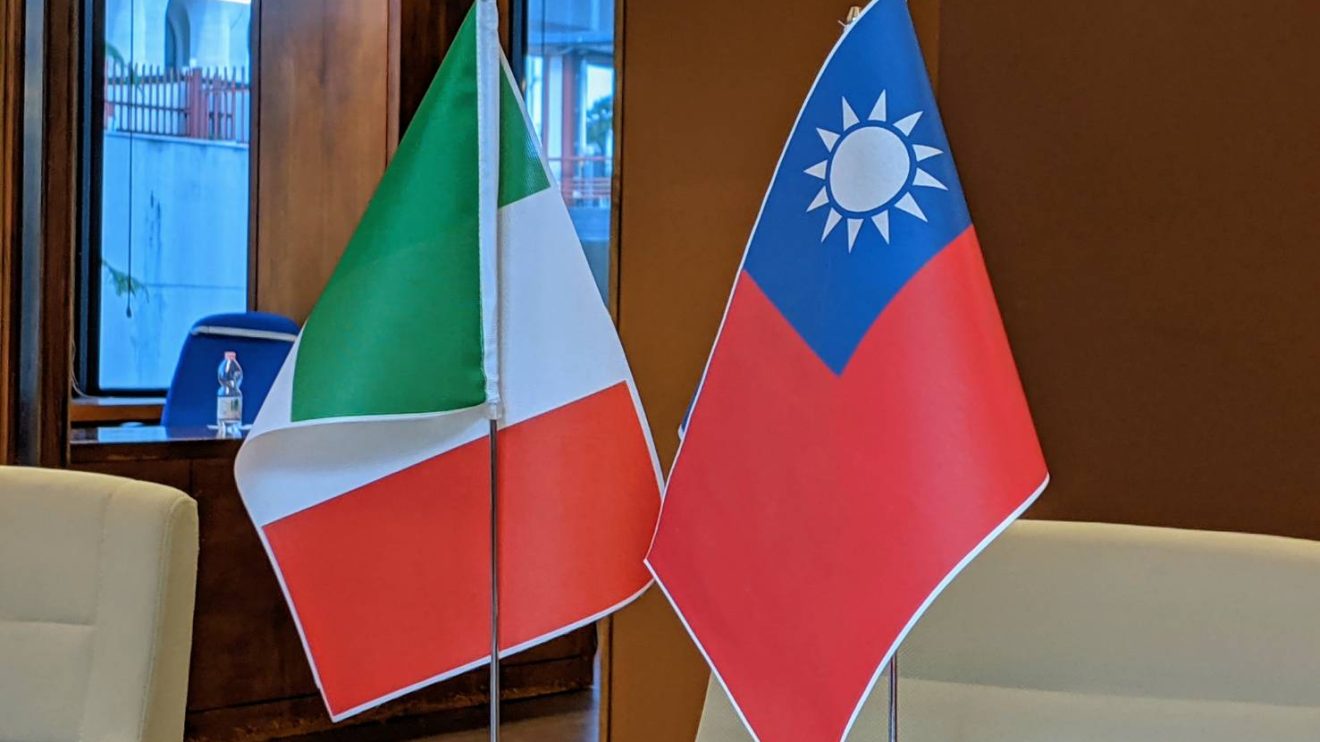La formula dell’art. 5 è senz’altro il principale termine di riferimento per immaginare gli impegni di sicurezza occidentali in favore dell’Ucraina. Tuttavia essa è una clausola che potrebbe non adattarsi agli ordinamenti costituzionali dei Paesi che la adottassero per Kyiv. Più correttamente, se si vuole pensare ad un precedente, bisognerebbe guardare alla garanzia dell’indipendenza (e neutralità) maltese che l’Italia ha assunto con l’accordo del 1980. L’analisi dell’ammiraglio Fabio Caffio
Archivi
Copie americane degli Shahed-136 per testare nuove difese anti-drone. Il piano dell'Usaf
La guerra in Ucraina spinge gli Stati Uniti a studiare da vicino lo Shahed-136 per esser pronti a contrastarlo in modo efficiente. Un bando dell’Air Force richiede copie identiche del drone iraniano usato da Mosca per testarne le caratteristiche e rafforzare i propri programmi di difesa aerea
Disabilità e Intelligenza artificiale. Le prospettive del disegno di legge del governo secondo Girelli
Quel che pare emergere dalla lettura complessiva del testo all’esame del Senato è la fissazione di un divieto generalizzato di arrecare danno alle persone con disabilità nel momento in cui si impiegano sistemi di intelligenza artificiale. Divieto che poi trova il suo risvolto “in positivo” nelle previsioni che stabiliscono l’utilizzo dell’IA al solo scopo di supportare le persone con disabilità e di migliorarne, anzi, le condizioni di vita. L’intervento di Federico Girelli, professore di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi Niccolò Cusano – Roma
Le quattro linee guida dell’Havel Dialogue per evitare il condizionamento cinese in Europa
Il messaggio dell’Havel Dialogue è chiaro: l’Europa deve collaborare con partner affini per non trasformare l’influenza economica cinese in uno strumento di condizionamento politico e di erosione delle democrazie occidentali
Modi, prove tecniche da leader globale. Scrive Arditti
Mentre Trump e Putin trattano in Alaska, Modi parla al mondo. La sua India non è solo un gigante demografico, ma una potenza che detta le proprie regole, protegge i propri confini e produce le proprie tecnologie. In 103 minuti, il premier traccia una rotta che fa di Nuova Delhi un attore centrale in un mondo frammentato, capace di dialogare con l’Occidente senza sottomettersi e di contenere la Cina senza conflitti aperti
Mentre i leader discutono, la Nato fa il punto sulla situazione sul campo in Ucraina. I dettagli
Il Comitato militare della Nato si è riunito oggi in videoconferenza sotto la presidenza dell’ammiraglio Cavo Dragone, con la prima partecipazione del nuovo comandante supremo in Europa Grynkewich. Al centro, la sicurezza dello spazio euro-atlantico e l’evoluzione della guerra in Ucraina. La sessione segue gli incontri diplomatici che hanno aperto a possibili trattative per la fine del conflitto
La forza di Trump si misurerà sulla capacità di ridimensionare le richieste di Putin. Parla Rosato
La forza persuasiva di Trump, sostiene Ettore Rosato, vicepresidente di Azione e membro della III Commissione (Affari Esteri e Comunitari), “non si misurerà sulla capacità di convincere Zelensky ad accettare una resa, ma di ridimensionare le aspettative di Putin: serve un accordo di pace, non una resa incondizionata di Kyiv”
Il Flamingo rappresenta una svolta per Kyiv. Ecco perché
Il nuovo sistema permette a Kyiv di estendere la propria capacità offensiva ben oltre le armi fornite dagli alleati, ottenendo un margine di autonomia strategica che le consente di colpire obiettivi sensibili all’interno della Russia senza vincoli politici esterni
Europa, guerra ed economia. Di cosa si parlerà al Meeting 2025
Il Meeting di Rimini, giunto alla sua 46ª edizione, torna a essere il crocevia del confronto politico nazionale e internazionale. Dal 22 al 27 agosto, alla Fiera di Rimini, sfileranno i principali protagonisti della vita istituzionale italiana, ma anche figure di primo piano dell’Europa e del mondo ecclesiale. Tra gli ospiti anche Meloni, Salvini, Tajani, tanti ministri, l’ex premier Draghi, il cardinale Zuppi e Daria Perrotta. Tutto il programma
L’Italia supporti l’identità di Taiwan, dalla politica alla cultura. Parla l'amb. Tsai
Taiwan rivendica la propria identità e la difende su più piani: culturale, politico, tecnologico. L’ambasciatore Vicent Tsai sottolinea come l’Italia, con la sua tradizione diplomatica e il suo peso culturale, possa essere un partner strategico in questo percorso