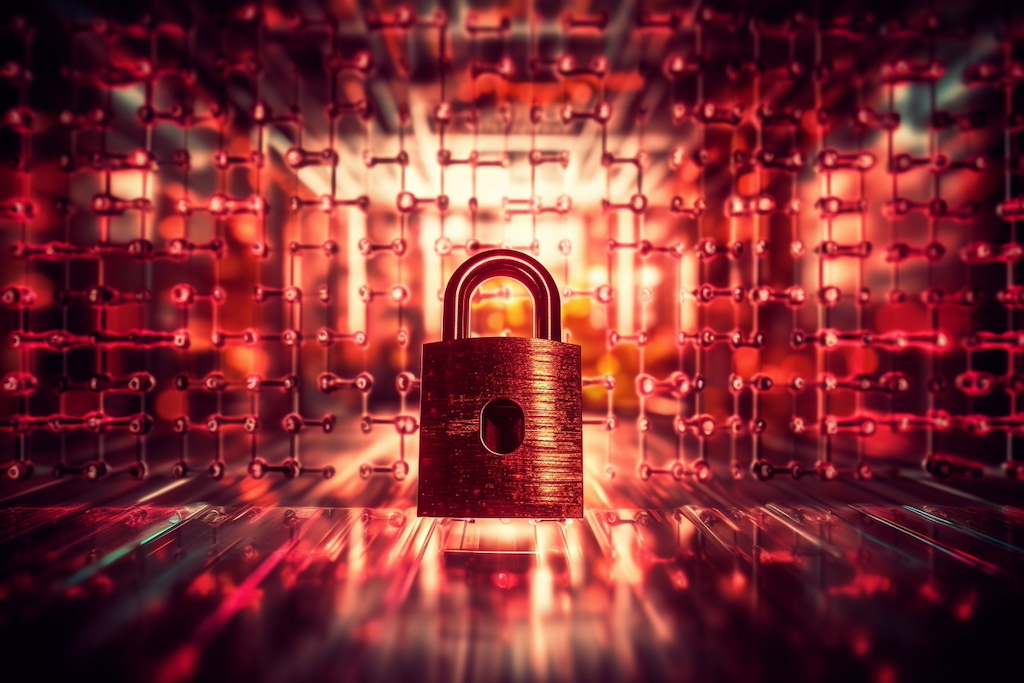Le democrazie liberali, basate su pluralismo e libertà di espressione, mostrano una vulnerabilità intrinseca: la loro apertura può essere sfruttata da attori ostili per diffondere disinformazione e amplificare divisioni interne. Il nuovo report dello European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats ne spiega le modalità
Archivi
L’Ue cerca di salvarsi dalla morsa del Dragone. Basterà un summit?
Tra poche ore Ursula von der Leyen stringerà la mano a Xi Jinping, provando a rimettere le relazioni tra Dragone e Vecchio continente in un’ottica costruttiva. Ma i nodi da sciogliere sono tanti, dalle banche ai dazi, passando per l’automotive
Il peso strategico dell’asse Roma-Algeri per lo scenario euromediterraneo
Il vertice di oggi a Roma è molto più di un appuntamento bilaterale: è la fotografia di un Mediterraneo che cambia, di un’Europa che cerca di ripensare la propria presenza nel Nordafrica e di un’Italia che, consapevole della posta in gioco, prova a guidare questo processo. Rafforzare l’alleanza con l’Algeria significa consolidare una partnership storica, ma anche aprire nuove traiettorie per la sicurezza e lo sviluppo dell’intera regione
Così Meloni ha dato credibilità internazionale all'Italia, ora via con economia e riforme. Parla Zeneli
La premier italiana ha consolidato la reputazione internazionale del Paese su temi chiave come l’allineamento transatlantico e il rapporto con l’Ue, la guerra in Ucraina e la relazione con la Cina. Secondo Valbona Zeneli (Atlantic Council) adesso serve anche un cambio di passo sull’economia e le riforme
Usa-Giappone, perché il deal sui dazi interessa l’Ue
Usa e Giappone siglano un accordo commerciale che riduce i dazi e rilancia gli investimenti, mentre l’Europa resta esposta alle tensioni transatlantiche. La mossa rafforza Tokyo ma evidenzia la reattività limitata di Bruxelles
Ritorno alla Luna, così la corsa allo spazio si fa palcoscenico per le potenze del futuro
Lo Spazio torna a essere un terreno di competizione strategica ed economica, dove l’Italia si muove per consolidare il proprio ruolo con strumenti normativi moderni, un’industria diffusa e alleanze bilaterali. Dalla dimensione militare alle prospettive economiche, la nuova corsa allo Spazio (e alla Luna) coinvolge sicurezza, innovazione e visione geopolitica. L’evento organizzato da Formiche e Airpress è stata così l’occasione per un confronto aperto tra istituzioni, Forze armate e sistema industriale ha delineato le sfide e le opportunità per il Paese
Istanbul riapre il tavolo della pace tra Ucraina e Russia, ma nessuno crede nel miracolo
Dopo due tornate fallite, Ucraina e Russia ci riprovano a Istanbul. I colloqui, focalizzati su temi umanitari, arrivano in un contesto di escalation militare e con un Cremlino che non sembra credere in una tregua a breve termine
La spinta di Trump funziona. Investimenti record della farmaceutica negli Usa
Manifattura e ricerca farmaceutica sono pronte a tornare negli Stati Uniti, con una spinta che sta ridisegnando la geografia dell’industria. L’effetto Trump ha portato i piani di investimento dei principali attori del comparto a superare i 300 miliardi di dollari
Eni, Sparkle, Menarini e non solo. Tutti gli accordi tra Italia e Algeria
Il Forum imprenditoriale italo-algerino, costola del vertice inter-governativo di scena a Roma, porta in dote una serie di intese tra le reciproche imprese, che mirano a rafforzare i legami industriali tra i due Paesi. E non c’è soltanto l’energia
Come la Cina si sta preparando silenziosamente alla cyberwar. Scrive Teti
Nel nuovo paradigma della guerra moderna, Pechino ha già occupato digitalmente il campo di battaglia. L’assenza dei suoi hacker dalle competizioni internazionali non era casuale: era l’inizio di una dottrina centrata sul controllo informatico globale. Dati, telefoni, infrastrutture: tutto è un potenziale bersaglio. E ogni linea di codice può diventare un’arma