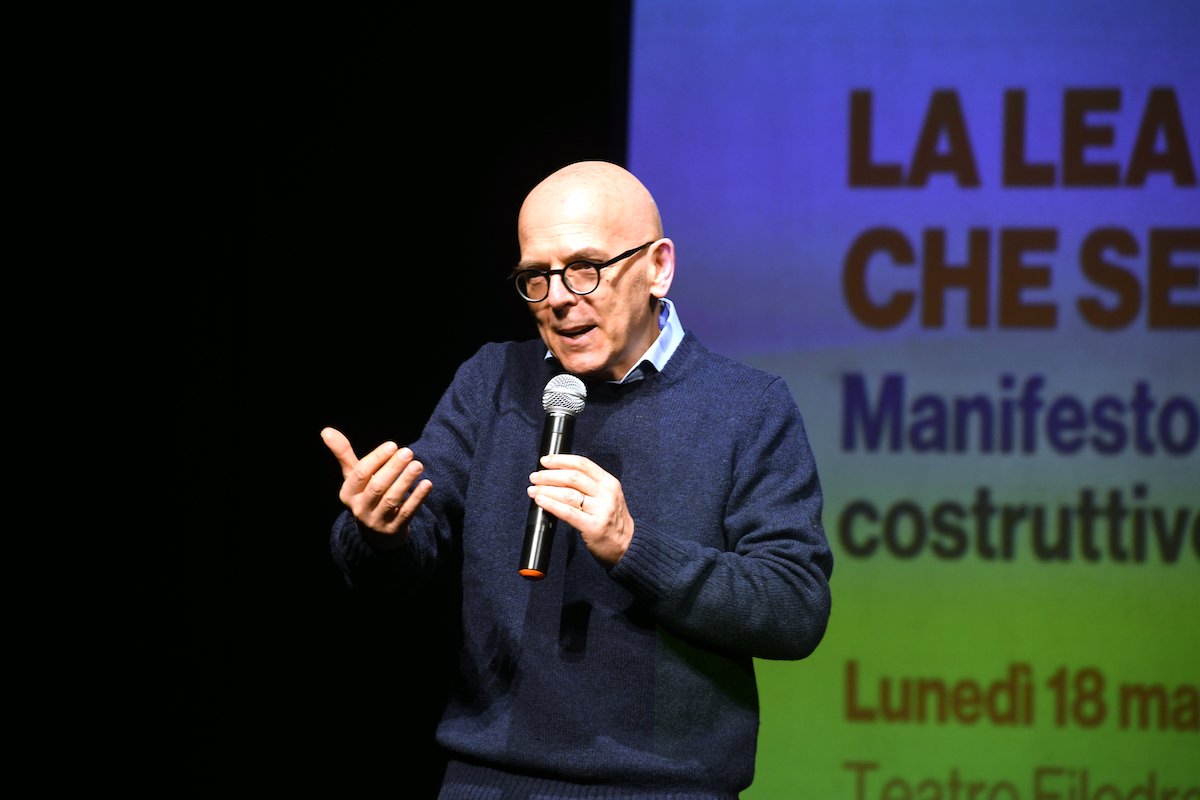La sentenza n. 28/2025 della Corte costituzionale boccia la moratoria della Regione Sardegna sugli impianti da fonti rinnovabili, riaffermando la priorità degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali. Sarebbe riduttivo attribuire alla decisione una valenza circoscritta alla questione sarda. Essa, piuttosto, si presta a fare da sfondo per diversi importanti temi di scala nazionale. L’analisi di Massimiliano Atelli, presidente Commissione Via Pnrr Pniec del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica
Archivi
Phisikk du role - Dalle piazze può nascere una nuova identità democratica
Di
Qualcuno ha scritto: son tornati in piazza i ceti medi nel nome dell’Europa. Forse è vero: se i ceti medi sono l’asse portante della democrazia, la loro scomparsa, o il loro dileguamento, rappresenta la difficoltà principale della democrazia e la sua sconfitta ad opera della cacofonia populista. Ma forse ancora c’è speranza. La rubrica di Pino Pisicchio
Il gioco delicato di Meloni per conservare la credibilità. Scrive Arditti
Di
La Lega aiuta Meloni nell’evitare la nascita di una forza politica di destra critica verso il governo (ad esempio ci ha provato Gianni Alemanno), questo il premier lo sa benissimo. Ma sa anche altrettanto bene che mezzo mondo misura quotidianamente la distanza politica tra lei e Salvini: oltre un certo numero di centimetri comincia il problema
Così Putin dal 2007 punta a destabilizzare l’Est Europa. L’analisi del gen. Caruso
Di
Nel febbraio 2007, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il leader russo pronunciò un discorso che avrebbe delineato la futura strategia geopolitica di Mosca. A distanza di quasi due decenni, quelle parole si sono tradotte in azioni concrete che hanno ridisegnato gli equilibri internazionali. Quella visione si sta materializzando nel tempo, dalle guerre in Georgia e Ucraina fino alle recenti operazioni di destabilizzazione in Romania. Precedenti sufficienti per tracciare le possibili future mosse del Cremlino in un mondo sempre più multipolare. L’analisi del generale Ivan Caruso, consigliere militare della Sioi
Segnali di pace in Ucraina. I pilastri della trattativa secondo l’amb. Castellaneta
Di
Dopo anni di guerra in Ucraina, emergono segnali di pace grazie a negoziati internazionali. Si punta a una soluzione rispettosa del diritto internazionale, mentre l’Europa e l’Italia cercano un ruolo più centrale nella Nato e nella geopolitica globale. Il commento dell’ambasciatore Giovanni Castellaneta
Gladio e mio padre, quella chiamata di Cossiga la notte di Natale. Il racconto di Follini
Di
Notte di Natale, in casa Follini squilla il telefono: è l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. In quella conversazione viene svelato al futuro vicepresidente del Consiglio, che suo padre sarebbe stato uno dei capi dell’operazione Gladio. Da questa conversazione prende le mosse Beneficio d’Inventario (Neri Pozza) un’originale ricognizione su quegli anni industriosi e irripetibili, tra potere e politica. Colloquio con l’autore
Viva la piazza del Popolo europeista ma attenzione a… Scrive Mayer
Di
Numerosi oratori hanno evidenziato l’importanza del sostegno all’Ucraina e della difesa comune europea. Tuttavia, sono emerse alcune criticità, come l’equivalenza di giudizio tra Stati Uniti, Russia e Cina, e la sottovalutazione del ruolo della Nato. Il commento di Marco Mayer
Intelligenza artificiale e sostenibilità, una conciliazione necessaria. Parla Palmieri
Di
Riprende il ciclo di incontri dedicati all’intelligenza artificiale generativa organizzato dalla Fondazione Pensiero Solido. Il presidente Antonio Palmieri introduce la sfida del primo evento: come trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e sostenibilità
Tutti i dilemmi della Trumponomics spiegati da Polillo
Di
Il ritorno al protezionismo, nel mito dell’autarchia, appare una scelta antistorica, se non addirittura oscurantista. È troppo presto parlare di una possibile bocciatura della trumponomics e degli eccessi di Elon Musk. Ma intanto il barometro dei principali centri finanziari segna burrasca. La riflessione di Polillo
Nella corsa alle materie prime l’Ue non fa abbastanza. Report Euiss
Di
Il nuovo report dello EU Institute for Security Studies evidenzia la lentezza delle politiche europee nel de-risking delle catene di fornitura di materie prime critiche, fondamentali per la difesa, il settore medico e le transizioni digitali e ambientali. Investimenti finanziari, ricerca e cooperazione internazionale emergono come misure essenziali per rafforzare la sicurezza strategica del continente