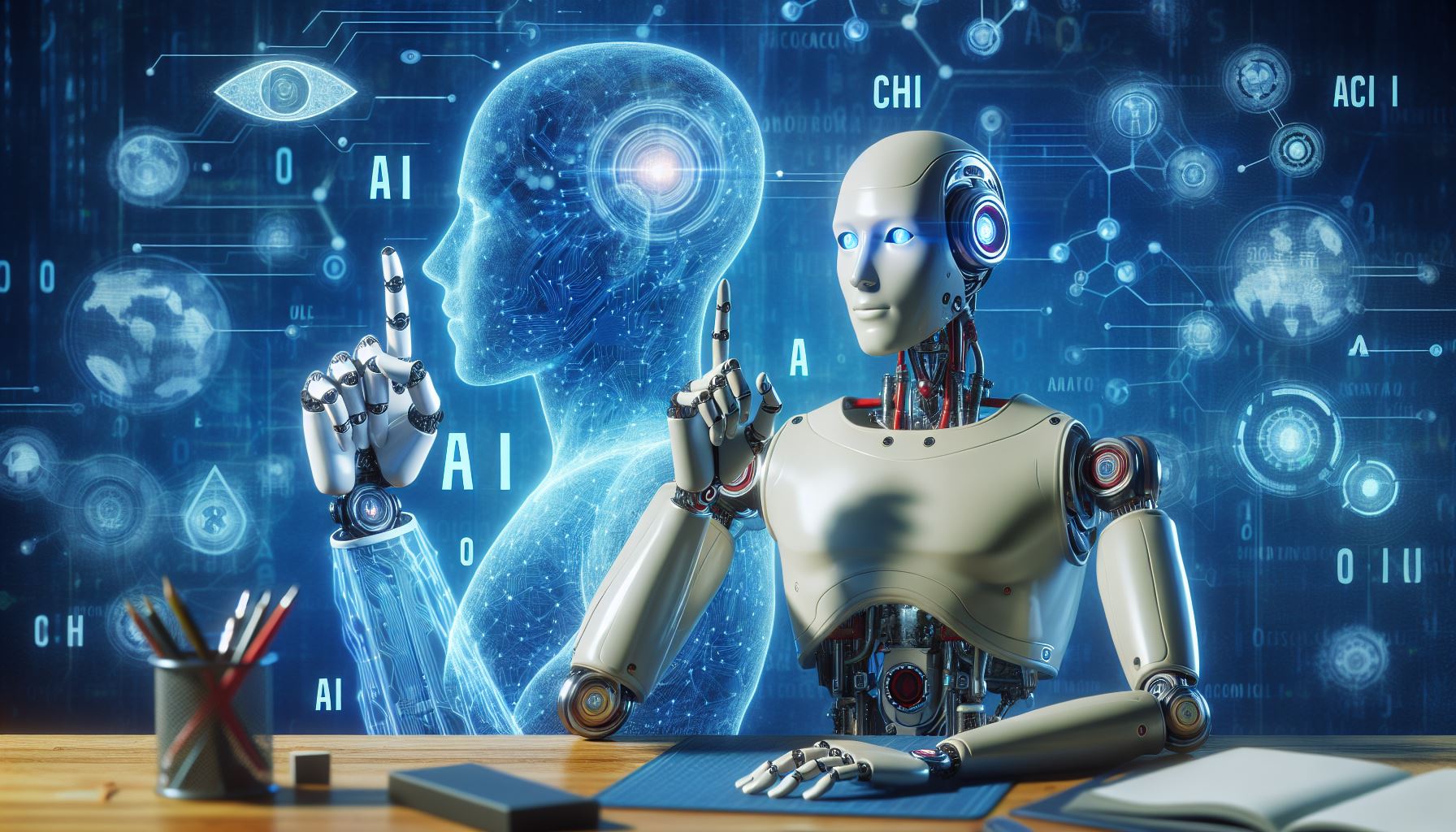Il mondo resta instabile e privo di una pace duratura, tra potenze armate e in competizione. La deterrenza, soprattutto quella nucleare, svolge un ruolo cruciale nel prevenire conflitti su larga scala, nonostante la sua efficacia appaia oggi più fragile. Forse, paradossalmente, serve più deterrenza, non meno. L’analisi di Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes
Archivi
Cosa cambia per Usa e Cina con un papa americano. L'analisi di Sisci
Il nuovo pontefice accorcia la distanza tra Vaticano e Washington imprimendo una nuova dinamica agli Stati Uniti e al mondo. La Cina ne è fuori con conseguenze ancora confuse. Il commento di Francesco Sisci
Leone XIV. Prospettive di un papato di opere, fede e miracoli
Un papato al galoppo alla guida di una Chiesa nuovamente baricentro del mondo. È l’impressione che ha lasciato il discorso dell’appena eletto papa Leone XIV. Premessa dell’incisività annunciata del terzo pontificato dall’inizio del secolo. L’analisi di Gianfranco D’Anna
Cessate il fuoco. Trump annuncia l’intesa tra India e Pakistan
Dopo quattro giorni di combattimenti lungo la Linea di Controllo, India e Pakistan hanno siglato un cessate il fuoco immediato. La tregua ha permesso la riapertura completa dello spazio aereo pakistano e raccolto l’apprezzamento delle Nazioni Unite
IA e giornalismo, quale bussola per navigare il cambiamento. Scrive Stazi
L’IA è sempre più integrata nel giornalismo, dalla produzione di contenuti alla ricerca di informazioni, migliorando l’efficienza e supportando la creatività. Tuttavia, questa evoluzione solleva anche questioni critiche che devono essere affrontate per garantire un uso etico e efficace della tecnologia. Il commento di Andrea Stazi (senior advisor external relations, Multiversity)
Come evolverà il rapporto tra potere terreno e spirituale nell’America di Trump
La scelta di un Papa americano introduce una nuova dinamica tra il potere politico degli Stati Uniti e quello spirituale della Chiesa cattolica. Il commento di Gianfranco Polillo
Il coraggio di decidere. La sicurezza europea tra sondaggi e politica
La politica europea è sempre più dominata da sondaggi e percezioni invece che da analisi e decisioni strategiche. Difesa, sicurezza, relazioni internazionali: affrontare la realtà richiede coraggio e visione. Ma la leadership è davvero pronta a scegliere?
Dagli Houthi a Israele. Trump prepara il viaggio nel Golfo
L’accordo tra Stati Uniti e Houthi, voluto da Trump, riduce la tensione nel Mar Rosso ma esclude Israele, lasciandolo un po’ più isolato in un conflitto che resta legato alla guerra a Gaza. Intanto, la fragile tregua americana non risolve le radici politiche del conflitto yemenita
L’Ue (con la guida italiana) può sfruttare l’apertura di Trump a Londra. Scrive l’amb. Castellaneta
L’intesa rappresenta un segnale di apertura da parte di Washington, che sembra pronta a negoziare anche con Bruxelles. I 27, guidati anche dall’Italia, hanno l’opportunità di sfruttare questo clima di dialogo per negoziare accordi vantaggiosi. E la recente elezione di Leone XIV ha ispirato un clima di dialogo, che potrebbe contribuire a risolvere tensioni globali. Il commento dell’ambasciatore Giovanni Castellaneta
Perché Leone XIV può ricucire i rapporti fra Usa e Vaticano. L'analisi di Faggioli
Con il nuovo papato si apre una stagione del tutto nuova per la Chiesa. Dal primo discorso emergono elementi di continuità con il predecessore, ma anche di discontinuità. Il fatto che sia americano rappresenta una svolta importante, probabilmente anche una risposta all’attuale corso della politica statunitense. Leone XIV lavorerà per ricucire i rapporti fra Usa e Vaticano. Colloquio con Massimo Faggioli, docente di Teologia e Studi religiosi alla Villanova University in Pennsylvania