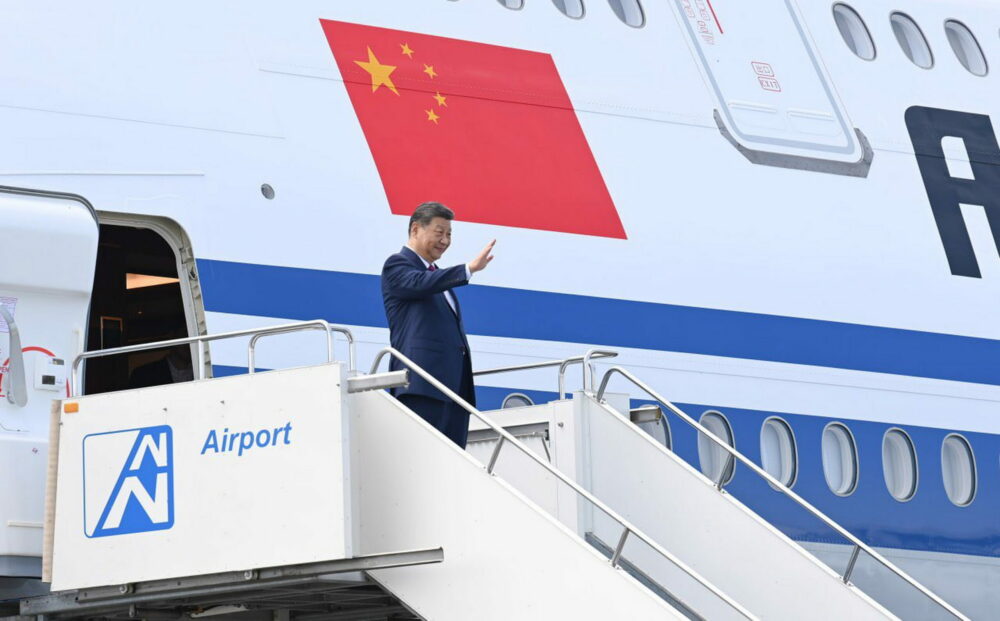Esaltando sopra ogni cosa la lealtà di Hu, la sua accettazione della disciplina di Partito, la sua incorruttibilità e la sua attenzione per “il popolo”, Xi impone un copione implicito su come l’attuale classe dirigente politica e militare deve comportarsi. Niente deviazioni, niente fazionalismi, solo obbedienza al leader e omologazione alla sua “linea”. L’analisi di Enrico Fardella, professore dell’Università di Napoli L’Orientale, direttore del progetto ChinaMed e adjunct professor alla Johns Hopkins University Sais Europe e Associate Director del Guarini Institute alla Johns Cabot University
Il 20 novembre, nella Grande Sala del Popolo a Pechino, il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha organizzato un simposio per commemorare il 110° anniversario della nascita di Hu Yaobang. Sul palco, nelle sue tre vesti di segretario generale del Pcc, presidente della Repubblica popolare e capo della Commissione militare centrale, Xi Jinping ha tenuto un “importante discorso”, invitando il Partito a studiare con serietà lo “spirito nobile” e lo “stile di lavoro esemplare” del vecchio leader riformista.
A prima vista potrebbe sembrare l’ennesima liturgia della memoria selettiva con cui il Pcc archivia i suoi fantasmi. Ma per capire che cosa significhi davvero, nel 2025 di Xi, tornare a celebrare Hu Yaobang, bisogna riavvolgere il nastro e tornare sia alla sua figura, sia al rapporto che lo legava a Xi Zhongxun, il padre dell’attuale leader.
Hu (1915–1989) è il quadro di vecchia guardia che all’inizio degli anni Ottanta diventa segretario generale del Partito e, di fatto, il volto politico della “riforma e apertura” denghista. È lui a spingere per la riabilitazione delle vittime delle campagne maoiste – Xi Zhongxun compreso –, a promuovere una nuova generazione di quadri più giovani e istruiti, a tollerare discussioni intellettuali e timidi esperimenti di liberalizzazione politica. Per molti cinesi di quella generazione, Hu rappresenta l’idea che il Partito potesse cambiare se stesso senza crollare, correggere i propri errori senza perdere il potere.
Proprio per questo, però, diventa anche il bersaglio naturale degli anziani conservatori, che vedono nelle sue aperture il preludio di una perdita di controllo sull’apparato. Nel gennaio 1987, dopo le proteste studentesche di fine 1986, Hu viene costretto alle dimissioni. Il processo è umiliante: riunioni di critica, accuse di “liberalismo borghese”, isolamento politico. Due anni più tardi, la sua morte improvvisa, nell’aprile 1989, scatena un’ondata di cordoglio che si trasforma in protesta politica: migliaia di giovani si riversano a Tian’anmen per rendergli omaggio, e da lì si avvia la spirale che porterà al massacro di giugno.
Il filo che lega Hu a Xi Zhongxun attraversa questa intera parabola. Xi padre era stato colpito duramente negli anni Sessanta, accusato di “cospirazione antipartito” e messo da parte. È Hu, una volta tornato ai vertici, a impegnarsi personalmente per la sua riabilitazione. Più tardi, quando il clima si rovescia e parte la campagna per rovesciare Hu, Xi Zhongxun si rifiuta di aggiungere la propria firma alla condanna. In quel rifiuto c’è tanto: lealtà personale, riconoscenza politica, ma anche una certa idea dei limiti che il Partito avrebbe dovuto porsi nel regolare i conti al proprio interno.
Non stupisce allora che, dopo il 1989, la figura di Hu Yaobang assuma un valore particolare soprattutto negli ambienti riformisti. È il leader che ha incarnato, più di altri, la speranza di un Pcc capace di aprirsi senza implodere. Non a caso, Robert Suettinger intitola la sua biografia “The Conscience of the Party”: Hu come coscienza critica, come simbolo di un bivio imboccato e poi abbandonato. Un simbolo scomodo, proprio perché appartiene pienamente alla storia del Partito e non a quella – molto più facilmente rimovibile – del dissenso dichiarato.
È qui che entra in scena l’ambivalenza di Xi Jinping. Da una parte Hu è un asset prezioso: un rivoluzionario di lunga prova, un dirigente incorruttibile, un uomo vicino al popolo. Una figura che può essere pienamente reintegrata nel pantheon dei “grandi” senza mettere in discussione l’ordine costituito. Dall’altra parte, Hu porta sulle spalle il peso di un’agenda – quella della riforma politica, del pluralismo interno, del ridimensionamento del culto del leader – che cozza frontalmente con il progetto di ri-centralizzazione del potere perseguito dalla leadership attuale.
Xi sceglie la via dell’appropriazione selettiva. Riprende la valutazione ufficiale formulata nel 1989 da Wen Jiabao, allora direttore dell’Ufficio generale del Comitato centrale, e la scolpisce in un nuovo contesto. Nel discorso del 20 novembre compie, in sostanza, tre operazioni. La prima è la canonizzazione: Hu viene celebrato come “rivoluzionario esemplare”, modello di lealtà, dedizione e integrità, senza ombre, senza ambiguità, senza traccia del conflitto che lo travolse negli ultimi anni.
La seconda operazione è la codificazione. Dalla biografia di Hu, Xi estrae cinque “virtù” destinate a diventare un prontuario per i quadri: la fede incrollabile nel comunismo; il “cercare la verità nei fatti” e correggere gli errori commessi, con il richiamo diretto alle riabilitazioni post-maoiste; l’audacia riformatrice, soprattutto in campo rurale e nella creazione delle zone economiche speciali; il mettere “il cuore nel popolo” e fare in modo che “i benefici siano condivisi da tutti”; l’essere equi, retti, severi con se stessi e con la propria famiglia, senza usare il proprio nome per arricchirsi. Hu viene così trasformato in un decalogo vivente, un compendio di virtù da emulare.
La terza operazione è la traduzione di queste virtù nell’agenda del presente. Ogni blocco del discorso si chiude collegando Hu alle grandi parole d’ordine della “Nuova Era”: la costruzione della modernizzazione alla cinese (中国式现代化), la linea delle “due integrazioni” (两个结合, cioè integrare i principi fondamentali del marxismo con la concreta realtà cinese e con l’eccellente tradizione culturale cinese), l’approfondimento complessivo della riforma (全面深化改革), la realizzazione della prosperità comune (共同富裕) e la “auto-rivoluzione” del Partito e perseguimento indefesso di una rigorosa governance totale del Partito (自我革命 / 全面从严治党永远在路上).
In questo montaggio narrativo, Hu non è più il protagonista di una stagione irripetibile, ma il precursore di ciò che Xi sta facendo oggi. È come se la linea di continuità tra gli anni Ottanta e il presente dovesse passare non per il trauma del 1989, ma per una genealogia rossa che collega direttamente Hu, Xi Zhongxun e Xi Jinping.
È qui che la commemorazione diventa un gesto insieme filiale e politico. Senza mai nominare il padre, Xi manda un messaggio chiaro: la linea rappresentata da Hu – e, di riflesso, da Xi Zhongxun – è “nostra”, non una deviazione liberale ma una delle radici dell’ortodossia attuale. Non a caso, quella del 2025 non è una prima volta: dieci anni fa, nel 2015, Xi aveva già presieduto il centenario di Hu con un grande elogio che ne sanciva di fatto la canonizzazione. L’evento di quest’anno è il secondo atto di questa operazione: non introduce una rottura, ma rafforza e riformula il racconto, inserendo Hu ancora più saldamente nell’architettura ideologica della “Nuova Era”.
E tuttavia, dietro questa appropriazione, resta il paradosso sottolineato da Suettinger: il sistema costruito da Xi somiglia sempre più al contrario di quello che Hu aveva in mente. Là dove Hu spingeva per depersonalizzare il potere, oggi assistiamo a una ricentralizzazione senza precedenti. Là dove si discuteva – pur tra mille ambiguità – di separazione tra Partito e Stato, abbiamo una loro ricomposizione strettissima. Là dove si cercava di limitare il mandato dei leader per evitare derive cesaristiche, sono stati rimossi i vincoli che impedivano la permanenza a vita. La Cina di Xi, nota Suettinger, è una “polizia di Stato pienamente funzionante” incardinata nel Pensiero di Xi Jinping, in cui il marxismo-leninismo sopravvive soprattutto come lessico dell’obbedienza: obbedisci o sarai punito.
In questo contesto, colpisce anche la coreografia della commemorazione. Nel comunicato ufficiale si sottolinea che “i parenti del compagno Hu Yaobang, gli amici che lo conobbero in vita e i rappresentanti della sua città natale hanno preso parte al simposio”. Secondo altre fonti, erano presenti in sala, tra gli altri, Hu Deping, secondo figlio di Hu, il generale in pensione Liu Yuan, figlio di Liu Shaoqi, e forse Deng Nan, figlia di Deng Xiaoping. Nelle regole non scritte della politica cinese, richiamare esplicitamente la presenza dei familiari di un leader defunto non è un dettaglio di colore: è un segnale. Vuol dire che la famiglia – e il capitale simbolico che la accompagna – è stata cooptata, che l’eredità di quella figura è considerata “sicura” e pienamente riassorbita nella narrazione ufficiale.
Ma è davvero così? Molti esponenti della “seconda generazione rossa” – i principini, figli dei grandi rivoluzionari come lo stesso Xi – hanno costruito, negli ultimi decenni, una lettura di Hu molto diversa da quella proposta oggi dalla leadership. A partire proprio dai figli di Hu, Hu Deping e Hu Dehua, e dai circoli raccolti attorno alla rivista Yanhuang Chunqiu (Primavere e autunni di Yan e Huang, i due mitici antenati del popolo cinese), Hu è stato raccontato come il simbolo di un socialismo più aperto, vincolato alla legge, meno personalistico. Da quelle pagine e da quelle reti sono arrivate, negli anni, critiche più o meno velate alla nuova traiettoria impressa da Xi: contro il ritorno del culto del leader, contro la stretta sul dibattito intellettuale, contro la chiusura dello spazio per un riformismo “di sistema”.
Emblematica, in questo senso, è la parabola di Hu Dehua, terzo figlio di Hu Yaobang ed ex vicedirettore di Yanhuang Chunqiu, scomparso lo scorso marzo. Nel 2013, durante una riunione interna della rivista a Pechino, Hu prese di mira alcuni passaggi ormai famosi di un discorso di Xi sul crollo dell’Unione Sovietica: la frase secondo cui, nel momento decisivo, “non c’è stato un solo vero uomo” pronto a difendere il Partito fino in fondo, e l’idea che l’esercito debba in ogni circostanza restare saldamente sotto il controllo del Pcc. Riprendendo l’interpretazione di Gennadij Zyuganov, leader comunista russo, Hu sostenne invece che l’Urss era crollata proprio perché il Partito aveva monopolizzato tutto: potere politico, risorse economiche e perfino il diritto di definire la “verità”. E rovesciò la retorica di Xi sulla “virilità” dei dirigenti sovietici con una domanda semplice: se un soldato si rifiuta di sparare su civili disarmati, non è forse quello il vero “uomo”? È la scelta dell’Armata Rossa di non aprire il fuoco sul popolo, spiegava, a dimostrare dignità e coraggio, non il contrario.
Sembra che Hu arrivò persino a dire che la generazione dei “figli rossi”, come Xi, oggi al comando aveva ricevuto un’istruzione molto limitata, che la Rivoluzione culturale “ha rovinato una generazione” e ha lasciato in eredità un’élite che, in sostanza, non possiede gli strumenti intellettuali né per spingere davvero le riforme, né per gestire in modo competente un nuovo ciclo autoritario.
Poco dopo, secondo diverse testimonianze, le autorità gli avrebbero recapitato un avvertimento formale a non “fare commenti irresponsabili”, e nel 2016 Yanhuang Chunqiu venne normalizzata: cambio di direzione imposto dall’alto, dimissioni in blocco della vecchia redazione, sopravvivenza del solo marchio, svuotato di senso.
Alla luce di questo trascorso e delle più recenti purghe dell’esercito popolare di liberazione, il discorso di Xi del 2025 su Hu Yaobang va letto dunque non solo come una canonizzazione retrospettiva di un leader dell’era delle riforme, ma come un manuale di comportamento per le élite del paese.
Esaltando sopra ogni cosa la lealtà di Hu, la sua accettazione della disciplina di Partito, la sua incorruttibilità e la sua attenzione per “il popolo”, Xi impone infatti un copione implicito su come l’attuale classe dirigente politica e militare deve comportarsi. Niente deviazioni, niente fazionalismi, solo obbedienza al leader e omologazione alla sua ‘linea’.