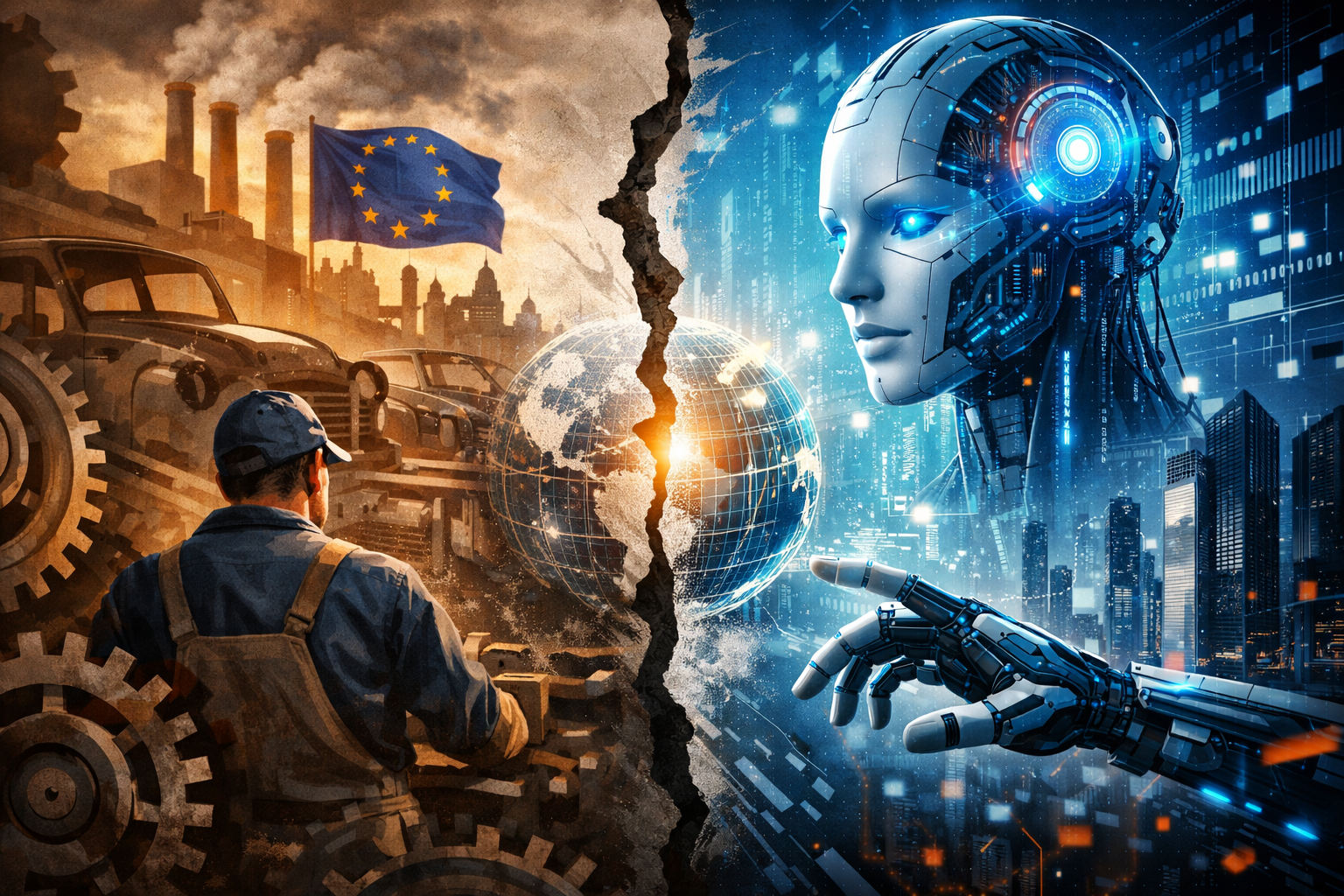Il libro di Massagli e Sacconi analizza l’IA come rottura definitiva del modello fordista. Contrastarla è inutile: va governata per liberare creatività e sviluppo. Italia ed Europa, ancora legate al passato, devono riformare lavoro, welfare e regole sociali per non restare indietro. La recensione di Gianfranco Polillo
“Creatività o sottomissione?”: non è solo il titolo dell’ultimo libro di Emmanuele Massagli e Maurizio Sacconi, edito da Marcianum Press (148 pagine, prefazione di Fabio Pammolli e postfazione di Andrea Bertolini).
Quell’alternativa rappresenta anche il confine tra il vecchio ed il nuovo mondo. Tra il “fordismo”, che fu caratteristica dello sviluppo economico del ‘900 e le nuove forme che dovranno nascere sotto l’usbergo dell’Intelligenza Artificiale (IA), la nuova tecnostruttura che, a passi da gigante, si appresta a divenire dominante.
Come reagire a questo impatto? Questo l’interrogativo di fondo che si sviluppa in tutte le pagine del saggio. Dimostrazione quasi fisica di un dilemma che sta già dominando la scena internazionale.
Si pensi solo alla dura competizione tra gli Stati Uniti di Donald Trump, e la Cina di Xi Jinping. Competizione dalla quale un Europa, che ancora si adagia su un vecchio modo di pensare e di agire, rischia di rimanere fuori.
Si può arrestare quel processo? È la storia a dirci di no. Una storia che, dalla fine del ‘700 in poi, è stata scandita dall’affermarsi dei nuovi paradigmi tecnologici. Al punto da far dire al vecchio Marx che “quando lo sviluppo delle forze produttive entra in contrasto con i sottostanti rapporti di produzione inizia una fase di rivoluzione sociale”.
Nella storia, per la verità, si sono verificati anche casi contrari. Sistemi in cui la rigidità dei sottostanti rapporti di produzione ha finito per ostacolare ed anche bloccare il progresso economico e sociale.
Si pensi solo alla Russia sovietica: alla fine morta per consunzione. Sebbene avesse a disposizione ogni ben di Dio sotto forma di materie prime, materiali sensibili, terre rare.
Ed al caso contrario della Cina di Deng Xiaoping, le cui riforme trasformarono un Paese ai limiti del sottosviluppo in quella grande potenza, che oggi ha l’ambizione di dominare il mondo.
Il saggio dà quindi per scontato che nei confronti dell’Intelligenza Artificiale non ha senso elevare barricate, nel segno della paura.
Comunque sia sarebbe una battaglia persa in partenza. Ed allora non resta, come sempre è accaduto nella storia, non solo di convivere con questa nuova creatura, ma di utilizzarla per consentire di realizzare quella “società storicamente superiore” che nel ‘900 era nelle speranze di filosofi e grandi leader.
Operazione, ovviamente, tutt’altro che semplice, date le caratteristiche della società italiana e, più in generale, del contesto europeo. Esiste oggi una distanza enorme tra la forma dei rapporti di produzione, che caratterizzano entrambe quelle realtà, e la possibilità di utilizzare al meglio la forza dirompente delle nuove tecnologie.
Una contraddizione che si spiega analizzando le contraddizioni della società italiana, a loro volta troppo spesso amplificate, da regole e codicilli frutto del condizionamento estero, rappresentato da Bruxelles.
Il fatto è che i principali Paesi che ne caratterizzano il nocciolo essenziale (Germania, Francia, Italia e Spagna; 72,5% del GDP della Zona euro) stanno vivendo una difficile fase di transizione.
Sono costretti a guardare al nuovo mondo, ma la loro cultura prevalente è quella del vecchio. Essendo ancora le regole sociali del “fordismo” a prevalere.
Quel modello si caratterizzava per la sussunzione del lavoro al capitale. I protocolli produttivi erano determinati dal ritmo del macchinismo che, a sua volta, poteva essere acquistato in blocco e trapiantato in qualsiasi realtà storica. Si pensi solo all’evoluzione della produzione di automobili.
La produttività, in altre parole, era data dal ritmo della tecnostruttura. Mentre al lavoro si chiedeva principalmente una resistenza supina al respiro della macchina. Negli anni ‘70, quando in Italia iniziò la massima diffusione di quel modello, il fulcro dell’organizzazione in fabbrica era data dalla mano d’opera maschile, di età intermedia, inquadrata quasi esclusivamente nel terzo livello.
Non si trattò semplicemente di un modo particolare di fare industria. Su quelle basi nacque, infatti, una cultura, un modo di porsi nei confronti del potere costituito, di dominare la scena politica.
Si spiega così il culto dell’egualitarismo, della centralizzazione dell’organizzazione sindacale, dei pochi spazi lasciati all’iniziativa individuale. Che per manifestarsi doveva rompere le barriere imposte al singolo dalla fabbrica e mettersi in proprio.
La storia di successo di tanti ex operai che abbandonarono la fabbrica, in cui si erano formati, per costituire le piccole imprese, che ancora oggi rappresentano il tessuto produttivo di molti territori, ne sono testimonianza.
Si poteva derogare da questo modello? Gli autori ne sono più che convinti. Citano in proposito diverse epoche storiche in cui l’iniziativa dal basso, diremmo oggi, rappresentò la risorsa principale delle grandi trasformazioni del paese.
Ciò che avvenne nel periodo del “Ricostruzione”, dal 1947 al 1964, fu qualcosa che rompeva ogni schema. Si trattò di un “miracolo”, come successivamente fu indicato.
Ma non solo “economico”. Non ci sarebbe stato, se non fosse stato determinato dal quel grande flusso di mano d’opera che, dalle campagne del Mezzogiorno, si riversava nel “triangolo industriale”.
Una spinta motivata dalla voglia di mettersi in gioco, fino ad affrontare un’avventura che aveva un significato esistenziale.
Negli anni ‘80, si verificò, qualcosa di diverso ma ugualmente significativo. Sul fronte internazionale, i primi grandi sommovimenti, tali da mettere in discussione le vecchie logiche coloniali, come avvenne sul fronte petrolifero.
Su quello interno l’emergere di nuovi ceti, in grado di dare valore ad un’attività immateriale come la moda, la televisione, la pubblicità come forma imprenditoriale. Ed il diffondersi di un ceto medio, che poteva offrire punti di riferimento diversi rispetto ad una società eccessivamente polarizzata.
Furono quelli gli anni in cui lo scontro tra le due culture – quella della conservazione da un lato e quella dell’innovazione dall’altro – fu esiziale per le sorti del Paese. Con la conseguenza di ritardare ulteriormente il passaggio oltre le Colonne d’Ercole che, come nel ‘500, chiudevano l’orizzonte.
Quegli anni devono ancora ispirarci. L’Italia di oggi, è più vicina a quelle esperienze che non alla cupezza degli anni ‘70.
L’inarrestabile diffondersi dell’IA, a sua volta, ne esalterà lo spirito di frontiera. Si pensi solo ai progressi compiuti rispetto alle due crisi del 2008 e del 2011. Allora gli spread erano pari a 570 punti base, oggi oscillano intorno ai 60 punti base.
Nel 2010 il deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti era pari al 3,2% del Pil. Lo scorso anno, nonostante i dazi d Trump, avremo un surplus dell’1%, con un saldo positivo costante superiore al doppio, per quasi un decennio.
Da una posizione patrimoniale debitoria pari 25,21% del Pil del 2014, possiamo ora (ultimo bollettino della Banca d’Italia) vantare crediti per un importo pari al 13,3% del Pil. Con un salto pari a quasi il 40%.
Questi elementi illustrano a sufficienza la resilienza non solo dell’economia, ma della società italiana.

Mostrano anche come il piagnisteo sul debole sviluppo della produttività sia fuorviante. Il suo effetto statistico è principalmente conseguenza del metodo con cui l’indice è costruito.
Funziona per Paesi omogenei, molto meno per un Paese a macchia di leopardo com’è la realtà italiana. In cui quasi il 100 per cento del surplus commerciale nei confronti dell’estero – indice ben più attendibile di una produttività di
gran lunga superiore ai livelli salariali corrisposti – si concentra in solo quattro regioni: Emilia, Veneto, Toscana e Marche.
Il significato di questi dati è evidente. Bisogna partire dai punti alti dello sviluppo italiano sui quali orientare le necessarie sovrastrutture.
Ed ecco allora il perché del passaggio da una “politica dei redditi” ad una “per i redditi” secondo le indicazioni dei due autori. Con il suo corollario di istituti giuridici da creare o potenziare.
Regole sindacali da cambiare. Nuove politiche del welfare da incentivare, fino a scavare negli assetti più profondi della società italiana che investono la demografia, lo stare insieme, la famiglia come cellula elementare di uno stile di vita.
Suggerimenti che dovrebbero interessare tutti, ma specie coloro che ancora si cullano nella bambagia di un ancien régime, destinato quanto prima ad essere spazzato via dal diffondersi dell’IA.