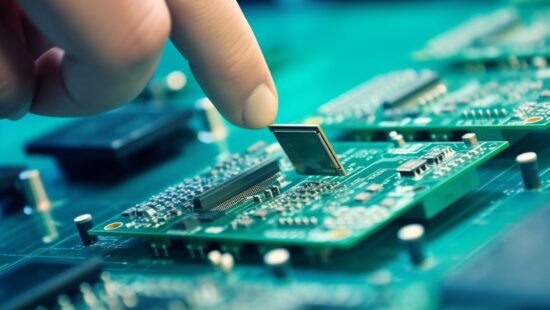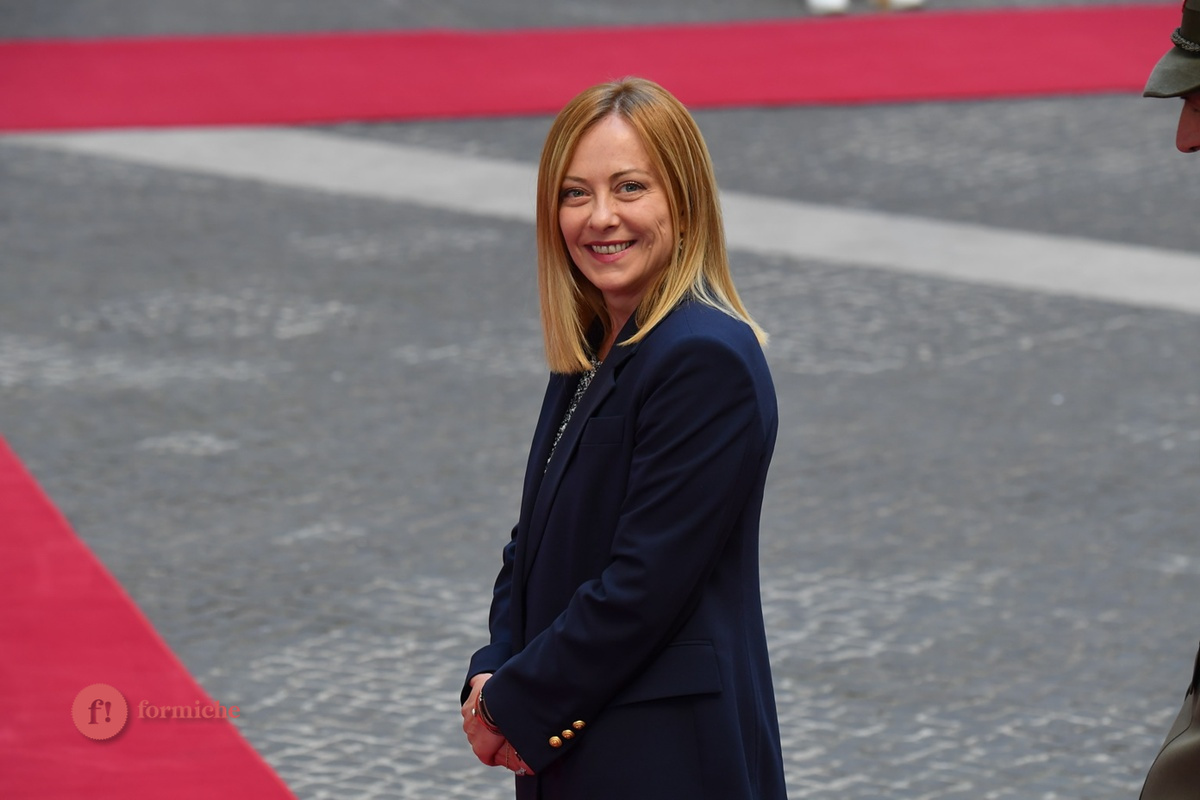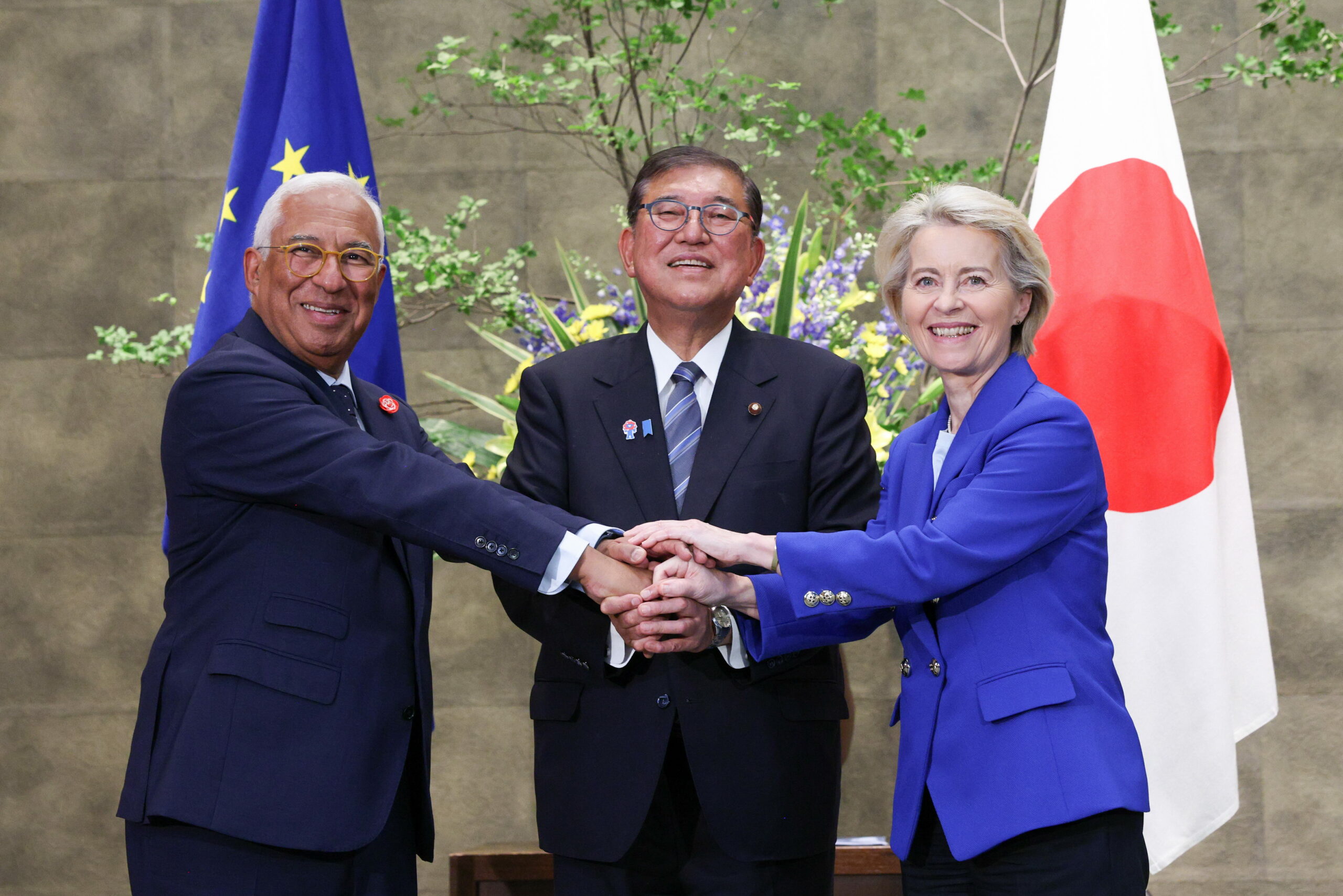Il recente scandalo dell’urbanistica a Milano continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sui tanti fenomeni di corruttela, che vanno oltre la classica definizione di corruzione secondo il Codice penale (artt. 319 e 318). La definizione giuridica è rilevante ai fini della configurazione del reato, mentre vi sono comportamenti altrettanto illeciti nell’esercizio della funzione pubblica o in incarichi conferiti al privato che vedono prevalere l’interesse particolare dell’agente su quello pubblico o del committente. Gli esempi sono molti e multiformi. Rientrerebbe in questa definizione il caso del Comune che redige un bando di appalto in modo tale da favorire l’impresa amica. Lo stesso può dirsi del presidente di una commissione per l’assegnazione di una cattedra universitaria che favorisce un candidato a spese degli altri, o del responsabile degli acquisti di un’impresa che gonfia i pagamenti ai fornitori con cui è colluso per trarne di rimando un profitto personale.
Le definizioni adottate dai paesi differiscono a tal punto da rendere poco probanti i confronti internazionali, benché possano servire a evidenziare gli andamenti nel tempo di determinati comportamenti illeciti. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione si astiene dal fornire una definizione comprensiva di tutti i casi, preferendo identificare una serie di azioni che dovrebbero essere considerate come reati dai Paesi aderenti. L’elenco spazia dalla corruzione comunemente intesa, al traffico di influenze, l’abuso di funzioni e il riciclaggio di denaro sporco. In Italia non tutti questi comportamenti si configurano come reati. Ne è esempio l’abolizione recente del reato di abuso di ufficio.
Le diversità nel perimetro definitorio non impediscono, tuttavia, di misurare seppure con qualche approssimazione, le dimensioni e caratteristiche del fenomeno della corruzione in un paese e di valutarne l’incidenza e il suo variare negli anni. Su questi aspetti sono stati pubblicati di recente alcuni rapporti ed indagini sull’Italia, che con metodi differenti danno utili indicazioni. La fonte più ricorrente è costituita dall’indagine di Transparency International che classifica i paesi secondo le percezioni che la popolazione ha della lotta alle pratiche corruttive nel settore pubblico e dei risultati. L’ultima rassegna relativa al 2024 vede il peggioramento di due punti negli indicatori dell’Italia rispetto al 2023 e il suo classificarsi alla 52a posizione su 180 paesi, ovvero al di sotto di quelli con miglior performance.
Tra costoro si trovano tanto paesi avanzati, compreso un buon numero di quelli europei, quanto paesi meno avanzati, come alcuni dell’America Latina, dei Caraibi e del Medio Oriente. Naturalmente si può esprimere riserve su queste classifiche che accomunano paesi che differiscono per dimensione, sviluppo economico, ordinamenti ed efficacia delle istituzioni. Nell’Ue la valutazione per l’Italia risulta, nondimeno, peggiore di quelle di Germania, Francia e Spagna, con cui il nostro paese può compararsi in molti aspetti. Si consideri in ogni caso che non bastano le percezioni se non sono suffragate da prove valide basate su dati.
Più solida appare sotto il profilo del metodo e della rilevazione l’indagine di Eurobarometer pubblicata da poco, che è condotta dalle istituzioni dell’UE per sondare l’opinione pubblica su temi rilevanti di carattere politico, sociale e sulle politiche dell’Unione. Il quadro che ne risulta per l’anno in corso non è confortante in sé stesso e anche se raffrontato alle medie europee. La maggioranza degli italiani ritiene che la corruzione sia diffusa nel Paese e che investa le istituzioni centrali più che quelle locali. L’incidenza di questa percezione raggiunge l’82% degli intervistati, ovvero una quota che supera nettamente la media dell’Ue (69%). La frequenza di questa valutazione non sembra cambiare nel tempo se non in misura minima: aumenta di 4 punti percentuali rispetto al 2024 dopo che era diminuita nel 2023.
Per quasi tutte le categorie dei beneficiari di tangenti e di abusi di potere le percentuali di italiani che avvertono la presenza di questi comportamenti, superano di gran lunga quelle medie europee. Le disparità toccano in particolare i funzionari pubblici addetti all’assegnazione dei contratti di appalto e dei permessi edilizi, alle autorizzazioni alle imprese, alle ispezioni per i controlli di sicurezza, ai servizi sanitari, al welfare e all’istruzione. Il giudizio negativo non sembra risparmiare nessuna delle categorie, segno di un malgoverno che tocca ampi strati della pubblica amministrazione. Né risparmia la classe politica, stante che la metà circa degli italiani la ritiene permeabile a queste pratiche, ma in questo giudizio nessuna disparità rispetto alla media degli europei.
Quanto all’impatto del fenomeno sulla vita dei cittadini, il 41% ritiene di subirne personalmente le conseguenze, ovvero una quota in ascesa rispetto al biennio precedente e più ampia rispetto alla media europea del 30%. La maggior diffusione dei giudizi negativi tra la popolazione contrasta, tuttavia, con l’esiguità del numero di quanti ne hanno esperienza diretta (4%), o sono venuti a conoscenza (5%) di persone che prendono tangenti; una esiguità che si rinviene anche nella media europea. Questo contrasto tra opinione diffusa e conoscenza ravvicinata potrebbe essere indice di credenze radicate nella cultura sociale sulla base dei comportamenti riscontrati da molto tempo nella vita lavorativa, anche se non conducono all’accertamento di reati. In questo senso, meno dei due terzi degli intervistati considera la corruzione inaccettabile, senza differenza rispetto alla media europea, e i due terzi vedono nelle connessioni con i politici la chiave del successo negli affari, con un’incidenza decisamente superiore al dato europeo.
Dalle risposte traspare un senso di assuefazione a queste pratiche che origina da precise motivazioni. Per la stragrande maggioranza degli italiani (81%), i casi di corruzione agli alti livelli non sono perseguiti a sufficienza e in generale serve a poco denunciarli alle autorità. I motivi sono principalmente la difficoltà della prova, la carenza di punizione dei responsabili, perché riuscirebbero a uscirne indenni e il rischio di ritorsioni verso chi denuncia per la scarsa protezione che riceverebbe.
Andando oltre le opinioni o le percezioni, i dati statistici disponibili non riescono a rappresentare compiutamente il fenomeno. Quelli giudiziari delle condanne penali sono molto esigui e riflettono le numerose scappatoie che le norme consentono. Numeri più consistenti si rilevano nei casi avviati a indagine, mentre quelli perseguiti sono inferiori. Inoltre, le più recenti statistiche rese pubbliche si riferiscono al quadriennio che termina nel 2019.
L’Istat ha fornito l’anno scorso i risultati di una indagine per gli anni 2022-2023 sulle richieste alle famiglie di denaro o di altro per ottenere favori o altre prestazioni. Il quadro che ne deduce è di un deciso miglioramento rispetto all’indagine nel periodo 2025-2016 in quanto solo il 5,4% delle famiglie è stato coinvolto e l’8,3% ha esperienze di atti corruttivi.
Ma 2,9 milioni di imprenditori riconoscono che sovente occorre corrispondere denaro per ottenere alcuni servizi. In sostanza, questo comportamento è visto come una realtà inevitabile al fine di realizzare sviluppo economico, in quanto permette di superare le barriere della burocrazia e delle sue lentezze. Anche tra le famiglie si nota una certa tolleranza verso le pratiche corruttive in alcuni casi. Ad esempio, il 20,1% dei cittadini (8,7 milioni di persone) le ritiene accettabili per trovare un’occupazione per un familiare. In contrasto, il 90,7% pari a 39,3 milioni ritiene che bisogna contrastare la corruzione denunciando i casi. Le quote, tuttavia, variano a seconda del livello d’istruzione e dell’area geografica.
Dalle evidenze raccolte si deduce che molto è stato fatto per contrastare il fenomeno, ma che molto ancora rimane da fare. L’approccio migliore richiede una concentrazione degli sforzi sulle attività di prevenzione e di rilevazione dei multiformi casi con metodi avanzati di costruzione di indicatori, come ha messo in atto l’Anac. Questa Autorità ha sviluppato modelli e programmi sia per la trasparenza negli appalti pubblici, sia per la prevenzione della corruzione e la vigilanza sugli appalti. Nel sottolineare il venir meno delle tutele contro gli abusi di ufficio e i conflitti d’interesse nell’amministrazione pubblica, nell’ultima relazione l’Anac lamenta la mancanza di un’organica disciplina del lobbying e l’eccessiva espansione degli affidamenti diretti degli appalti pubblici, che ha raggiunto il 98% a danno della concorrenza.
Registra altresì un incremento annuo delle richieste di intervento (in totale 5029) per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nella gestione pubblica. Al netto di quelle rigettate per incompetenza, le richieste hanno dato luogo all’avvio di 642 procedimenti, con un aumento di oltre il 3% sul 2023, di cui il 70% per la vigilanza anticorruzione e il resto per attività sanzionatorie. Malgrado l’allargamento delle maglie della disciplina normativa, che ha ridotto il perimetro di rilevazione delle ipotesi di reato, le segnalazioni anticorruzione continuano ad espandersi.
Segno al contempo di una crescente consapevolezza tra i cittadini della necessità di partecipare al contrasto del fenomeno e dell’impegno dell’Autorità nel rendere più efficace la lotta. È illusorio credere che si possa sradicare la piaga della corruzione e dei comportamenti assimilabili con i soli interventi normativi, giudiziari e dell’autorità di contrasto. L’esperienza italiana non si distingue da quella di molti paesi, benché un gruppo di loro sia riuscito a contenerla entro margini molto ristretti, come nei paesi scandinavi e in Svizzera. Per aver successo occorrono un cambiamento della cultura sociale, la partecipazione attiva di tutti i cittadini, un efficace coordinamento interistituzionale e, non ultimo, una digitalizzazione di tutte le procedure.