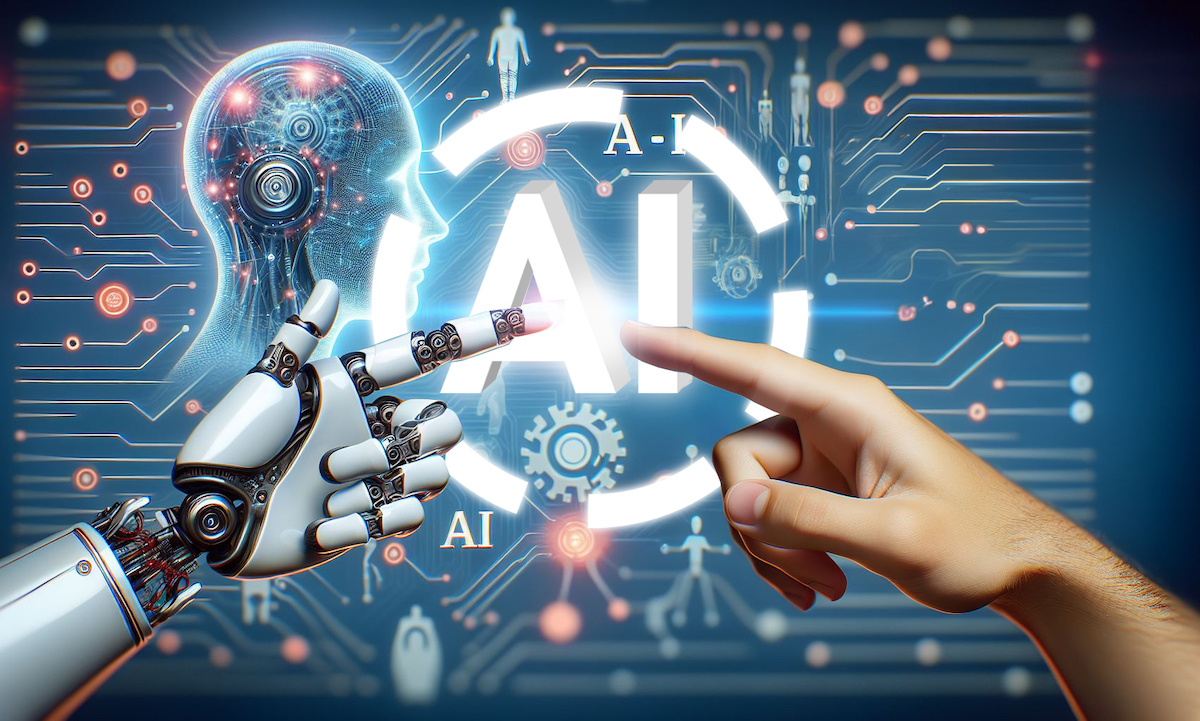Nel dibattito elettorale tedesco sicurezza e Difesa si affacciano prevalentemente nel prisma ucraino. Tuttavia, il governo che uscirà dalle urne, o piuttosto dai lunghi negoziati per la futura coalizione, avrà un critico appuntamento con la Nato. Dovrà decidere che contributo dare e che ruolo assumere. Berlino è al centro della difesa dell’Europa. L’analisi di Stefano Stefanini, senior advisor dell’Ispi e già rappresentante permanente d’Italia alla Nato
Archivi
La morte degli stili. Come l’intelligenza artificiale può spingerci verso l’unicità
Ci sarà sempre chi cercherà la propria espressione, utilizzando gli strumenti in modo che gli sembra più congeniale. Così gli stili saranno sempre più ripetibili. Ma forse saranno sempre meno popolati dagli artisti. Il commento di Stefano Monti
Cosa penso del ruolo dell'intelligence nel caso Sala. L'opinione del prof. Teti
Sull’arresto della giornalista Cecilia Sala, afferma Antonio Teti, professore dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, sono diversi gli elementi meritori di molteplici spunti di riflessione e che necessitano di un’analisi attenta e cauta, soprattutto sulla base delle informazioni attualmente disponibili al riguardo
Transizione energetica, come arrivare vivi al 2050 secondo De Bettin (DBA Group)
La sostenibilità, se davvero la si vuole raggiungere, si garantisce redistribuendo equamente i costi della transizione, con incentivi mirati per le aziende più esposte e politiche di protezione sociale per chi lavora nei settori in declino. Il commento di Francesco De Bettin, presidente di Dba group
Mercati e Pnrr, le sfide di Meloni e Giorgetti che l'Italia può vincere
L’anno appena cominciato porta in dote due obiettivi decisamente strategici. Primo, continuare ad assicurarsi la fiducia degli investitori e un costo del debito sostenibile. Secondo, la messa a terra di oltre un quarto del Piano di ripresa e resilienza. Per fortuna il 2024 si è chiuso con una buona rendita da sfruttare a proprio favore. Le variabili energia e dazi
Postumanesimo, la tecnologia per l’umanità o l’umanità per la tecnologia?
L’intelligenza artificiale ha il potenziale di diventare il “superpotere” del 21° secolo, ma solo se sapremo utilizzarla per costruire un mondo più giusto, sicuro e prospero per tutti. La quarta puntata firmata da Vincenzo Ambriola, Università di Pisa, e Marco Bani, Senato della Repubblica Italiana, sulle riflessioni riguardo l’impatto sociale dell’intelligenza artificiale
Razzi commerciali riutilizzabili. Pechino insegue SpaceX e sfida il mercato globale
La crescente sinergia tra pubblico e privato rappresenta una svolta strategica per il dominio cinese nello spazio, che nel 2025 mira a rafforzare la sua posizione di potenza spaziale globale con il lancio di nuovi razzi Long March e vettori sviluppati da aziende private. Tra innovazione tecnologica e competizione interna, Pechino punta a incrementare la frequenza delle missioni, abbattere i costi e sviluppare soluzioni riutilizzabili per sostenere progetti ambiziosi, dalle mega-costellazioni alla stazione spaziale
Missili estoni nei cieli ucraini. Ecco il nuovo sistema anti-drone
La start-up estone Frankenburg Technologies testa in Ucraina un missile anti-drone a basso costo progettato per affrontare le sfide della guerra moderna. Mentre l’Estonia si conferma un attore chiave nel sostegno militare a Kyiv
AfD, dall’opposizione al potere? Il rebus tedesco visto da Crescenzi
I sondaggi dimostrano come i tedeschi considerino Alice Weidel, presidente di AfD e possibile candidata al cancellierato, la meno affidabile fra i potenziali concorrenti. E non possono bastare al partito sovranista i vasti consensi raccolti, fin qui, soprattutto nei Länder dell’est e in Baviera. Ma gioca a favore di AfD lo scarso dinamismo, per non dire la mancanza di coraggio e iniziativa, che la politica tedesca sta dimostrando nella gestione delle diverse crisi. L’analisi di Luca Crescenzi, presidente dell’Istituto italiano di studi germanici
Minacce ibride, la risposta è nella deterrenza punitiva. L'analisi di Bajarūna
Negli ultimi dieci anni gli Stati membri dell’Ue hanno compreso chiaramente che la guerra ibrida del Cremlino rappresenta una sfida significativa alla sicurezza. Dal 2016 l’Ue ha sviluppato proposte ambiziose attraverso il Joint framework on countering hybrid threats, successivamente rafforzate con l’istituzione di un Eu hybrid toolbox, una raccolta completa di metodi per contrastare le minacce multidominio. L’analisi di Eitvydas Bajarūnas, visiting fellow presso il Center for european policy analysis, Cepa