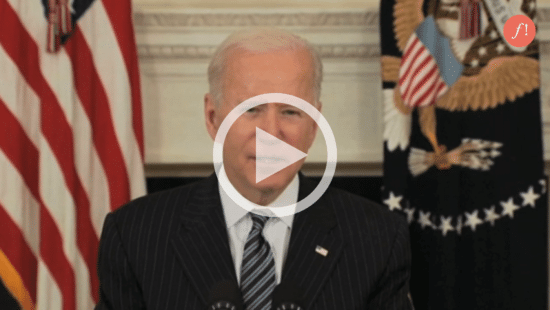Un decreto ministeriale non può modificare il Codice di procedura penale e il pubblico ministero ha già il potere di perquisire a distanza, decidendo cosa sequestrare e cosa no. Il commento di Andrea Monti, professore incaricato di Diritto dell’ordine e della sicurezza pubblica, Università di Chieti-Pescara
Archivi
Copasir, tra Volpi e Urso c'è Letta. Ecco perché
La partita per il Copasir è ancora aperta. La via istituzionale di Fico e Casellati non chiude le porte alla politica. Volpi convoca l’ufficio di presidenza, un passo indietro non è all’ordine del giorno. Sullo sfondo si rafforza l’intesa Letta-Meloni
Anche le imprese hanno bisogno di un loro piano vaccinale
A più di un mese dall’insediamento del governo Draghi, è già tempo di svolgere se non dei bilanci, quanto meno talune prime valutazioni in ordine ai provvedimenti adottati. Il commento di Stanislao Chimenti, docente di Diritto commerciale e partner dello studio internazionale Delfino Willkie Farr & Gallagher
Il SofaGate dimostra che per Erdogan non c’è posto in Europa. Scrive Gancia (Lega)
L’episodio della sedia mancante per la presidente von der Leyen in visita ad Ankara è l’ennesima dimostrazione che la Turchia di Erdogan è l’antitesi dei valori fondanti l’Unione europea. L’intervento di Gianna Gancia, europarlamentare della Lega
Il futuro delle terre rare passa dalle urne in Groenlandia
Che impatto avranno le recenti elezioni sulla corsa globale alle terre rare? Tra ambiente, sviluppo e indipendenza il prossimo governo deciderà il destino dei progetti per sfruttare i ricchi giacimenti presenti nell’isola artica. Con conseguenze sul piano geopolitico
From Sputnik to Ukraine, will Russia drift away from Europe?
Vladimir Putin has his phase 3 too, and it entails slowly and inexorably moving away from the West. The Chinese hug awaits him, but he got it all wrong. From vaccines to espionage, a European road map to keep the guard up with Moscow. An analysis by Marta Dassù, Senior Advisor at the Aspen Institute and member of the task force on the future of NATO, as well as former Deputy Foreign Minister
Parigi rilancia il Fcas. L'intesa tra Dassault e Airbus e l'attesa per Berlino
Una nota della Commissione Difesa del Senato francese conferma l’accordo tra Dassault e Airbus per procedere sullo sviluppo del progetto Fcas. Ora il nodo si sposta al Bundestag, che dovrà approvare l’intesa entro l’estate per evitare ulteriori ritardi. Resta poi da chiarire il ruolo della Spagna
Biden sui vaccini: "Dal 19 tutti gli adulti in Usa avranno diritto". Il video
Biden sui vaccini: "Dal 19 tutti gli adulti in Usa avranno diritto" [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=iwH9G0fM5Iw[/embedyt] Milano, 7 apr. (askanews) - "Ancora molto lavoro da fare". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia che a partire dal 19 aprile tutti gli adulti americani avranno diritto alla vaccinazione, ma il nuovo leader della Casa Bianca è cauto: la lotta contro il virus…
Von der Leyen confinata sul divano da Erdogan. La lettura (poco) diplomatica
Fraintendimento, disguido o affronto voluto? Il momento in cui la presidente della Commissione europea è rimasta in piedi, prima di doversi accomodare più lontano dal presidente turco e dal presidente del Consiglio europeo, ha scatenato critiche e molte interpretazioni, anche sul rapporto Ue-Turchia. E c’è un precedente che rende il tutto più imbarazzante
Se il vizietto cinese sui prestiti contagia anche il fintech
Il governo centrale interviene a gamba tesa sui finanziamenti online concessi agli studenti per pagarsi gli studi, fermando le erogazioni di denaro. Colpa dei tassi troppo alti e delle condizioni troppo rigide che avrebbero potuto portare a un’ondata di insolvenze