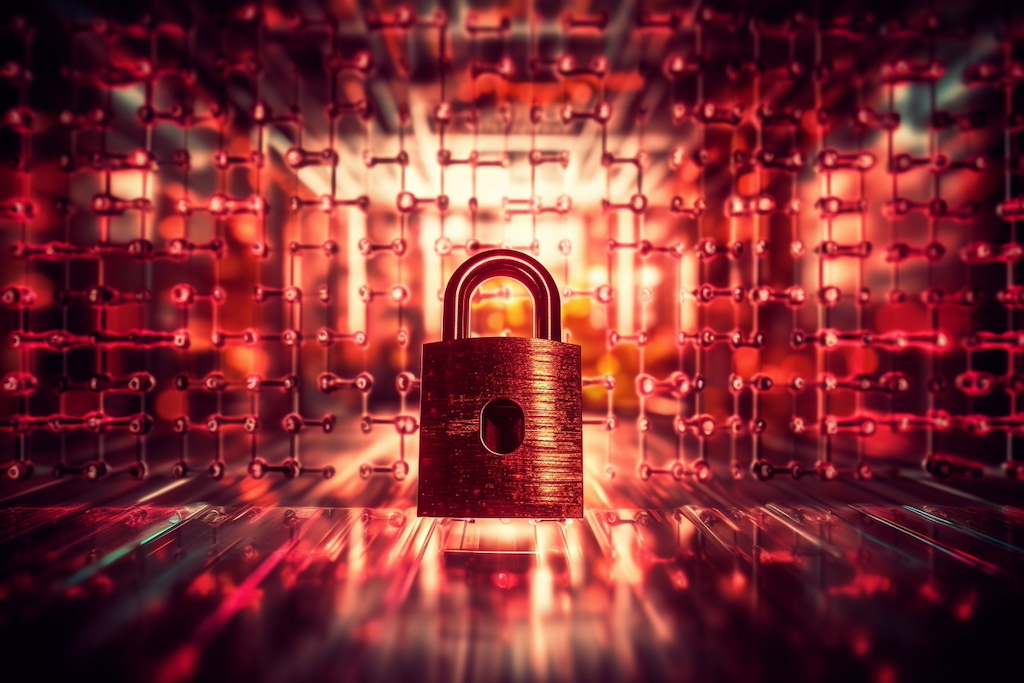Chi considerasse Trump e la sua nuova amministrazione come “isolazionista” sbaglierebbe e i riferimenti di Trump alla presidenza McKinley (1897-1901) e ai suoi programmi protezionisti e nazionalisti durante il discorso d’inaugurazione del mandato, lasciano spazio per una breve riflessione
Archivi
Sull’asse Roma-Riad si muove anche il Gcap. Quali spazi per i sauditi?
Italia e Arabia Saudita stringono i legami sulla Difesa. Tra i dossier ancora aperti l’interesse saudita a diventare il quarto partner del Gcap. Aperture in senso positivo dall’Italia, con Giorgia Meloni e Roberto Cingolani che non escludono progressi in questo senso. Tuttavia il processo potrebbe prendere del tempo, visto il necessario accordo politico tra i governi dei tre Paesi impegnati a sviluppare il caccia di sesta generazione
L'anno del serpente inizia male in Cina. Imprese a tappeto
Contro ogni previsione, l’indice dell’attività manifatturiera cinese scivola a gennaio, mandando nuovi segnali inquietanti ai mercati. Forse anche per questo Pechino annuncia una nuova chiamata alla salvezza del Dragone
Il pragmatismo trumpiano come stimolo all’Europa. Il commento di Cangini
Trattare con Donald Trump e confrontarsi con il trumpismo non è né giusto né sbagliato. È semplicemente necessario.
Occorre, pertanto, evitare le drammatizzazioni e sforzarsi di interpretare la nuova realtà che ci è dato vivere in una chiave il più possibile positiva. Il commento di Andrea Cangini
Perché la formazione sulla cybersicurezza è una priorità per il futuro dell'Italia. Scrive Benigni
La cybersicurezza non è più un’opzione, ma una necessità per garantire la competitività e la sicurezza delle imprese italiane. La formazione deve diventare un impegno condiviso tra istituzioni, aziende e cittadini, affinché il nostro Paese possa affrontare con successo le sfide digitali del futuro. La riflessione di Lorenzo Benigni, vicepresidente di Unindustria Lazio con delega alla cybersecurity
La chiave di Meloni (anche a Al-Ula) si chiama Piano Mattei
Secondo la premier è possibile un costante e progressivo miglioramento delle relazioni dal momento che “ci sono ancora delle potenzialità”. Ed ecco che da questo elemento si dipanano le strategie attuative, una delle quali (da un punto di vista di visione, forse la più rilevante) prende il nome di Piano Mattei. Domani visita in Bahrein
Strategia e crescita. Tutte le intese tra Italia e Arabia Saudita
La visita della premier porta in dote una serie di risultati, come le intese da 10 miliardi, i semi della cooperazione frutto della tavola rotonda di alto livello. Presenti Fincantieri, Leonardo e Pirelli
Il ruolo strategico dell’Arabia Saudita nelle politiche italiane. Conversazione con Varvelli
Per Arturo Varvelli (Ecfr), “una partnership forte con Riad rappresenta un vantaggio considerevole per l’Italia, sia in termini economico-commerciali che politici”
Le sfide del governo Meloni sono solo all'inizio. Il commento di Sisci
Dal dialogo con Trump alle riforme come quella della magistratura, il governo Meloni ha davanti a sé sfide ancora più stringenti di quelle già passate. L’esecutivo è a rischio? No, ma qualcosa si muove (anche a sinistra). La riflessione di Francesco Sisci
La sinistra è in crisi perché non si fa le domande giuste. Scrive Cazzola
In Italia la sinistra non è in crisi perché la destra le ha rubato il mestiere e la base elettorale. La vera innovazione nella politica del governo Meloni sta nella sua continuità con quella del governo Draghi, mentre la sinistra la sta ripudiando, per inseguire la dottrina Landini della rivolta sociale. Il commento di Giuliano Cazzola