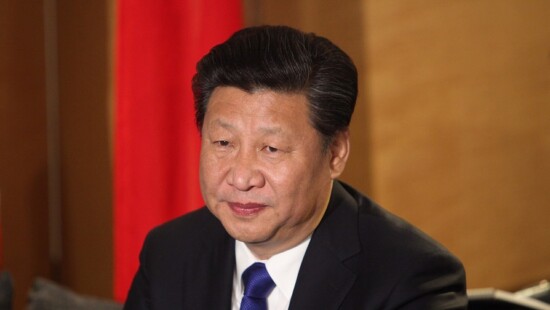L'ultimo è stato Fabio Capello, storico allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, a cedere alle lusinghe del pallone nell'ex Celeste Impero. "L'impressione sul calcio cinese è di una nazione con uno sviluppo verticale", ha detto il tecnico friulano nella conferenza stampa di presentazione dello Jiangsu Suning, il club che poi ha in mano anche l'Inter. E non sarà…
Archivi
Voucher, ecco cosa cambia con Libretto di famiglia e Lavoro occasionale
Il testo che segue è un’anticipazione di un saggio di prossima pubblicazione su Argomenti di diritto del lavoro È in corso d’approvazione la nuova normativa in materia di lavoro occasionale, quel lavoro finora retribuito mediante appositi voucher che però sono stati aboliti a marzo per scongiurare il referendum proposto dalla Cgil. A sottolineare la grande rilevanza della questione, la Corte…
Vi racconto profilo e manie degli attentatori
La catena di attentati dell'ultimo decennio ha fatto piombare l'Europa in un clima di terrore che sta, inevitabilmente, condizionando le vite e le scelte dei cittadini europei. Per capire cosa sta succedendo nel Vecchio Continente è fondamentale partire dagli attori che stanno mettendo in scena questo atroce spettacolo del quale non si riesce ad intravedere la fine. Federico Mello, giornalista…
Vi racconto la prossima riglobalizzazione del commercio internazionale
L'ultima frontiera della globalizzazione è la ricerca della dimensione antropologica dell'individuo. Fino ad oggi il business è stato e - ancora per qualche tempo - continuerà ad essere fortemente caratterizzato dalla libera circolazione delle merci, dalla standardizzazione dei prodotti, dall'omologazione dei pensieri e dei comportamenti. Le migliori interpreti di questo trend sono le multinazionali che prosperano su economie di scala,…
Come e perché Silvio Berlusconi gongola
Da almeno un mese Silvio Berlusconi è tornato di ottimo umore. Non si è dispiaciuto più di tanto nemmeno per l’accordo sfumato sulla legge elettorale. Anche perché ormai ha imparato a non fare troppo affidamento alle offerte in arrivo da Matteo Renzi. La prende, per così dire, con filosofia. Il Cavaliere è di buon umore perché sente aria di vittoria.…
Le impronte di D’Alema nell’Ulivicidio del 1998 registrate da Ciampi
(Articolo ripreso da www.graffidamato.com) Stimolato un po' da una certa nostalgia dell’Ulivo, cresciuta a sinistra anche per effetto del primo turno quasi bipolare delle elezioni amministrative di questo mese di giugno, un po’ dai recenti insulti televisivi di Massimo D’Alema al vice direttore dell’Espresso, che gli aveva rimproverato, o girato le ripetute accuse di Matteo Renzi di avere “ucciso” la…
Rendering Revolution, il progetto di Stefano Mainetti
Musica, danza pittura e videoarte unite in un’esperienza sinestetica, creata dal compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti (in foto con la moglie Elena Sofia Ricci). Davanti a un parterre di artisti, attori, produttori, imprenditori e star dello show business, lunedì 12 giugno al Maxxi di Roma, è stato presentato il progetto Rendering Revolution, un’installazione fruibile ancora soltanto virtualmente, che punta a…
Roberto Maroni e Giorgio Gori, la strana coppia per il sì al referendum sull'autonomia in Lombardia
C’eravamo tanto rottamati. I tempi del camper e della Leopolda, per Giorgio Gori, sono finiti da un pezzo. Dal 2014, l’ex spin doctor di Matteo Renzi è sindaco di Bergamo, terra di leghisti della vecchia guardia e nostalgici dei comizi in canottiera di Umberto Bossi. Grazie al sostegno del Pd, Gori, tre anni fa, è riuscito a strappare la città…
Perché l'Europa deve ripartire dallo spazio
Pubblichiamo l'intervento del presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) Roberto Battiston all'evento “Space policy for EU integration”, organizzato dalla Commissione Ue e tenutosi oggi a Roma, in Campidoglio, nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma Perché questa celebrazione è importante? Perché significa che l'Europa riconosce a sé stessa un futuro comune. Un futuro che trova…
L'IS rivendica il primo attacco in Israele, Hamas smentisce
Venerdì la sedicente agenzia stampa del Califfato, Amaq News, ha rivendicato a nome dell'IS un attentato terroristico a Gerusalemme, nel quale una poliziotta israeliana di 23 anni è rimasta uccisa dopo essere stata accoltellata. L'UNICA RIVENDICAZIONE, FINORA Le rivendicazioni dello Stato islamico in Israele finora era stata soltanto una: il lancio di un razzo dal Sinai – dove si trova la Wilayat…