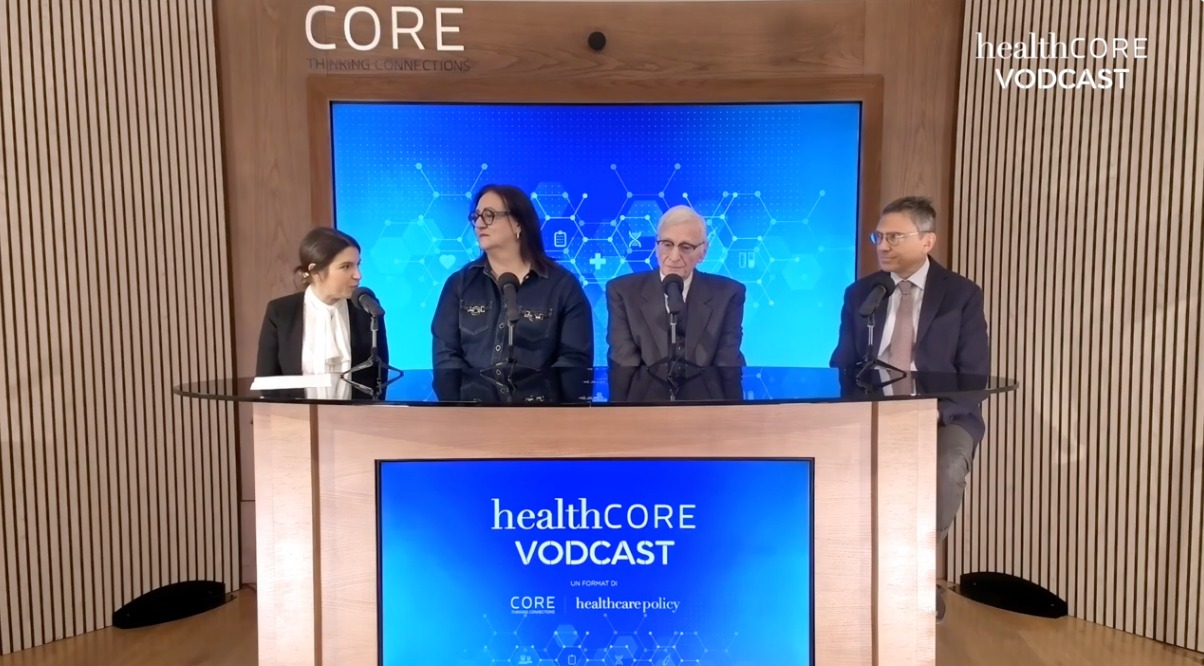Il referendum, per come è costruito e per il contesto in cui cade, non premia la sofisticazione. Premia la chiarezza del conflitto, il frame più limpido e più efficace nel mobilitare gli elettori dei fronti opposti. La domanda, allora, non è se lo scontro si attenuerà. La domanda è quanto saprà restare dentro un perimetro politico senza trasformarsi in un cortocircuito istituzionale. L’analisi di Martina Carone
Archivi
Ricordando Nikolajewka, lo spirito alpino in oltre un secolo di servizio. Scrive Rauti
Nikolajewka rappresenta il culmine del coraggio e della fratellanza degli Alpini, richiamando una storia che attraversa oltre 150 anni. Dalle montagne della Prima Guerra Mondiale alle moderne esercitazioni in condizioni estreme, la tradizione si intreccia con la preparazione alle sfide del presente. La memoria non è solo commemorazione, ma strumento attuale di servizio e resilienza, testimoniato dal lavoro quotidiano degli Alpini. La riflessione di Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, in occasione della commemorazione della battaglia di Nikolajewka
L'Occidente si fa il suo listino prezzi per le terre rare. La sfida alla Cina
Dopo aver intessuto una rete di accordi commerciali per garantirsi gli approvvigionamenti di minerali critici e dando all’Europa un buon motivo per fare altrettanto, adesso l’America alza il tiro. Lavorando a un listino prezzi alternativo a quello cinese. E così il dominio del Dragone sulle materie prime è sempre più fragile
Il Pnrr tra energia ed economia circolare per una transizione ecologica permanente
“Il Pnrr non è un punto d’arrivo ma un’accelerazione verso una reale competitività strutturale europea e nazionale, dove l’energia e le filiere circolari sono fattori di stabilità economica e geopolitica”, ricorda Fabrizio Penna, capo dipartimento Pnrr del Mase, intervenendo alla seconda tappa di avvicinamento alle Giornate dell’Energia e dell’economia circolare di Trevi, organizzate da Globe Italia e da WEC Italia
Dentro la macchina di influenza di Mosca. Il leak che svela il ruolo di “The Company”
Un leak di documenti interni – oltre 1.400 pagine – offre uno sguardo senza precedenti su una rete globale di influenza che, da Mosca, intreccia narrativa, destabilizzazione politica e interessi industriali per ridefinire gli equilibri del cosiddetto Global South. L’inchiesta di Forbidden Stories
Cosa c’è dietro la diatriba sulle Isole Chagos tra Usa e Regno Unito
Il presidente americano cambia idea ancora una volta sull’accordo con il Regno Unito per la cessione dell’isola Diego Garcia nell’Oceano Indico, dove il Pentagono ha una base strategica. Perché è così importante (e cosa c’entra l’Iran)
Cosa significa l'intervento di Mattarella al Csm. La versione di Cazzola
“Né commettere ingiustizia, né ricambiare l’ingiustizia” è un celebre caposaldo della morale socratica. Per non incorrere in interpretazioni sbagliate e irriverenti ci piace pensare che il Presidente Sergio Mattarella avesse in mente questo principio etico quando si è recato irritualmente a presiedere il plenum dl Csm convocato per l’ordinaria amministrazione, allo scopo di chiedere il rispetto dovuto ad un organo di rilevanza costituzionale di cui è presidente lo stesso Capo dello Stato
Bonus alle famiglie ed Ets, anatomia del decreto bollette
Palazzo Chigi approva l’atteso testo che punta a sgonfiare i prezzi in bolletta. Il sistema Ets verrà modificato, disco verde dell’Europa permettendo, mentre per i nuclei più vulnerabili sarà previsto un bonus una tantum fino a 115 euro. E passa anche la riduzione della forbice tra il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam e quello all’ingrosso. Tutti i dettagli
Dallo spazio ai droni, un nuovo baricentro industriale italo-spagnolo nel panorama europeo
Due accordi firmati nello stesso giorno raccontano più di una semplice cooperazione industriale. A Roma, Indra consolida l’asse con Elt Group e Leonardo, intrecciando guerra elettronica, spazio, droni e cyber defence in un disegno unitario. Sullo sfondo, un’Europa chiamata a fare sistema e a presentarsi con partnership già rodate. Non un annuncio isolato, ma un tassello che chiarisce dove sta andando l’industria della difesa europea
Oncologia femminile, il nodo dell’accesso che mette alla prova il Ssn
Dal punto di vista di pazienti, volontari e clinici emerge la necessità di un approccio più umano, tempestivo e mirato, capace di coniugare sostenibilità, appropriatezza e qualità della cura. Gli spunti emersi dal vodcast di HealthCore