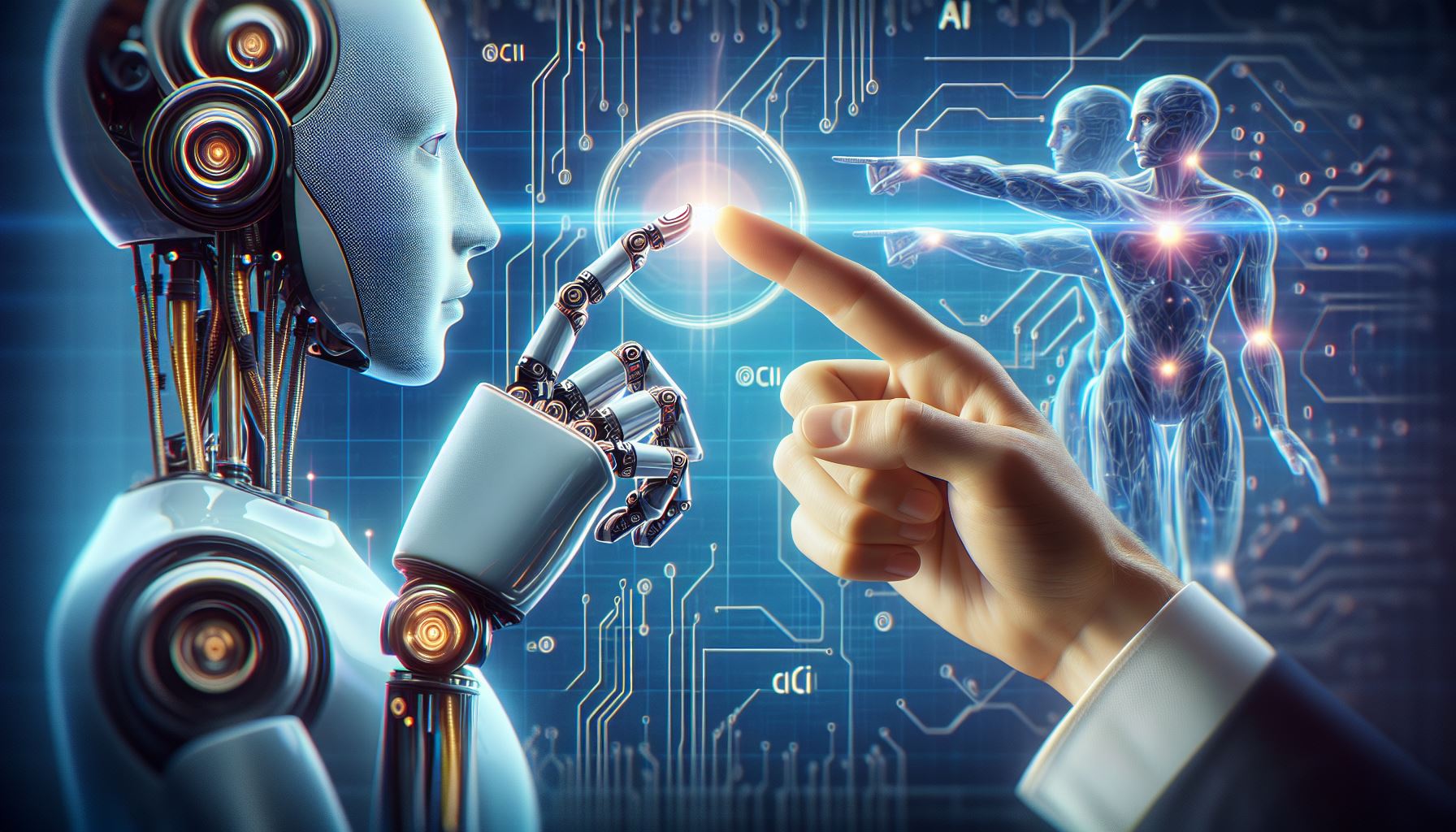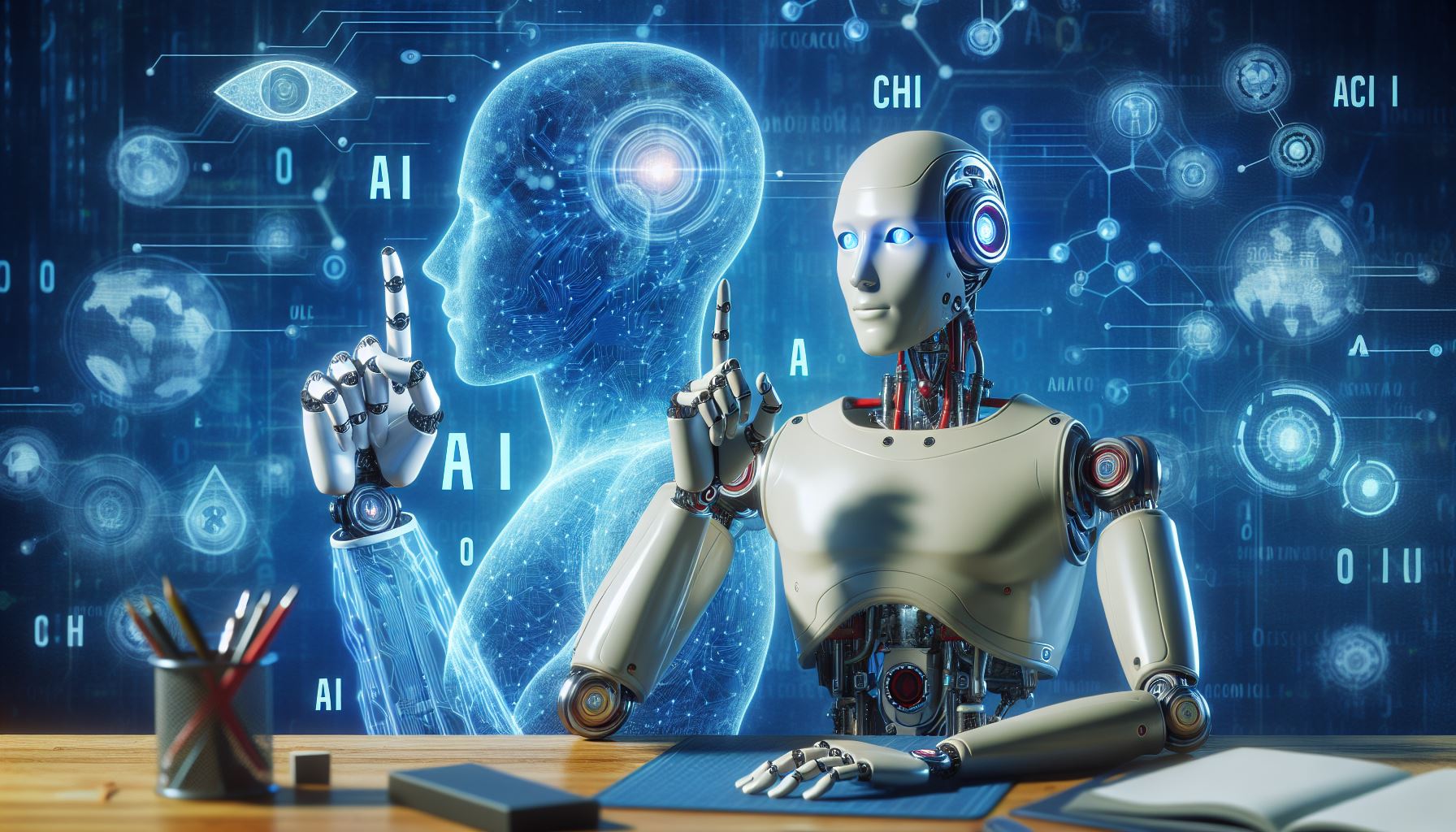La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi di Donald Trump e riafferma il primato del Congresso nella politica commerciale, confermando la tenuta dei checks and balances. La Casa Bianca studia nuove strade, ma lo scontro istituzionale resta aperto mentre si avvicinano le elezioni di midterm. L’analisi di Gianfranco Polillo
Archivi
Agente straniero o esperto di sicurezza? L'esperimento di Pagani con l'IA
Dalle operazioni di influenza documentate alla diplomazia pubblica praticata da tutte le democrazie occidentali, il confine tra soft power e interferenza resta sfumato. Un dialogo con l’intelligenza artificiale rivela quanto facilmente il sospetto possa emergere anche senza prove concrete. La riflessione di Alberto Pagani, esperto di intelligence e sicurezza, docente di Terrorismo Internazionale presso l’Università di Bologna e autore del Manuale di Intelligence e Servizi Segreti (Rubbettino, 2019), deputato dal 2013 al 2022
Stabilità artica, risorse e ruolo delle medie potenze. Conversazione con il prof. Heininen
Il professor Lassi Heininen sottolinea come l’Artico resti un’eccezione alla conflittualità globale, caratterizzato da stabilità geopolitica e cooperazione nonostante le tensioni tra grandi potenze. Il professor Heininen sarà tra i protagonisti del pre-evento “Greenland and Scenarios for Arctic Security” (per partecipare, seguire il link), organizzato dal Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University il 2 marzo alle ore 18:00, con la media partnership di Formiche e Decode39. L’incontro alla John Cabot apre il programma dell’Arctic Circle Rome Forum, iniziativa che si concentra sugli scenari di sicurezza, sui domini strategici e sul crescente interesse delle potenze extra-artiche per la regione
Quando il Gulag silenziava i procuratori. La recensione di Ciccotti
Il regista russo Sergheij Loznycja con “Due procuratori” (2025) racconta la storia, ambientata nella Urss degli anni Trenta, di un giovane procuratore che crede e si batte per il rispetto del diritto socialista, prendendo le difese dei reclusi dei gulag, ingiustamente arrestati e torturati, sapendo che può fare la stessa fine. Un magistrale racconto kafkiano declinato dalla livida fotografia alla Jan Němec
Ecco perché Roma rimarrà sempre un partner irrinunciabile per Washington
Anche in uno scenario di distacco di Washington dalla Nato e dall’Europa, gli Stati Uniti dovrebbero mantenere un rapporto privilegiato con l’Italia come accesso stabile ed affidabile al Mediterraneo. L’opinione di Niccolò Comini
Il futuro del welfare passa dalla cultura condivisa. Gli spunti di Monti
Il sistema pensionistico italiano mostra crepe tra debito pubblico e invecchiamento della popolazione. La soluzione passa da un mix di previdenza pubblica, complementare e risparmio individuale, ma incertezza normativa e lavoro precario frenano l’azione dei cittadini. Serve un cambio culturale: più educazione finanziaria, strumenti concreti e partecipazione collettiva per rendere la pianificazione del futuro una pratica quotidiana
Emergenza abitativa, forse ci siamo. L'analisi di Riccardo Pedrizzi
La crisi abitativa in Europa è sempre più grave: il 17% vive in case sovraffollate, quasi uno su dieci non riesce a riscaldarle e un milione è senza dimora. In Italia 1,5 milioni di famiglie affrontano difficoltà soprattutto sugli affitti, mentre quasi 5 milioni di proprietari non hanno risorse per riqualificare casa. Il paradosso sono 8,5 milioni di “case dormienti” inutilizzate. L’Europa punta a 150 miliardi per alloggi sostenibili, e il governo italiano promette 100mila nuovi alloggi in dieci anni. Il punto di Pedrizzi
Così l'IA aumenta produttività e crescita. L'analisi di Bartoli
L’aumento della produttività totale significa che con le stesse risorse si produce di più. Dal 2030, due milioni di lavoratori all’anno mancheranno al mercato del lavoro europeo a causa della crisi demografica. Ma l’IA può colmare la quasi totalità del gap. L’analisi di Gloria Bartoli, dell’Osservatorio produttività e benessere della Fondazione Tor Vergata, seguito del ciclo di interventi legati al volume Una bussola per l’Europa, a cura di Luigi Paganetto
Come governare l’innovazione del XXI secolo. Il nuovo paradigma spiegato da Shivakumar (Csis)
Sujai Shivakumar, senior fellow e direttore del programma Renewing american innovation presso il Center for strategic and international studies (Csis), analizza i limiti del modello tradizionale dell’innovazione e la necessità di una strategia sistemica che integri ricerca, manifattura e cooperazione transatlantica per affrontare la competizione globale
La competizione globale del biotech non consente ambiguità. Picaro (FdI) spiega perché
La competizione globale nel biotech è diventata una questione geopolitica che incide su sicurezza, crescita e sovranità sanitaria. Secondo Michele Picaro, europarlamentare e membro commissione per la Sanità pubblica, l’Europa deve superare il modello puramente regolatorio e dotarsi di una vera strategia industriale per restare competitiva