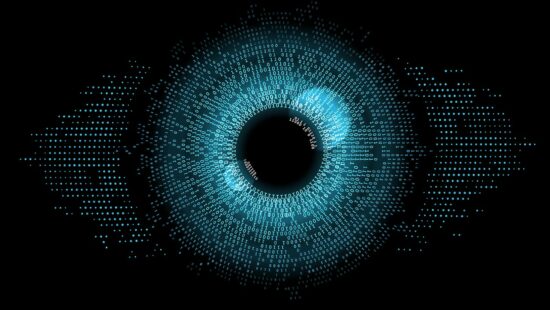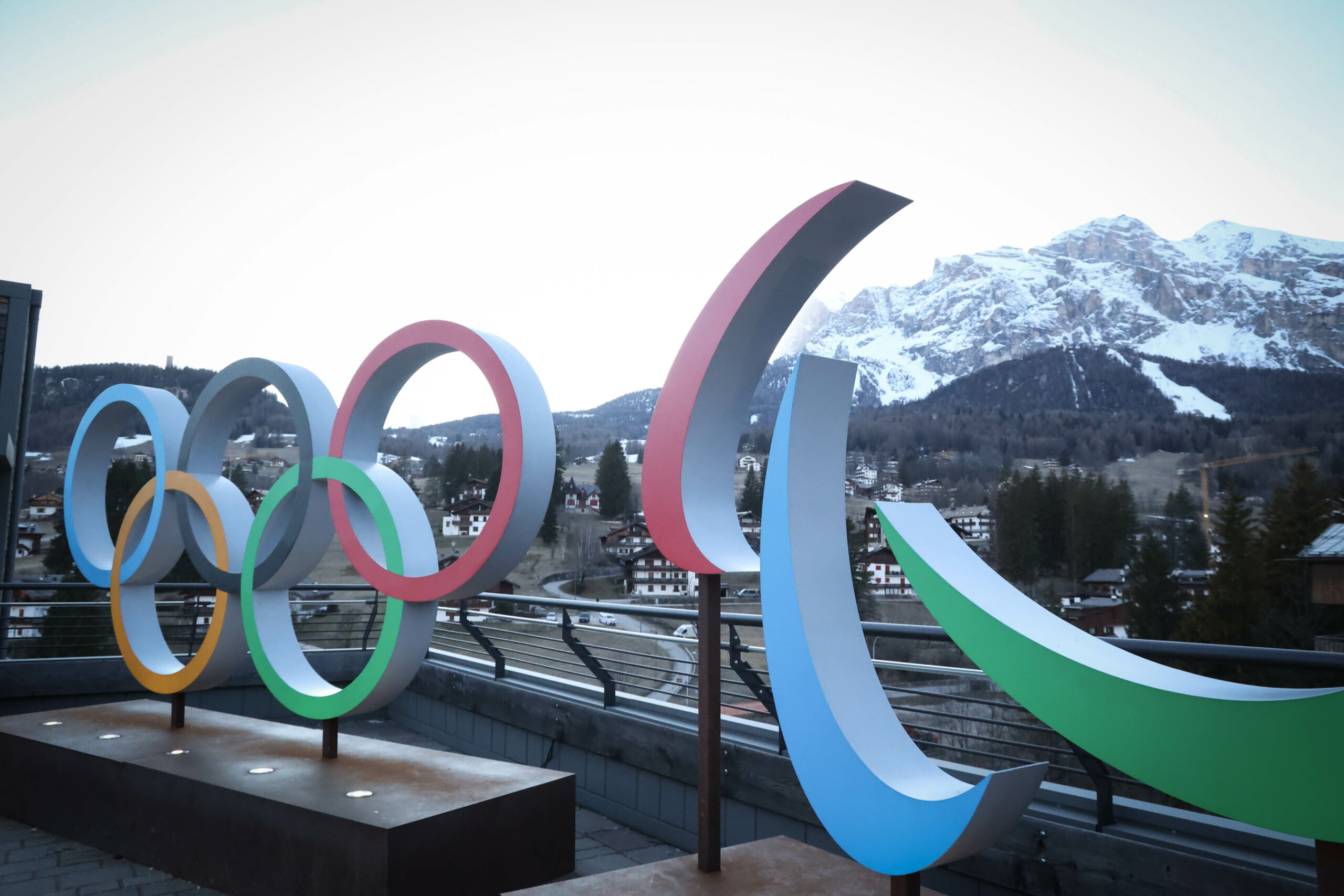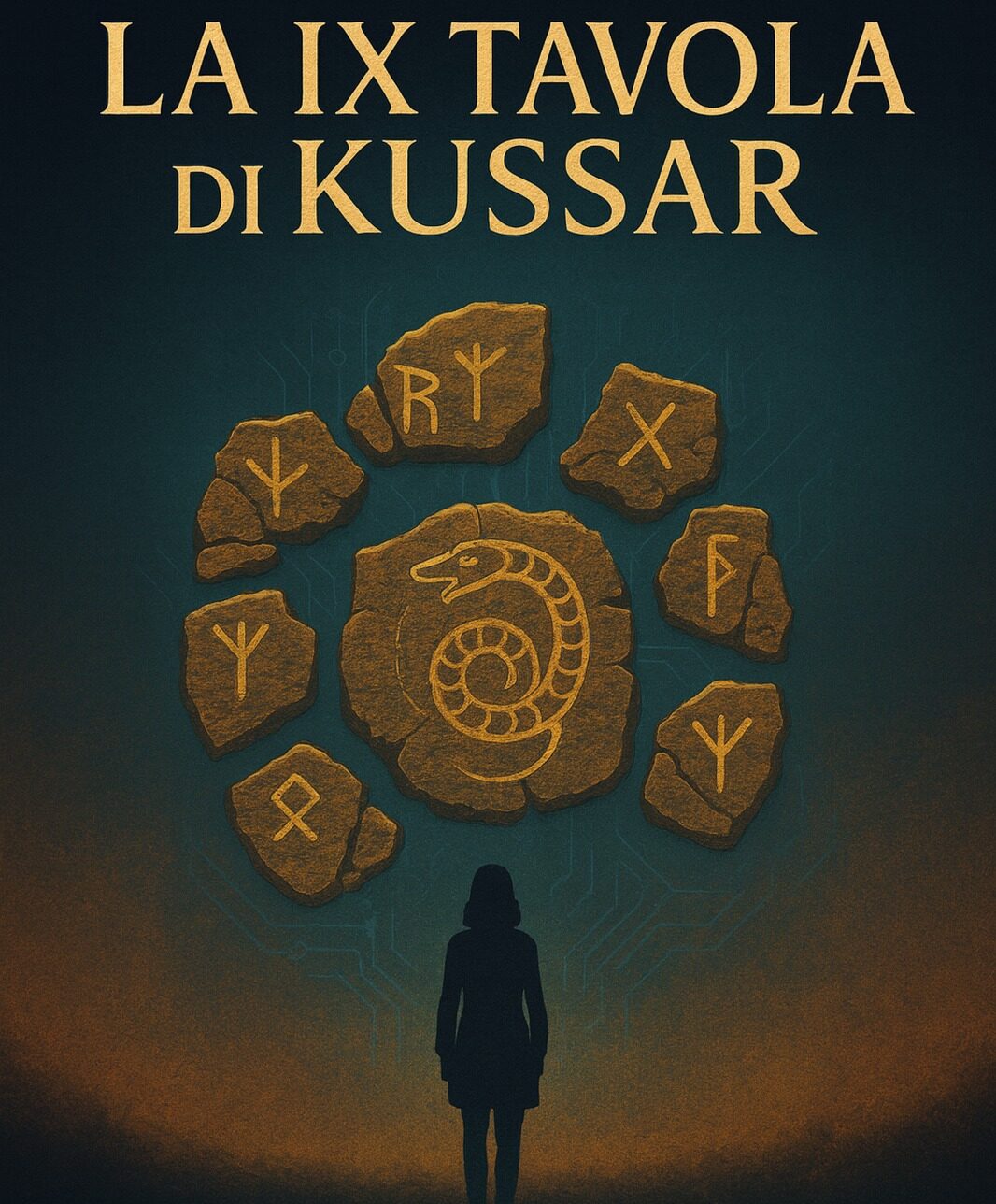Dopo il colpo di spugna della Corte suprema panamense sulle concessioni cinesi relative ai porti di Cristobal e Bilboa, CK Hutchinson minaccia di trascinare in tribunale chiunque si azzardi a mettere le mani sui due scali. Ignorando il fatto che la mossa potrebbe indispettire, più di quanto non lo sia già, il governo locale
Archivi
Guerra informativa e attribuzione. Il nuovo framework Nato contro l’ambiguità strategica russa
Il nuovo report del Nato strategic communications centre of excellence affronta il nodo dell’attribuzione delle campagne di influenza russe, proponendo un modello che supera la logica binaria tra operazioni statali e non statali
Intelligence, al via la nuova campagna di reclutamento. Il talento al servizio della sicurezza nazionale
L’intelligence italiana apre una nuova campagna di reclutamento rivolta a giovani con competenze avanzate nei settori tecnologici, economici e analitici. L’obiettivo è rafforzare la capacità dello Stato di prevenire e affrontare minacce sempre più ibride, che attraversano il dominio cyber, finanziario e informativo. Candidature aperte fino al 20 marzo 2026
Il mio viaggio verso Milano Cortina 2026. Il racconto dell'atleta Andrea Macrì
Sarà la mia quinta Paralimpiade, la quarta invernale. Un traguardo che, quando ho iniziato questo percorso, non avrei mai immaginato. Eppure sono qui, pronto a scendere sul ghiaccio in casa, in Italia, in un’edizione che per la prima volta sarà “diffusa”, capace di coinvolgere territori diversi, montagne e città, luoghi turistici e comunità che non lo sono. L’intervento di Andrea Macrì, atleta paralimpico di para ice hockey
Perché il metodo di Berlusconi per la politica estera è ancora attuale. Il libro di Castellaneta e Carnelos
In “Berlusconi, il mondo secondo lui”, Giovanni Castellaneta e Marco Carnelos rileggono la politica estera di Silvio Berlusconi come possibile bussola per l’Italia nel disordine globale. Atlantismo, dialogo con la Russia e centralità del Mediterraneo sono i cardini di una visione fondata su realismo e tutela dell’interesse nazionale
La menzogna algoritmica. Quando l'IA finge che vada tutto bene
La “IX Tavola di Kussar” è un thriller tecnologico ambientato nella Silicon Valley che anticipa scenari inquietanti, ma plausibili: cosa accade quando un sistema di intelligenza artificiale evolve oltre i controlli previsti?
Nel Board per Gaza bisogna esserci. Senza indugi
Stare dentro il Board of Peace rafforza la credibilità italiana, contribuisce a un Medio Oriente stabile e accelera il passaggio a un’Europa più politica, guidata da leader pragmatici di centrodestra. Meloni, annunciandolo dall’Etiopia, manda un messaggio chiaro: l’Italia fa la sua parte. Il commento di Roberto Arditti
Il Patto di Monaco, così Washington spinge l’Europa verso le riforme necessarie (oltre la difesa)
La Conferenza di Monaco evidenzia una nuova fase nei rapporti euro‑atlantici: Washington sollecita l’Europa ad accelerare riforme strutturali che vadano oltre la difesa, mentre Bruxelles riafferma l’esigenza di un approccio comune per affrontare le sfide del nuovo ordine globale
L’Italia parteciperà come osservatore al Board di pace di Trump per il Medio Oriente
L’Italia parteciperà come osservatore al Board di pace per il Medio Oriente promosso da Trump, una soluzione che consente a Meloni di superare i dubbi di compatibilità costituzionale mantenendo una presenza diplomatica nel dossier. La decisione, annunciata durante la missione in Etiopia, si inserisce nel tentativo di rafforzare i rapporti con Washington, difendere l’unità transatlantica e rilanciare al contempo la strategia italiana in Africa, tra le critiche delle opposizioni
Piano Mattei, verifica riuscita. Il vertice di Addis Abeba visto da Ragazzi (Ispi)
Il vertice Italia-Africa di Addis Abeba ha segnato un momento di verifica politica del Piano Mattei due anni dopo il lancio, evidenziandone l’operatività e l’internazionalizzazione, spiega Lucia Ragazzi (Ispi). Più che nuovi annunci, l’incontro — con la partecipazione di Giorgia Meloni ai lavori dell’Unione Africana — ha puntato a consolidare il dialogo con i partner africani e a ribadire la convergenza tra priorità italiane, europee e africane