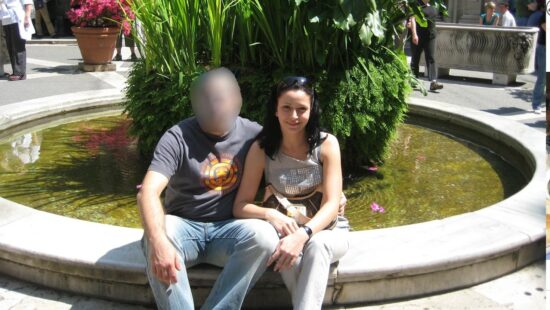Il successo di Bellingcat può essere esasperante per Mosca. Ma non è un segreto. Edward Lucas, non-resident senior fellow al Center for European Policy Analysis, spiega perché. Ed è sicuro: non sarà l’ultima inchiesta
Archivi
Il terzo polo e i cattolici sociali e popolari. L'opinione di Merlo
Il terzo polo non può fare a meno di quella cultura cattolico popolare e sociale che, nel corso della storia politica italiana, ha saputo contribuire ad affrontare e a risolvere i principali nodi politici sul tappeto. L’opinione di Giorgio Merlo
Celestino V, il testimone coraggioso. La riflessione di Cristiano
Quella dell’Aquila si iscriverà certamente nella storia della Chiesa come una giornata memorabile, e dà la cifra di come si imposterà da domani la discussione sull’argomento degli argomenti: “come predicare il Vangelo”?
Alta tensione in Libia. Gli scontri mortali e i rischi per la regione
Le lotte intestine tornano a surriscaldare il clima in Libia. Le tensioni tra i vari centri del potere sfociano nuovamente in scontri armati: decine i morti, con il rischio che l’escalation possa produrre alterazioni ai delicati equilibri che si sono creati tra gli attorni esterni che si muovono sul dossier
Perché l’ossessione del centrodestra per il Quirinale? Il mosaico di Fusi
È come se la triade FdI-Lega-FI, consapevole o convinta di avere i numeri dalla sua parte, ponesse sullo sfondo la battaglia contro il centrosinistra per concentrarsi sul Rubicone da attraversare per essere legittimata a governare: il via libera del Quirinale
Bollette in vetrina, il disagio degli esercenti e il difetto della politica. Parla Musacci (Fipe)
Il vicepresidente dell’associazione di categoria: “I rigassificatori a Piombino e l’eventuale messa a punto di centrali nucleari di ultima generazione prevedono tempi troppo lunghi. Nel frattempo, si rischia di perdere centinaia e centinaia di imprese”
Tutti gli errori capitali dei sindacati secondo Cazzola
Se il mondo del lavoro si sente rappresentato dalla destra sovranpopulista, ciò significa che le politiche portate avanti da questi partiti e movimenti sono giuste, che fanno gli interessi del mondo del lavoro e che, pertanto, la sinistra risolverebbe i suoi problemi di rappresentanza se ritornasse ad impegnarsi in quelle politiche che la destra gli ha scippato? Il commento di Giuliano Cazzola
La settimana dei leader politici. La social hit di Giordano
Per Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Matteo Salvini è TikTok la piattaforma più coinvolgente. Per Calenda, Letta e Renzi a essere più performante è invece il canale Instagram. La social hit settimanale di Domenico Giordano (Arcadia)
Ritorno al futuro sulla Luna? La missione Artemis secondo Spagnulo
La Nasa si appresta a lanciare il nuovo gigantesco razzo SLS che spedirà intorno alla Luna una capsula senza equipaggio. Si tratta del primo test per un vero allunaggio che secondo i piani avverrà nel 2025. Il lancio di SLS ha scatenato in tutto il mondo nuovo entusiasmo per quello che appare come un “Ritorno al Futuro” sulla Luna. Ma è davvero così? L’opinione dell’ingegnere esperto aerospaziale
Phisikk du role - Georgia on my mind
Per rendere stabile il suo consenso la leader di Fratelli d’Italia dovrà muoversi nella logica del consolidamento che si faccia partito-organizzazione e non partito-emozione temporanea. Se è tutto poggiato sul brand, sullo spot azzeccato dell’ultimo momento per conquistare non la parte razionale delle meningi dell’elettore, ma solo il suo istinto, beh, lo spot poi finisce presto, soppiantato da qualche nuovo brand. La rubrica di Pino Pisicchio