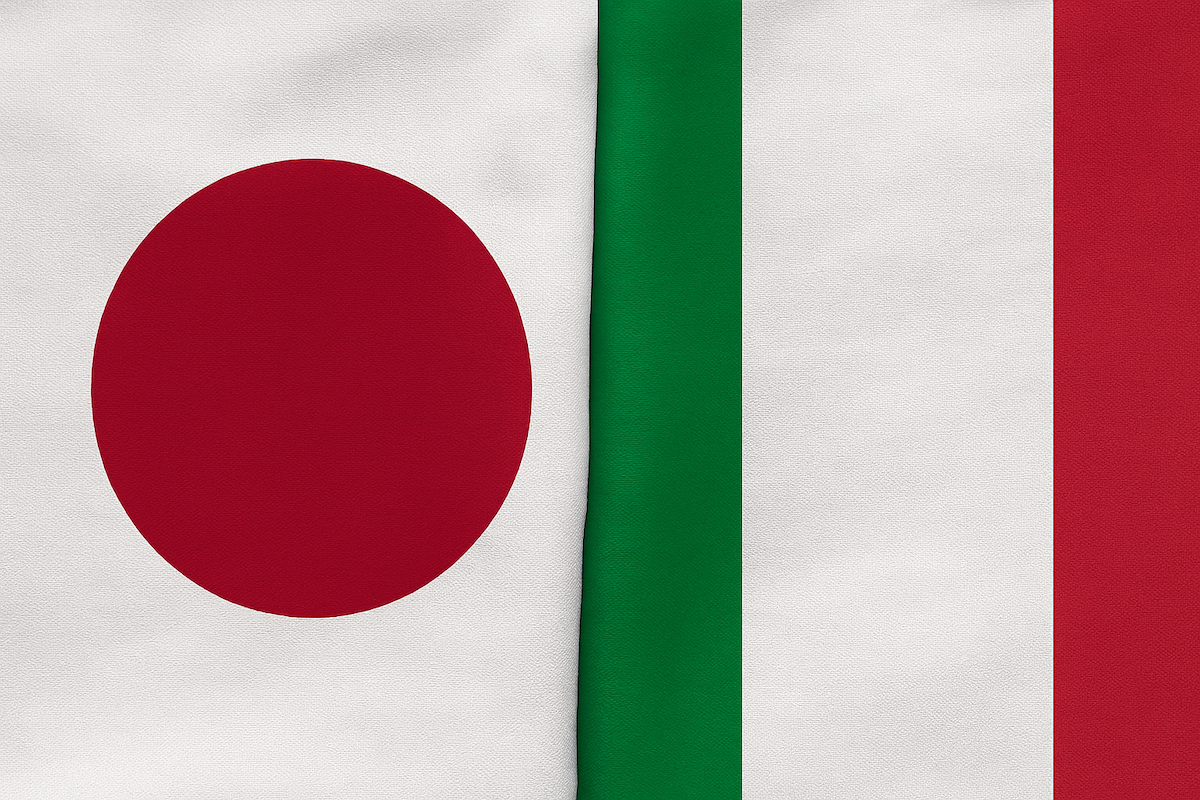Con l’arrivo di Mykhailo Fedorov alla guida della Difesa, Kyiv segnala la volontà di puntare ancora di più su tecnologia, droni e capacità asimmetriche per reggere un conflitto in cui l’innovazione e l’adattamento tecnologico giocano un ruolo più che mai cruciale
Archivi
Strade Sicure e il perdurante deficit di cultura della difesa in Italia
Solo attraverso un investimento sistematico nella dimensione educativa è possibile rafforzare la cultura strategica del Paese, favorire un dibattito pubblico più informato e, in ultima analisi, creare le condizioni politiche e sociali per restituire alle Forze armate un impiego coerente con la loro missione primaria. L’opinione di Matteo Mazziotti di Celso (Università di Genova)
Sabotaggio, finanza e zone grigie. Come Mosca opera nello spazio europeo
Il sabotaggio è diventato una componente strutturale della guerra ibrida russa in Europa, e se seguire il denaro aiuta a leggere il sistema, le ultime indiscrezioni provenienti dai Balcani permettono di tracciarne la rete
Così Roma e Tokyo incrociano le loro rotte. Conversazione con il prof. Patalano
Secondo Alessio Patalano (King’s College), Italia e Giappone occupano una posizione “complementare” nelle rispettive aree strategiche e condividono una leadership politica capace di incidere sui dossier di sicurezza in Europa e Indo-Pacifico. La visita di Giorgia Meloni a Tokyo si inserisce così in una fase favorevole per rafforzare cooperazione strategica, difesa e coordinamento economico
Chi è “Rosita”, la modella e influencer legata ai narcos in Venezuela
Omicidi, fughe dal carcere, rapine. La giovane Jimena Romina Araya Navarro sarebbe legata ad una trama criminale che rimanda al Tren de Aragua, l’organizzazione terroristica che le autorità americane cercano di smantellare
Iran, dopo una notte di tensioni le rassicurazioni di Trump (per ora)
Trump abbassa i toni sull’Iran mentre Washington mantiene aperta l’opzione militare e la regione si muove per evitare un’escalation incontrollata. In questo equilibrio fragile, Israele osserva una finestra strategica favorevole, consapevole che le decisioni finali spettano agli Stati Uniti
Investire in salute per rafforzare Italia ed Europa. Il dibattito in Senato
Oggi in Sala Zuccari, al Senato, la salute è stata letta come architrave della governance pubblica, dal livello nazionale a quello europeo. Zaffini: non politica settoriale, ma bene pubblico universale, investimento per la crescita e leva di stabilità democratica
Anti-americani. Come sono diventati gli italiani secondo Swg
Il Radar Swg mostra una crescita dell’anti-americanismo in Italia: gli Stati Uniti sono sempre più percepiti come una minaccia alla pace globale, più della Cina e quasi quanto la Russia. Le scelte su Venezuela e Groenlandia incrinano l’immagine dell’alleato storico, in un contesto segnato da paura dei conflitti e debolezza europea. Un segnale critico per la tenuta dei valori occidentali
Muscat, Tokyo, Seul. La missione globale di Meloni secondo Pelanda
Secondo Carlo Pelanda, economista e saggista, l’Italia può guardare con rinnovato ottimismo al suo futuro internazionale e alla presenza nei dossier che contano. Non sarà facile e implicherà una duplice scelta, per l’Unione europea e per gli Stati Uniti. Ma proprio questo modello ha portato il Paese a muoversi da solo come moltiplicatore di forza
Cosa c'è dietro allo sventato attentato al presidente del Costa Rica
Alla vigilia delle elezioni del 1° febbraio, il Costa Rica affronta uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Il presunto complotto contro Rodrigo Chaves evidenzia l’impatto crescente della criminalità organizzata sulla politica nazionale