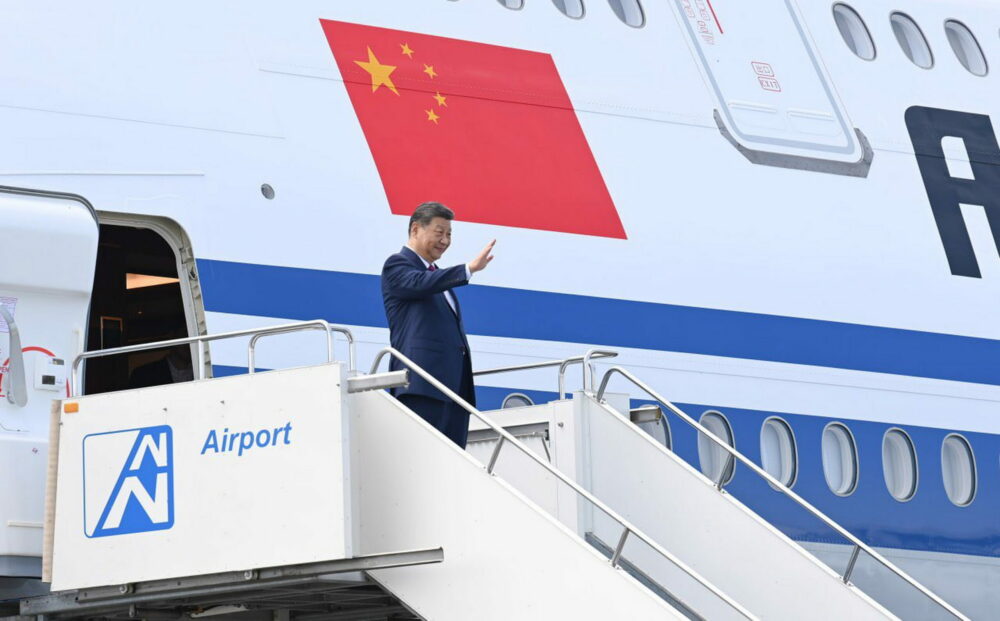Un ponte lungo oltre 5.300 chilometri. Roma e Riyadh sono più che mai vicine. Due mondi lontani, due economie molto diverse. Eppure, gli incastri ci sono. L’Arabia saudita è oggi per l’Italia terra di grandi opportunità. La prova? Sta tutta nel Business Forum Italia-Arabia 2025, tenutosi proprio presso la capitale araba. Oltre venti accordi tra imprese di grosso calibro, una girandola di incontri e tanti buoni propositi hanno dato sapore e consistenza all’evento mai così strategico per le relazioni economiche tra i due Paesi. Organizzato da Ice Agenzia con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Riyadh e delle principali controparti saudite, il Forum si è tradotto in una vera e propria azione di sistema Paese, rafforzata dalla presenza del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.
ANATOMIA DI UN FORUM
Ad animare il Forum, per parte italiana, i vertici di Ice, Sace, Simest e Confindustria, oltre a imprenditori e manager di oltre 430 aziende tricolore di diversi settori, per un totale di 805 partecipanti italiani registrati, di cui 385 del settore infrastrutture, 146 dei settori altamente tecnologici, 99 della farmaceutica, 95 dell’agritech e 80 dell’industria dello sport. E ancora, cinque macro-aree tematiche per oltre 340 incontri B2B tra le imprese italiane e più di 600 realtà saudite. Per le imprese italiane (che nei primi nove mesi del 2025 hanno esportato nel Regno beni per un valore di 4,4 miliardi di euro, in aumento del 4,3% rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Ice) quello dell’Arabia è un mercato chiave per aumentare ulteriormente le proprie esportazioni, soprattutto in questa fase storica di ridefinizione degli equilibri e delle rotte del commercio globale.
D’altro canto, per l’Arabia Saudita, l’Italia, con le sue eccellenze produttive in tutti i settori, rappresenta un partner ideale per raggiungere gli obiettivi della Vision 2030, ovvero la strategia di sviluppo varata dal governo nel 2016, che punta alla diversificazione dell’economia nazionale, riducendo la dipendenza dal petrolio attraverso importanti investimenti nei settori della manifattura, delle infrastrutture, delle energie rinnovabili, del turismo, ma anche della cultura e dello sport.
IL PESO DELL’EXPORT
I numeri forniti dalla Farnesina, comunque, parlano fin troppo chiaro. L’Arabia Saudita è oggi il secondo mercato di sbocco delle esportazioni italiane nell’area Medio-Oriente-Nordafrica. Dalla fine della pandemia del 2020 fino a dicembre 2024, l’interscambio commerciale tra Italia e Arabia Saudita ha registrato una fase di espansione (+67%). Dal 2022 l’export è aumentato di quasi il 20% su base annua (l’aumento è stato del 27,9% nel 2024). Ancora, nel 2024, l’Italia ha guadagnato una posizione tra i principali fornitori sauditi, salendo al settimo posto, con un incremento delle importazioni di beni italiani pari al 35,2%. L’interscambio tra i due Paesi è stato di 10,3 miliardi di euro nel 2024, con un saldo commerciale positivo per l’Italia di 2,1 miliardi, grazie a 6,2 miliardi di euro di export (+27,9% rispetto al 2023), trainato in particolare dalle vendite di macchinari e prodotti farmaceutici, ma anche semilavorati per l’industria, mobili e mezzi di trasporto.
L’ASSE DELL’ENERGIA…
Entrando nel merito del Forum, sono tanti i terreni che accomunano Italia e Arabia Saudita. Sempre secondo i dati forniti dalla Farnesina, per esempio, l’Arabia Saudita è uno dei player più rilevanti a livello energetico, grazie alle sue ampie riserve di idrocarburi, e sta dando sempre maggior importanza alla diversificazione del mix energetico grazie alle energie rinnovabili, l’idrogeno e i suoi derivati, con l’obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2060 (attraverso la Saudi Green Initiative). In tal senso, nel luglio 2024 Saipem ha firmato contratti per un valore complessivo di 3,5 miliardi di dollari per l’espansione dei giacimenti offshore di Marjan, Zuluf e Safaniyah.
D’altronde, il Piano nazionale saudita per le energie rinnovabili, che punta a raggiungere il 50% di rinnovabili nel mix energetico entro il 2030, offre nuove opportunità a imprese come Snam, attiva anche nel settore dell’idrogeno. Le italiane De Nora e BH–Nuovo Pignone partecipano come partner tecnologici al progetto per la più grande centrale al mondo di esportazione di ammoniaca verde, sviluppato da Neom City, AcwaPower e Air Product, già completato all’80% e operativo dal 2026. Sono, poi, in corso contatti tra aziende italiane e saudite in ambiti quali idrogeno, smart grid e transizione energetica. Ed è inoltre in preparazione la prima edizione degli Energy Days Italia–Arabia Saudita, prevista per la prima metà del 2026, volta a rafforzare la cooperazione nei settori oil & gas, elettricità ed efficienza energetica.
… E QUELLO DELLE INFRASTRUTTURE
Anche le infrastrutture rappresentano un ulteriore ambito prioritario della cooperazione bilaterale, in linea con la strategia Vision 2030. Qui la palla passa a Webuild, attiva nei progetti della smart city Neom, nella metropolitana di Riyadh (linee 2 e 3, con nuove gare in corso) e nello sviluppo del quartiere storico di Diriyah. Anche per questo Tajani ha visitato il Diriyah Gate Development Project a Riyadh, parte del programma Saudi Vision 2030 e realizzato da Webuild per conto della Diriyah Development Gate Authority. Il progetto punta a trasformare Diriyah, sede del sito Unesco di At-Turaif, in un polo residenziale, culturale e commerciale di livello mondiale, ispirato all’architettura tradizionale Nadji.
La società, nel complesso, è impegnata nella realizzazione di opere di grande complessità: dal Super Basement Works, che ha raggiunto uno stato di realizzazione molto avanzato ed è una delle infrastrutture sotterranee più grandi mai realizzate in Arabia Saudita, con tre livelli interrati per un parcheggio da 10.500 posti auto su circa 1 milione di metri quadrati, e oltre 2 km di tunnel a quattro corsie, collegati alla rete stradale di Riyadh; al distretto Retail & Lifestyle, che ospiterà oltre 70 edifici e spazi pubblici su 365.000 metri quadrati, interamente pedonale, con piazze, souk e cortili che richiamano i villaggi sauditi, integrando tecnologie per efficienza energetica e sostenibilità. A questi si aggiungono ulteriori opere strutturali collegate alla costruzione di uffici, hospitality (6 hotel 5 stelle) e la Grande Moschea. E poi c’è Ferrovie, che gestisce i servizi di operation&maintenance per quattro linee della metropolitana di Riyadh e mira a consolidare la propria presenza attraverso un memorandum con Saudi Arabia Railways, siglato proprio in occasione del Forum.
IL FATTORE DIFESA
Ma è il settore della Difesa a rappresentare la priorità strategica per l’Arabia Saudita, che nel 2025 ha destinato 78 miliardi di dollari (pari al 22% della spesa pubblica e al 7,3% del Pil) al comparto, collocandosi tra i primi dieci Paesi al mondo per investimenti militari. Il Regno mira a conseguire entro il 2030 una produzione locale pari al 50% del fabbisogno nazionale nel settore difesa, in linea con la Vision 2030. In tale contesto, l’Arabia Saudita rappresenta un mercato di primaria importanza per le imprese italiane, in particolare Leonardo, Fincantieri ed Elettronica, che stanno consolidando la propria presenza attraverso accordi industriali e programmi congiunti. Nel novembre 2024, oltre 30 aziende italiane hanno partecipato a Riyadh agli Italian Industry Days, organizzati congiuntamente dai ministeri della Difesa italiano e saudita, con il sostegno della stessa Farnesina e dell’Aiad, a testimonianza del crescente interesse industriale verso il mercato saudita.
Infine, anche il commercio bilaterale nel settore farmaceutico ha registrato una forte espansione, raggiungendo un valore di 434,7 milioni di euro, con un significativo incremento del +102,6% rispetto al 2023. A determinare questa crescita sono state soprattutto le esportazioni italiane, pari a 433,2 milioni di euro (+104,4%). Il settore moda e lusso è uno dei settori prioritari dell’export italiano in Arabia Saudita, con quasi 270 milioni di euro di export nel 2024 e un incremento del 18% nel 2024.
GLI ACCORDI FIRMATI A RIYADH
Ed ecco le intese sottoscritte nell’ambito del Forum. Durante il Forum per gli investimenti Arabia Saudita-Italia, Tajani e il ministro dell’Investimento saudita Khalid al Falih hanno fatto da corollario alla firma di 22 accordi bilaterali in settori chiavi come telecomunicazioni, tecnologia, commercio, turismo, sanità, agricoltura, acqua, cultura e sport. Tra le intese, quella di Cassa depositi e prestiti, Simest e Camera di commercio italo-araba che ha l’obiettivo di intensificare la collaborazione economica tra le imprese italiane e quelle dei Paesi arabi, con particolare attenzione alle opportunità offerte dall’Arabia Saudita.
L’accordo mira a creare un canale strutturato, stabile e permanente di cooperazione, facilitando l’accesso delle aziende italiane ai mercati dell’area e promuovendo partnership industriali e commerciali ad alto valore aggiunto. Di più. Il memorandum rappresenta un passo significativo per trasformare le grandi opportunità legate ai mega-programmi sauditi e alla Vision 2030 in collaborazioni operative concrete tra imprese italiane e arabe. La cooperazione tra Cdp, Simest e Jiacc permetterà infatti di accelerare processi di internazionalizzazione, favorire investimenti reciproci e rafforzare la presenza dell’Italia in una delle aree più dinamiche e strategiche del panorama globale. In tal senso, l’intesa prevede attività congiunte in quattro aree chiave: business matching e partnership industriali; informazione e orientamento ai mercati arabi, con focus sull’Arabia Saudita, eventi e missioni congiunte.
Ancora, Simest, la società di Cassa per l’internazionalizzazione delle imprese italiane guidata da Regina Corradini d’Arienzo, ha inaugurato la sua nuova antenna a Riyadh. L’apertura del presidio Simest punta a consolidare ulteriormente il supporto operativo alle imprese italiane impegnate in percorsi di espansione internazionale, offrendo assistenza diretta sia nella fase di ingresso sia in quella di consolidamento in un mercato tra i più dinamici al mondo. Il Medio Oriente rappresenta infatti un’area strategica per la crescita internazionale dell’Italia, grazie a relazioni economiche in forte sviluppo e a un crescente interesse dei partner locali per le tecnologie e il know-how italiano.
Tra gli altri accordi, l’intesa per la riassicurazione tra Sace e Saudi Exim volto a condividere il rischio su futuri progetti di credito all’esportazione di interesse reciproco, sulla base dei rispettivi contenuti nazionali, tra la medesima Sace e Saudi Electricity Company volto ad aumentare gli approvvigionamenti dall’Italia e tra il Politecnico di Torino e Kaust per la cooperazione in formazione, studio e ricerca. E sempre con Kaust Fincantieri ha sottoscritto il progetto di borse di studio congiunte per attività di ricerca connesse al settore marittimo. Altre intese, poi, hanno riguardato La Semaforica e Saudi Controls (produzione di lanterne semaforiche in Arabia Saudita) e Elettronica e Kaust (cooperazione su tecnologie avanzate e ricerca), Almaviva e Solutions by Stc, Valvitalia e Saudi-Fal, Blackshape e Al Qahtani Group (accordo commerciale con la prospettiva futura di sviluppare un accordo industriale più ampio con una componente di localizzazione) e Acea e Mowah. E ancora, Nuraxi con Delta Medical Laboratories per la cooperazione tecnica e Gksd e ministero della Salute per la collaborazione in materia di supporto alla formazione professionale dei medici.
CACCIA A NUOVI INVESTIMENTI
E che ci sia ancora altro spazio di manovra, lo provano le parole di Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti. Per la quale “l’Arabia Saudita è già il secondo mercato mediorientale per export e per export potenziale dell’Italia, con importanti margini di crescita in diversi settori ad alto valore aggiunto. Esiste un potenziale aggiuntivo di 1,2 miliardi di euro sfruttando la capacità produttiva attuale, cui si sommano altri 7,1 miliardi ottenibili attraverso investimenti in ricerca, innovazione e ampliamento produttivo. La meccanica strumentale guida questo potenziale con 355 milioni, seguita dai prodotti in legno con 175 milioni, a conferma della forte domanda saudita nei comparti più dinamici”.
Guardando alle prospettive di medio periodo, Cimmino ha detto: “Expo Riyadh 2030 sarà un acceleratore formidabile, in grado di generare nuove opportunità di investimento e visibilità internazionale. Per coglierle appieno servono continuità, programmazione e un’azione coordinata del Sistema Paese.
Confindustria metterà a disposizione delle imprese strumenti data-driven, come la piattaforma Expand per accompagnare in modo stabile e strutturato la presenza italiana nel Regno”. Cimmino ha evidenziato il ruolo dell’Arabia “al crocevia tra Europa, Asia e Medio Oriente e già oggi al centro delle principali rotte commerciali globali”, ricordando che l’Arabia Saudita è “l’unico Paese arabo del G20 e tra i firmatari dell’Imec, il corridoio India-Medio Oriente-Europa destinato a ridisegnare le catene del valore”.