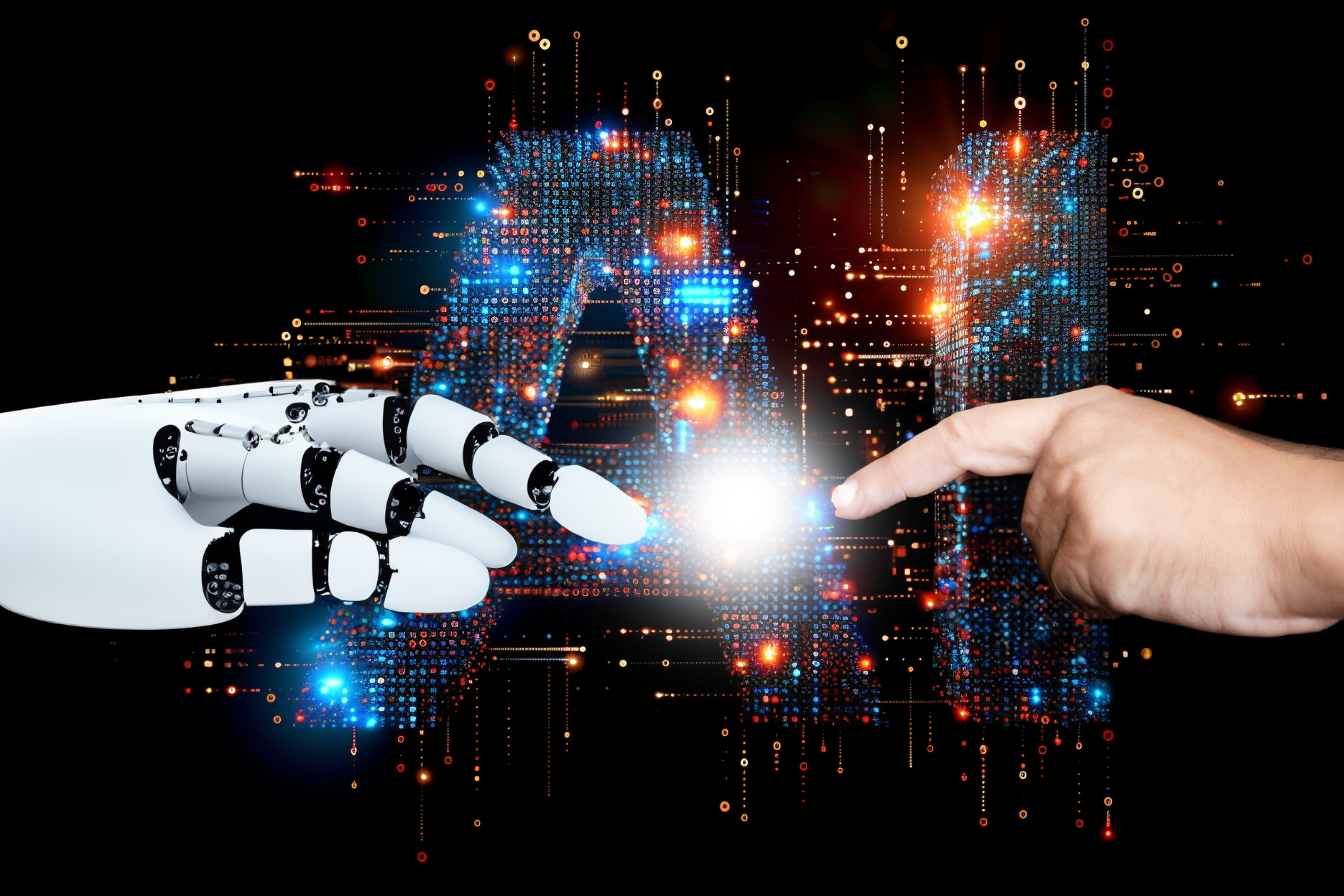Gli sconfinamenti dei caccia russi nei cieli del Baltico sono la spia del tentativo di Mosca di testare le difesa tanto dell’alleanza quanto dell’Ue. Per questa ragione l’esercitazione Dacian Fall 2025 si tiene i questi giorni in Romania e Bulgaria
Archivi
Il Pkk lascia la Turchia, svolta storica per il gruppo (e vittoria per Erdogan?)
Il Pkk ha annunciato il ritiro totale delle proprie forze dalla Turchia, trasferendole nel Kurdistan iracheno, in linea con l’appello di Abdullah Öcalan alla smobilitazione. La mossa segna una nuova fase nel processo di pace con Ankara e punta alla transizione del movimento verso la lotta politica democratica
Dal sovranismo all'autorevolezza, come Meloni ha smentito l'isolamento e rafforzato l'Italia. Parla Checchia
“Meloni ha spiazzato tutti i detrattori con una posizione pragmatica nei fronti di crisi e fortemente improntata a un occidentalismo non ricurvo su se stesso, ma autorevole e identitario”. Conversazione con l’esperto diplomatico Gabriele Checchia, a tre anni dalla nascita del governo Meloni. Un bilancio sulla sua politica estera e la postura internazionale di Roma
Newman e l'Università "ideale". L'esperimento di Dublino ora è Magistero della Chiesa
La proclamazione di San Newman a Dottore della Chiesa eleva a dottrina il suo progetto educativo a Dublino. Promosse un ideale di “educazione dell’intelletto” per formare il gentleman capace di conciliare fede e ragione, un faro necessario per orientare il mondo moderno
Trump verso la Cina. Ecco perché l’incontro con Xi è il cuore del viaggio asiatico
Il viaggio asiatico di Trump, dalla Malesia al Giappone fino alla Corea del Sud, segna il ritorno di Washington come attore centrale nell’Indo-Pacifico. Tra accordi commerciali, diplomazia muscolare e l’atteso incontro con Xi, il presidente punta a ridefinire gli equilibri economici e strategici globali
Dallo “Sputnik moment” cinese al Piano Trump. La nuova corsa globale all’IA guidata dai governi
Dalla sfida di AlphaGo alla strategia cinese sull’IA, fino al piano americano di Trump: l’intelligenza artificiale è il nuovo campo su cui si gioca la leadership globale. Pubblichiamo un estratto del libro “Intelligenza artificiale e competitività – Guida operativa per le imprese” di Stefano da Empoli e Luca Gatto (Egea, 2025)
Argentina al voto. Perché le elezioni sono un test per Milei
Le elezioni di metà mandato in Argentina sono un test per il futuro politico di Javier Milei. Il presidente libertario, eletto nel 2023 affronta il momento più delicato del suo mandato: una crisi valutaria, un governo indebolito da scandali ma conta sul sostegno americano
Suolo, una risorsa da preservare. I risultati del Rapporto Ispra 2024 e la risposta dell’Europa
l Rapporto Ispra conferma la crescita del consumo di suolo, con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ai primi posti. Bruxelles vara la direttiva sul monitoraggio per garantire terreni più sani e politiche di rigenerazione urbana e rurale più efficaci
L’Europa mette all’angolo Putin e Trump lo divide dalla Cina. L'analisi di D'Anna
Mentre il tempo e il crescente assedio dell’occidente giocano a sfavore, la situazione internazionale della Russia si fa sempre più precaria ed il Cremlino non riesce più a recuperare la perdita della credibilità negoziale che aveva in parte ritrovato dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca. L’analisi di Gianfranco D’Anna
Tre anni di politica estera del governo Meloni. Risultati e obiettivi
Dalla nuova relazione con la Cina depurata della zavorra Via della Seta, al protagonismo in Ue e Nato; dalla special relationship con la Casa Bianca e l’Indopacifico, fino al Piano Mattei e alla centralità nella riunificazione balcanica, passando da aree mai battute prima come Asia centrale e America Latina. Che cosa ha fatto il governo Meloni sul piano internazionale