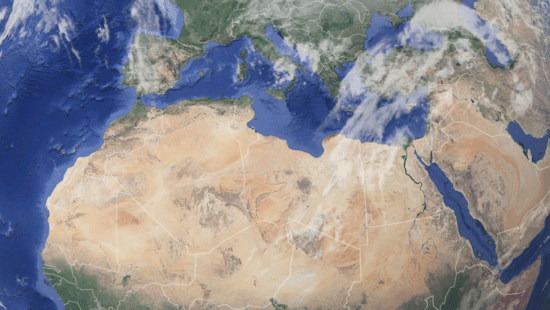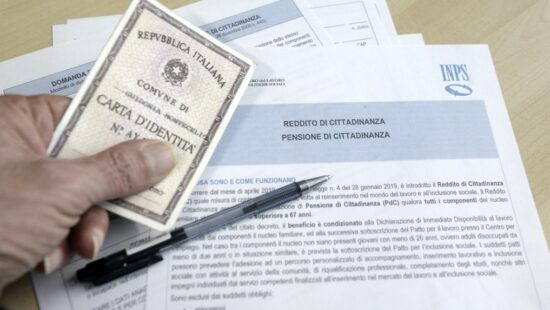La tecnologia è ormai diventata da tempo una componente importante della politica internazionale. Inizialmente i settori coinvolti erano quelli dell’energia, dell’aerospazio e della difesa, soprattutto per la loro importanza per aumentare l’indipendenza economica, politica e militare dei paesi interessati. Ma l’interesse si sta oggi allargando al mondo dell’ICT, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
È sempre più evidente che la vita e lo sviluppo di ogni Paese dipendono dalla possibilità e dalla capacità di utilizzare queste tecnologie. Per i Paesi già sviluppati o con maggiori prospettive di crescita e ambizioni questo significa saperle anche padroneggiare, per lo meno parzialmente, pena la proporzionale perdita di sovranità. Queste tecnologie non coinvolgono solo hardware e software dei sistemi di elaborazione dati, ma anche quello dei sistemi di trasmissione.
Nel campo energetico l’utilizzo delle fonti è strettamente connesso con il trasporto dei prodotti: gasdotti, oleodotti, navi e mezzi terrestri costituiscono quello che nel corpo umano è il sistema di circolazione del sangue che consente di alimentare ogni nostra funzione. Nel campo ICT vale lo stesso principio: cavi, ponti radio, satelliti costituiscono il sistema nervoso che consente il funzionamento di tutto il resto e l’insieme dei centri di elaborazione dei dati sono il cervello che elabora e trasmette gli ordini.
Fuori metafora, un Paese sviluppato che vuole tutelare la sua crescita deve cercare di tutelare le sue imprese ICT sia sostenendole sia proteggendone l’identità nazionale. Per questa ragione la normativa italiana sulla Golden power, introdotta nel 1992 principalmente per il settore della difesa e della sicurezza, è stata successivamente aggiornata soprattutto per il settore ICT.
Il governo ha la possibilità di intervenire anche sui cambiamenti di proprietà delle imprese che svolgono attività strategiche, impedendoli nei casi estremi o fissando delle prescrizioni nei casi più frequenti. Giustamente il nostro sistema di controllo non discrimina gli investitori: a contare è la loro affidabilità e la strategia che perseguono. Quest’ultima valutazione presenta una notevole complessità e richiede un’approfondita conoscenza dei mercati e delle dinamiche industriali.
Più in generale si dovrebbe sempre considerare il ruolo dell’impresa interessata nel quadro della politica internazionale del nostro Paese. Più questa opera sul mercato internazionale e, in particolare, su aree di nostro interesse strategico e maggiore deve essere l’attenzione delle autorità e, se del caso, più forti e stringenti le prescrizioni. Da questo punto di vista non è, quindi, rilevante che l’investitore sia europeo o extra-europeo: fino a quando il processo di integrazione politica europea non avrà fatto significativi passi avanti, sulla bilancia della politica internazionale le implicazioni europee continueranno ad avere un peso minoritario.
Emblematico da questo punto di vista è la recente vicenda di Retelit, società italiana di successo che opera nel campo ICT, in particolare collegamenti in fibra ottica, data center, cloud e cavi sottomarini. È uno dei principali fornitori italiani indipendenti di servizi Wholesale in fibra ottica, con una piattaforma di rete di circa 16.000 km, comprese le reti metropolitane delle prime 14 città italiane. Il 46% della rete in fibra ottica è detenuta attraverso infrastrutture di proprietà (tubi e cavi) e il rimanente attraverso concessioni a lungo termine.
Retelit è proprietaria di 18 Data Center situati in Italia e uno in Austria, oltre a una partecipazione in AAE-1, il cavo sottomarino di 25.000 km che collega l’Europa all’Asia passando per il Medio Oriente. Retelit garantisce la connessione delle basi americane in Italia, in particolare Aviano, Vicenza (Caserma Ederle), Sigonella, Capodichino e Pisa (Camp Darby). Nel 2020 ha realizzato un fatturato di 165 milioni di euro con 600 dipendenti in Italia. La sua capitalizzazione in borsa era ad inizio luglio di 465 milioni di euro. Fra i suoi azionisti, da quindici anni, vi è al 14,4% la LPTIC (Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company), holding del governo libico di partecipazioni tecnologiche.
Retelit e LPTIC hanno, inoltre, costituito a febbraio 2020 RetelitMed s.r.l., partecipata pariteticamente. La società ha come obiettivo quello di sfruttare le competenze congiunte dei due azionisti per contribuire al nuovo grande progetto digitale libico, che prevede la creazione di una nuova rete in fibra ottica, lo sviluppo dell’infrastruttura 5G, l’atterraggio di cavi sottomarini Italia-Libia, cavi terrestri per creare connessioni in fibra con gli altri Paesi africani e un grande data center nazionale. Intende, poi, sviluppare opportunità e sinergie commerciali tra Retelit e LPTIC nel settore lCT, con particolare riferimento ai servizi internazionali nel bacino del Mediterraneo tra Europa, Asia e Africa, facendo leva sulla naturale posizione geografica dell’Italia e della Libia.
I principali progetti in discussione che vedono impegnata RetelitMed sono sei. Primo, interconnessione delle rispettive infrastrutture di rete (a Marsiglia e a Palermo attraverso i cavi sottomarini esistenti) per una piattaforma di erogazione di servizi di connettività per multinazionali fra Europa e Libia. Secondo, consulenza ed ingegneria per la costruzione di un nuovo data center in Libia per la società LTT (Libyan Telecom &Tech), controllata di LPTIC, per erogare servizi cloud al mercato business domestico libico.
Terzo, un nuovo collegamento fra Libia e l’Italia, anche attraverso l’estensione alla Libia di cavi esistenti nel Mediterraneo. Quarto, un ulteriore nuovo cavo sottomarino Libia-Italia attraverso la modalità di project financing con partner statunitensi. Quinto, cablatura in fibra delle principali città libiche e costruzione di un cavo per collegarle. Sesto, infine, costruzione di un cavo in fibra ottica dalla Libia al Mar Rosso, attraverso il confine con il Sudan.
Non vi possono, quindi, esservi dubbi sulla strategicità di Retelit per i nostri interessi nazionali nel Mediterraneo (qui un focus) e, in particolare, in Libia. In quest’ultimo Paese la società si avvantaggia delle sue competenze tecnologiche e del suo radicamento nel mercato locale, ma anche della presenza, da quindici anni, di un socio libico nella sua struttura proprietaria. Considerando che importanti prospettive di sviluppo sono legate alle iniziative di RetelitMed, è evidente che il gruppo potrebbe svolgere un ruolo trainante per il consolidamento del legame fra l’Italia e la Libia, soprattutto nel momento in cui la lunga crisi politico-istituzionale dell’area sarà superata.
Inoltre, l’infrastruttura in fibra ottica che Retelit detiene sul territorio nazionale, unita all‘atterraggio del cavo sottomarino AAE-1, sono elementi chiave per la trasformazione digitale del nostro Paese, come anche confermato dalle recenti linee guida del Pnrr.
Di qui un preciso interesse nazionale a garantire che il gruppo Retelit possa continuare a mantenere un’identità italiana.
Stupisce, di conseguenza, la limitata attenzione posta dal governo sulla progressiva acquisizione del suo controllo da parte di un qualificato investitore spagnolo, il fondo Asterion. Nel dicembre 2020 il suo ingresso nel capitale di Retelit al 28,8%, diventando il primo azionista, è stato autorizzato con alcune limitate e generiche prescrizioni. Ma le stesse sono state confermate a fine luglio anche per l’OPA lanciata a fine maggio sull’intero capitale di Retelit. Sarebbe stato, invece, opportuno un intervento più assertivo, rafforzando le misure speciali già in essere, in particolare per quanto riguarda eventuali successive operazioni di riorganizzazione/ristrutturazione industriale, la governance di Retelit e RetelitMed e l’utilizzo della liquidità generata da Retelit, reindirizzandola a incrementare l’investimento infrastrutturale.
In ogni caso è ora indispensabile che la società venga attentamente monitorata per le attività svolte e per quelle che potranno essere avviate.
Ma sarebbe molto più efficace perseguire l’obiettivo di mantenere l’attuale presenza libica e avere una presenza di “garanzia” italiana nell’assetto proprietario perché consentirebbe di mantenere l’identità nazionale dell’impresa anche e soprattutto nei confronti dei partner mediterranei.
Per puntare a questo obiettivo sarebbe necessario che il ministero dello Sviluppo economico, acquisito il sostegno della presidenza del Consiglio e del ministero degli Affari esteri, individuasse rapidamente un potenziale socio italiano e aprisse un confronto diretto e amichevole con il fondo Asterion per condividere una strategia di rafforzamento del gruppo Retelit. Questa partnership italo-spagnola andrebbe sviluppata a livello industriale e, parallelamente, a livello governativo, inserendosi efficacemente nella nostra politica internazionale verso l’area del Mediterraneo allargato.