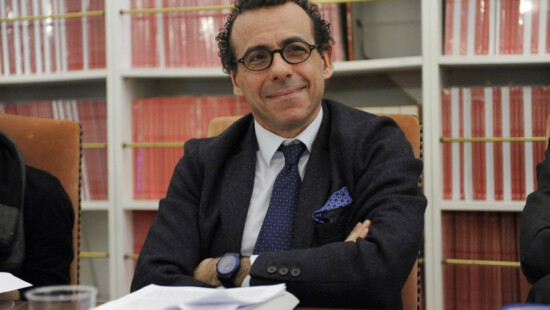Gli Stati Uniti avranno un inviato speciale per la Libia. L’ambasciatore Norland seguirà il dossier per prendere per mano il governo Dabaiba verso le elezioni di dicembre
Archivi
Migranti, in arrivo la tempesta annunciata. Numeri e prospettive
Alla vigilia dell’estate, sugli sbarchi e i naufragi dei migranti, Draghi dovrà dimostrare di contare di più in Europa. Il commento di Marco Zacchera
Cosa è successo in una scuola a Kazan in Russia
11 morti e molti feriti in una sparatoria nella città russa che ha portato all’arresto di un diciassettenne. Tutte le scuole del Paese sono state allertate. A distanza di due giorni dalla parata di Putin del 9 maggio a Mosca, ecco che la Russia viene sconvolta da una vicenda sanguinosa, ancora priva di motivazioni chiare
Se Francesco aiuta l’Islam a riconoscere il valore del pluralismo
Non si può non notare che, pur essendoci forze ostili all’incontro, dopo mesi di evidente lavorio su cosa dovrebbero dire e magari firmare al-Sistani e al-Tayyeb, sauditi e iraniani hanno avviato negoziati attesi da decenni, mentre le guerre divorano milioni di vite. Gli interlocutori di Francesco stanno cercando, grazie al papa, di riportare la fede dalla parte dei credenti e non dei cantori dell’odio
Il Pentagono diventa data-centrico. Ecco il piano targato Kathleen Hicks
La vice segretaria alla Difesa degli Stati Uniti, Kathleen Hicks, ha firmato un memorandum per imprimere un’accelerazione alla riforma del Pentagono sulla gestione dei dati. L’obiettivo è assicurare agli Usa un vantaggio competitivo da diffondere in tutto il dipartimento, “dagli uffici al campo di battaglia”. Riforma in vista per il confronto sui Big data con la Cina
Dal tech al clima, l’amb. Lambrinidis spiega l’alleanza possibile fra Usa e Ue
Intervista a Stavros Lambrinidis, ambasciatore dell’Ue negli Usa, già ministro degli Esteri della Grecia. Con Biden una nuova pagina nei rapporti transatlantici, ora un’alleanza fra democrazie nelle tecnologie critiche, dal 5G all’IA (come sui vaccini). Presto un’accordo Ue-Usa per una tassa sui servizi digitali
Processo, prescrizione e Csm de-politicizzato. Le ricette di Guzzetta
La partita del Recovery, la necessità di un processo con tempi ragionevoli, i criteri di elezione al Csm e Salvini coi radicali. Le necessità della riforma sulla Giustizia secondo l’ordinario di Tor Vergata. “La prescrizione è un criterio di civiltà, non è concepibile che un imputato rimanga in balia dello Stato per sempre”
Informazione e influenza cinese, se l’Italia ha gli occhi bendati
C’è un sistema che definisce continuamente, piccolo passo dopo piccolo passo, la percezione della Cina. Mentre i professori, i ricercatori e i giornalisti nostrani pensano di essere immuni da tale influenza, protetti dalla millenaria cultura accademica italiana, dalla libertà di informazione e dai principi della ricerca scientifica, ogni giorno contribuiscono a creare una pericolosa deriva. Il caso australiano dovrebbe essere d’esempio. L’opinione di Stefano Pelaggi
Lo scandalo Line scuote il Far East. È ancora accettabile delocalizzare servizi digitali?
Dati personali e chat degli utenti di Line (una piattaforma di messaggistica nippo-coreana estremamente diffusa in Estremo Oriente) sono potenzialmente finiti nelle mani delle autorità di sicurezza nazionale cinesi. Che cosa significa? L’analisi di Andrea Monti, professore incaricato di diritto dell’Ordine e della sicurezza pubblica
nell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara
Colonial Pipeline e non solo. Hacker contro i servizi essenziali dello Stato
Attacco contro la rete Colonial Pipeline, l’Fbi punta il dito contro il collettivo hacker DarkSide. Fatih Birol, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia, sottolinea “l’importanza della cyber-resilienza per le forniture energetiche sicure” e denuncia un trend in ascesa. Ecco i precedenti