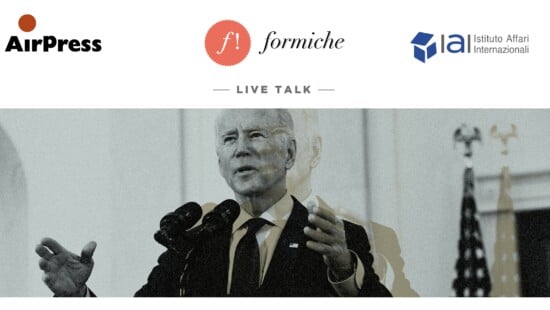L’Italia prosegue con fermezza nella richiesta di una distribuzione dei vaccini anti-Covid più rapida e snella. E maggiore rigore nel rispetto delle promesse fatte dalle case farmaceutiche. Pressing sulla produzione nazionale, accolta anche da Angela Merkel e da Thierry Breton come soluzione auspicabile.
Archivi
La Difesa Usa ai tempi di Joe Biden. Cosa cambia per l'Italia
Le riviste Formiche e Airpress organizzano il live talk dedicato alla Difesa Usa con Joe Biden e ai rapporti con l’Italia. Partecipano Stefano Cont, addetto alla Difesa presso l’ambasciata d’Italia a Washington, e Michele Nones, vice presidente dello Iai. La diretta su questa pagina e su Facebook
Cyber Recovery (modello Israele). Dal Cloud al 5G, tutte le priorità
Il Recovery Fund è l’occasione per importare in Italia il modello israeliano di un Polo 4.0 per la cybersecurity. Un “CyberSpark” che unisca ricerca, governo e settore privato per investire nell’innovazione, dal Cloud al 5G. L’analisi di Andrea Chiappetta, Adjunct Professor – Data, Algoritmi e Identità – Università Niccolò Cusano, e Massimo Ravenna, Head of Cybersecurity – Acea
La rivoluzione dell’idrogeno. Un nuovo modello di sviluppo
È in corso una nuova fase per il nostro pianeta: quella che rende interdipendenti lo sviluppo tecnologico ed economico con la sostenibilità ambientale. In questa “grande trasformazione” dei nuovi modelli di sviluppo che si appoggino a risorse energetiche che promuovano la crescita attraverso l’utilizzo di strumenti in grado di operare in condizioni di equilibrio con l’ecosistema, l’idrogeno assume un ruolo primario
AstroSamantha torna nello Spazio. I dettagli sul nuovo viaggio
Dopo la missione Futura del 2014, AstroSamantha tornerà nello Spazio il prossimo anno. Destinazione: Stazione spaziale internazionale, con un occhio anche alle future missioni lunari. Per Cristoforetti si preparano nuovi record in orbita
Tutti i poteri del ministero della Transizione ecologica. Anche il Mit cambia nome
Il nuovo ministero per la Transizione ecologica (Mite) si occuperà di temi finora riservati ai ministeri dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (cambia nome anche il dicastero guidato da Enrico Giovannini). Cingolani avrà la competenza su energia, idrocarburi, emissioni nei trasporti, economia circolare
L’arte della politica e la sua missione. La riflessione di D'Ambrosio
Il governo ora è quasi completo e in generale sembra con diverse velocità, viste anche le ultime scelte. Per governare ci vogliono limiti di velocità, massimi e minimi, uguali per tutti. E perché la politica sia arte ci vuole un “maestro d’arte” che diriga la bottega e segni il passo, indichi costantemente il progetto da realizzare e abbia il coraggio anche di mandare a casa chi, per motivi nobili o meno nobili, pensa ad altro. La riflessione di Rocco D’Ambrosio, presbitero della diocesi di Bari, ordinario di Filosofia Politica nella facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma
L'invasione delle spac negli Usa. Il perché di un successo inarrestabile
Negli Stati Uniti oggi risiede il grosso delle società che puntano a portare in Borsa le aziende più promettenti. In parte è merito delle start-up della Silicon Valley che si sono sganciate dalle banche d’affari tradizionali per quotarsi. Ma è anche questione di dimensioni, come spiega l’economista Mario Comana
Russia, Turchia e Usa. Da chi passa il destino dell'Armenia
La conferma del premier Pashinyan non è solo nelle sue mani. L’esercito chiede le sue dimissioni e dopo le manifestazioni di piazza, proprio dalla possibile decisione di Mosca di appoggiarlo in toto o meno, potrebbe scaturire un’accelerazione decisiva
Sottomarini e innovazione. La risposta di Fincantieri al Covid-19
Il contratto per due sottomarini di nuova generazione per la Marina militare dà spinta alle previsioni di crescita presentate ieri dal cda di Fincantieri. Sul 2020 il Covid si è fatto sentire, ma il ritorno alla crescita nel 2021 è concreto. A spingere sono il settore militare e il focus sull’innovazione tecnologica, all’insegna della diversificazione