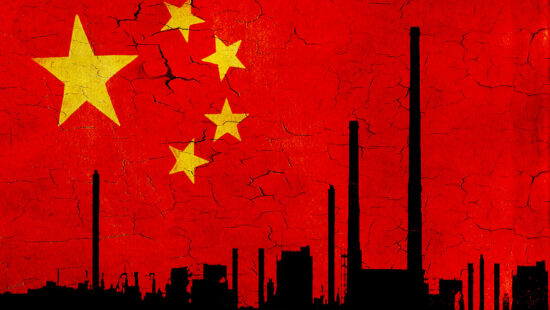La sicurezza nucleare rientra nelle narrative attorno alla guerra, dopo un fine settimana di bombardamenti sulla centrale più importante dell’Ucraina. Mosca e Kiev si accusano a vicenda, Zelensky parla di terrorismo nucleare ed esorta a sanzionare Rosatom, gli invasori russi annunciano un “referendum” di annessione
Archivi
Dopo l'operazione a Gaza cambierà qualcosa tra Israele e mondo arabo?
Secondo Dentice (CeSI), l’operazione israeliana a Gaza contro il Jiahd islamico palestinese non altererà le relazioni tra Israele e parte del mondo arabo. Si tratta di una questione interna, collegata alle dinamiche della Striscia, che tuttavia ha un collegamento regionale: l’Iran, che finanzia il gruppo palestinese
Mire cinesi sul Pnrr. Zonergy sbarca a Milano
Zonergy, società fondata nel 2007 su iniziativa del colosso tecnologico Zte, ha aperto un ufficio a Milano per entrare nel settore europeo delle energie rinnovabili. I dettagli dell’accordo e l’impegno della diplomazia cinese
Battaglia navale permanente. Così Pechino potrebbe isolare Taiwan
Le imponenti esercitazioni militari lanciate da Pechino a seguito della visita a Taiwan della speaker della Camera Nancy Pelosi potrebbero proseguire ancora. Oltre ai timori per una possibile invasione dell’isola, la mossa potrebbe creare una situazione di quasi-embargo per Taipei, il cui spazio aero-marittimo non sarebbe più sicuro per i traffici globali da cui dipende l’economia dell’isola
L’offensive cybersecurity di Stato richiede un quadro normativo organizzato
Con il dl Aiuti anche l’Italia cerca di dotarsi della capacità reattiva ad attacchi informatici. Ma “l’articolo 37” è solo il primo passo. L’analisi di Andrea Monti, professore incaricato di Digital Law nel corso di laurea in Digital Marketing dell’università di Chieti-Pescara
A Franco Gabrielli il Premio Francesco Cossiga per l’Intelligence 2022
La cerimonia, via streaming, si svolgerà il 17 agosto 2022, giorno della scomparsa del Presidente emerito. Il premio dal 2020 viene dato a una personalità che si è particolarmente distinta nella diffusione della cultura dell’intelligence in Italia. La giuria è presideduta da Gianni Letta, affiancato da Giuseppe Cossiga e Mario Caligiuri
Quanti stranieri candideranno le forze politiche italiane?
La questione dell’apporto della componente straniera (e di origine straniera) non è mai stata seriamente considerata a livello politico né sotto il profilo dell’inclusione economica e finanziaria, né della partecipazione sociale e politica e, men che meno, delle pari opportunità. L’analisi di Nadan Petrovic, Università La Sapienza di Roma
Blinken lancia la strategia americana per l’Africa. Anche contro la Cina
La nuova strategia americana per l’Africa cerca di spostare l’attenzione dalla competizione tra potenze e creare partnership più strutturare con i Paesi del continente
Di debito si muore. In Cina riesplode la mina Huarong
La bad bank del Dragone, controllata da Pechino, non riesce più ad assorbire e gestire i crediti inesigibili, esplosi con la crisi del mattone e con il collasso di Evergrande. E non è la sola
I tormenti di Calenda? Nulla rispetto a chi dovrà governare. Scrive Campi
Da Letta che ha l’urgenza di cambiare toni e argomenti di propaganda, a Calenda stesso che ora dovrà capire se correre da solo o con Italia Viva, al centrodestra che guarda la loro campagna elettorale fatta dagli avversari. Tutti i riflessi politici della rottura della coalizione di centrosinistra nell’analisi di Alessandro Campi, politologo e docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia