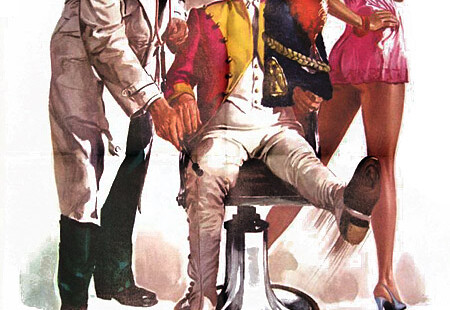Donald Trump evoca la rinascita dell’America dal lockdown anti-epidemia e loda i governatori che stanno riaprendo i loro Stati, allentando o revocando del tutto le restrizioni, ma contestualmente blocca temporaneamente l’immigrazione negli Usa a causa "dell'attacco del nemico invisibile": "Dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro grande Paese", spiega il magnate presidente. Il numero dei contagi negli Usa s’avvia…
Archivi
Venezuela in crisi. E la Russia fa da scudo
Il prezzo del petrolio è ai minimi storici, ma questo non impedisce ai governi di Russia e Venezuela di stringere ancora di più i loro legami, anzi. Il presidente russo, Vladimir Putin, e il leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro, hanno sostenuto una conversazione telefonica per decidere come gestire congiuntamente l’epidemia di coronavirus, e il Cremlino si è impegnato a inviare…
Le cyberminacce al tempo del coronavirus spiegate da Dominioni (Ispi)
Quali sono le ripercussioni sul “quinto dominio”, cioè lo spazio cibernetico, della pandemia di Covid-19? Da dove provengono i rischi? In un’analisi intitolata “La pandemia ed il virus 2.0”, Samuele Dominioni, research fellow dell’Ispi Centre on Cybersecurity, suddivide in tre macro-settori le minacce. GLI ATTACCHI CIBERNETICI Il primo riguarda gli attacchi cibernetici. “Già a partire da inizio febbraio, quando la diffusione…
Perché l'Italia deve aiutare San Marino. L'analisi di Pellicciari
Colpisce l’osservatore di questioni internazionali la quasi totale assenza sui media italiani dell’impatto della pandemia nella Repubblica di San Marino. Un laconico lancio dell’Agi del 3 Aprile comunicava che il micro-Stato detiene il triste primato di paese con “la maggiore percentuale di contagi di Covid-19 al mondo” (sic). Sono beninteso notizie che vanno filtrate (simili rivelazioni statistiche penalizzano i Paesi…
Ecco Andromeda, la costellazione di Argotec per comunicare sulla Luna
Dalla Luna al coronavirus, lo Spazio si conferma un ambiente sempre più determinante per la vita sulla Terra (e oltre). Argotec, azienda aerospaziale di Torino, ha presentato oggi il suo nuovo progetto: Andromeda, una nuova costellazione di nano-satelliti finalizzata a supportare le future attività sul nostro satellite naturale. Se convertita, la stessa tecnologia promette di sostenere anche la lotta al…
Siamo uomini o caporali?
Sai, quando sei chiuso in casa, se non hai altro da fare provi a pensare; magari ripensi a quello che hai avuto modo di pensare un’evo fa, dentro la crisi del 2008: Consumatori, siamo uomini o caporali? Si può essere, insomma, individui che fanno, nella fattispecie militare, i caporali o… si è, tout court, solo caporali? Bando alle ciance, veniamo…
Il rischio della libertà
Non sono rari i casi in cui la cura uccide il malato. Non sempre, lo sappiamo, la libertà possibile è libertà che ci libera; il prezzo di tale possibilità, talvolta, è la negazione della libertà stessa. Ci muoviamo, in questo tempo di fasi confuse nel post (?) coronavirus, tra la necessità di essere liberi e l’impossibilità di esserlo. C’è il…
Mediterraneo bollente. Aerei russi ingaggiano mezzi della US Navy
Un caccia russo ha compiuto una missione di intercettazione aggressiva di un aereo della marina americana sopra le acque del Mediterraneo orientale domenica. Sia Mosca che Washington hanno confermato l'attività. È stata la Sesta flotta degli Stati Uniti, che copre l'Europa sia con unità navali che con le forze aeree connesse, a dichiararlo in una nota domenica. Un SU-35 Flanker "ha volato in modo non…
Israele, intesa Netanyahu-Gantz. E Bibi punta alla presidenza nel 2021
Dopo oltre un anno di stallo e tre tornate elettorali, Israele ha un governo. Di “emergenza nazionale” per affrontare il coronavirus, dicono il premier uscente e confermato Benjamin Netanyahu e il suo ex rivale Benny Gantz: una formulazione pensata per superare gli scontri passati fra i due - basti pensare che Blu e bianco, la formazione guidata dall’ex capo di…
App Immuni di Bending Spoons? Perché serve chiarezza. L’opinione di D’Ubaldo
Le preoccupazioni attorno ai problemi di privacy lasciano sullo sfondo gli interrogativi sulle procedure che hanno condotto alla selezione di “Immuni”, il progetto della Bending Spoons per il tracciamento dei contagi da coranavirus. Come è noto, il governo italiano ha ignorato l’iniziativa - una call urgente con scadenza 20 marzo - della Commissione Innovazione e ricerca dell’Unione europea, presieduta dalla…