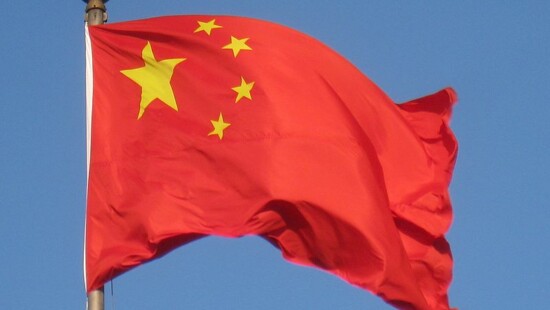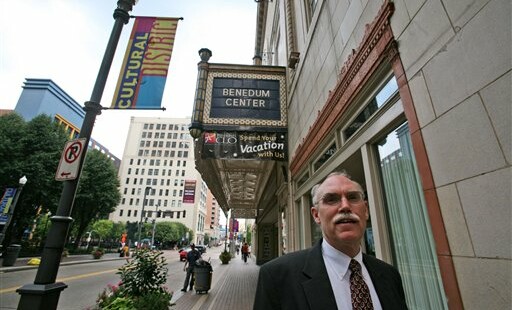Sul commercio è ormai un corpo a corpo a colpi di dazi. Ma sulle operazioni finanziare tra Cina e Stati Uniti è tutt'altra storia. La guerra commerciale non ha fermato Anbang, il gigante assicurativo cinese, messo sotto il controllo del governo di Pechino dopo essere finito a un passo dal crack a causa delle operazioni spericolate del vecchio management, che hanno portato a…
Archivi
F-35, l’Italia prima in Europa a renderli operativi. Le parole di Rosso
L’F-35 è operativo e ciò significa che da ora in poi potrà essere usato nei scenari operativi nei quali la Difesa riterrà opportuno il suo impiego. Ad annunciarlo è stato il capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare, Alberto Rosso, da poco subentrato ad Enzo Vecciarelli alla guida dell’Arma azzurra. L'Italia, come è stato spiegato dalla base di Amendola, sede del…
Perché è importante non lasciare l’Afghanistan. Parola del presidente Trump
Il conflitto in Afghanistan non è finito. Il rischio che i talebani tornino al potere è alto, ed è per questo che la missione Resolute Support della Nato non deve ridurre i propri sforzi. È quanto emerge delle parole del presidente Donald Trump, intervenuto sul tema in un’intervista rilasciata al Washington Post. Il punto del tycoon chiama in causa anche…
Offensive informatiche e fake news, la Germania sotto (cyber) attacco
L'intelligence di Berlino avrebbe rilevato, secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, un nuovo attacco informatico mirato a colpire gli account di posta elettronica di alcuni legislatori tedeschi, delle Forze armate nonché diverse ambasciate tedesche. Dietro l'offensiva ci sarebbe un gruppo di hacker russi noto come Snake, Uroboros o Turla. I PRECEDENTI L'ultimo attacco informatico, al momento oggetto di approfondimento, è…
Marriott, tutti i dettagli sulla maxi violazione di dati
È una delle più imponenti violazioni di dati conosciute quella che ha colpito Marriott, colosso mondiale del settore alberghiero. Il gruppo americano, con sede a Bethesda, nel Maryland, ha dichiarato in una nota di aver subìto una perdurante offensiva informatica che avrebbe messo a rischio negli anni, si stima dal 2014, le informazioni personali di oltre 500 milioni di clienti.…
Perché Trump non incontrerà Putin al G20
Il presidente americano, Donald Trump, non incontrerà il suo omologo Vladimir Putin nell’appuntamento previsto a latere del G20 argentino. L’americano dice che il faccia a faccia non ci sarà per via dell’aggressione russa contro le navi ucraine avvenuta domenica scorsa nel Mar d’Azov — dove la marina russa ha aperto il fuoco contro tre battelli ucraini, che poi ha catturato,…
Professione 007. Al via il nuovo master in Intelligence dell’Università della Calabria
“Fino a qualche anno fa era impensabile un’attività formativa del genere nel nostro Paese”. Con queste parole Marco Gerometta, vice direttore vicario della Scuola di Formazione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ha introdotto la sua lezione all'inaugurazione dell’ottava edizione del master in Intelligence dell’Università della Calabria, i cui lavori sono stati trasmessi da Radio Radicale. LA…
L'arte e la cultura possono risollevare le città. McMahon spiega come
Arti, eventi e finanza possono cambiare volto a comunità e cittadini? Secondo Kevin McMahon, ceo del Pittsburgh cultural trust, sì. Si tratta del responsabile della gestione esecutiva e delle strutture del Trust fondato nel 1984 per promuovere la crescita culturale ed economica del centro di Pittsburgh, attraverso lo sviluppo di un centro di arte e divertimento di quattordici isolati nel…
La Brexit, l'Italia gialloverde e i dubbi sulla manovra. Parla Martin Sorrell
Lo davano per finito, e invece eccolo qua, pronto a reiniziare una seconda vita e a infrangere nuovi record. Sir Martin Sorrell, il guru della pubblicità mondiale, il tycoon britannico che ha fondato il gruppo Wpp plc, la più grande società di advertising al mondo, ci accoglie in una stanza riservata dello studio legale Curtis di Roma. Dalla finestra all’ultimo…
Vi spiego il corto circuito del governo sul Global Compact. Parla De Luca
Sul Global Compact “facciamo come la Svizzera”. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ieri alla Camera che il governo non avrebbe partecipato al summit internazionale di Marrakech sulle migrazioni. “Siamo in campagna elettorale (per le elezioni europee ndr), ovviamente Salvini già da tempo giganteggia su varie prese di posizione e il suo 'sconfinamento' in questo campo…